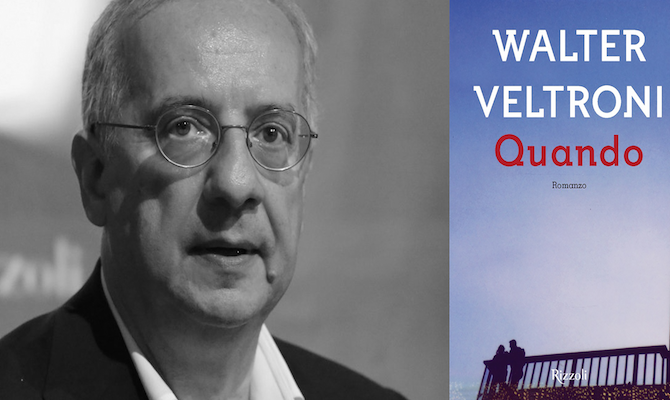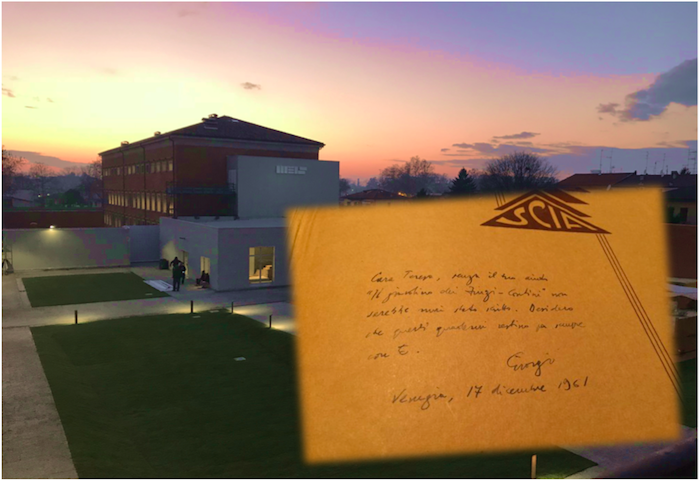IL CACCIATORE DI LEGGENDE
Il reperto
CAPITOLO III – Il reperto
Sewell cercava senza successo di capire cosa i due si dicessero, poi finalmente Juan si voltò verso lo scienziato e gli parlò in un inglese elementare ma privo di incertezze: «Professore, lo stregone ci ha appena ammonito a non proseguire le nostre ricerche. Ha detto che c’è una maledizione su tutti coloro che disturbano la quiete di Alatapec.»
«Alatapec quello delle leggende?» chiese a quel punto Greenstone.
«Esatto, intende dire il dio della montagna. Colui che vive sotto di essa e si nutre delle rocce di cui è fatta!» rispose prontamente il giovane aiutante.

Quelle parole furono musica per le orecchie dello scienziato scozzese, era chiaro che il vecchio alludeva al lithofagus. L’avvertimento aveva peraltro sortito l’effetto contrario e, anziché scoraggiarlo, convinse una volta di più Sewell della bontà delle sue teorie.
Finalmente Sewell era in possesso della prova che le farneticazioni dello sciamano non erano frutto di dicerie locali o di antiche leggende tramandate. Ora sapeva con certezza che l’oggetto della sua ricerca era esistito realmente e forse esisteva ancora: lo attestava il pacco misterioso che Juan gli aveva consegnato la sera prima!
Il pacco conteneva una mandibola intatta di forma assai strana, mai vista prima, chiaramente appartenente a una specie sconosciuta. Era molto larga e massiccia, insolitamente pesante per un reperto fatto di osso, ricordava quasi una grossa scodella, all’interno di essa una serie innumerevole di incavi stava a indicare gli alveoli dentali.
Per Greenstone era tutto fin troppo chiaro. Il reperto osseo presentava curiose analogie con le numerose tracce iconografiche nazca che aveva raccolto nei suoi appunti. Con l’aiuto di Juan era entrato in possesso di ciò che in realtà era una delle tante reliquie di Alatapec, divinità pagana di origine inca.
Ora non restava che mettere a posto l’ultimo tassello: dove era stata trovata la mandibola del lithofagus australis?
L’ostinata reticenza del vecchio sciamano obbligò Greenstone a dover battere altre strade per poter rispondere a quel quesito. Egli sospettava che molti indios della zona sapessero dove trovare quei reperti ossei. Il problema fu che il veto imposto dallo stregone e il timore della maledizione indussero gli indigeni a tenere le bocche cucite, soprattutto nei confronti di stranieri ficcanaso.
Quelli erano luoghi dove le superstizioni e il culto della magia e del soprannaturale avevano radici millenarie assai difficili da estirpare. Oltre a ciò, la diffidenza verso gli europei rendeva quasi impossibile trovare qualche indio disposto a parlare, nemmeno in cambio di ricompense generose.
Jacques Verdoux, informato da Sewell del ritrovamento della mandibola, volle esaminarla immediatamente. Una volta osservata, il francese ne fu entusiasta. Dichiarò che essere entrati in possesso di quell’oggetto avrebbe rappresentato una svolta decisiva per l’intera missione. Propose poi che si poteva tentare di sorvegliare di nascosto gli indigeni che si inoltravano nella giungla e attendere che qualcuno si dirigesse nel luogo dei reperti.
L’idea fu subito scartata da Greenstone. Egli obiettò che attraversare la giungla per seguire la gente del posto non era una cosa semplice, occorreva discrezione e comportava lunghi appostamenti a distanza che avrebbero impegnato il gruppo di esploratori per parecchio tempo, non dando nessuna garanzia di successo. Anzi, nel caso fossero stati scoperti, rischiava di rendere ostili uomini già diffidenti. Era necessario trovare un’altra soluzione, più rapida e meno rischiosa.
Ma proprio mentre i due esploratori discutevano su come risolvere il problema, un tarlo si era insinuato nella mente dello scozzese. A dire il vero il dubbio l’aveva assalito già la sera prima, ma solo in quel momento sentì l’esigenza di esternarlo ai compagni. «Mi chiedo come mai lo stregone si sia privato di una preziosa reliquia in cambio di una semplice lampada a petrolio…» disse.
«Mio caro collega, quello che è semplice per voi può non esserlo per un indio e viceversa.» chiosò frettolosamente il paleontologo.
«Professore, e se per lo sciamano fosse più preziosa la lampada dell’osso che mi ha dato? Io ho visto che nel villaggio tutti indossano qualcosa fatto di osso!» intervenne Juan.

A quel punto anche Pedro sentì l’obbligo di dire la sua: «Señor, io due giorni fa ho visto un uomo tornare al villaggio, era diretto alla casa dello sciamano con un pesante cesto sulle spalle e due torce spente in mano, forse c’è un legame…»
«Hai visto cosa c’era nel cesto?» domandò molto interessato Greenstone.
«No… beh forse, señor credo fossero frammenti di osso, o forse pezzi di rami secchi, non ho visto bene señor…»
«Erano senz’altro pezzi d’osso!» l’interruppe il biologo. «Credo che il nostro stregone non sia affatto un vecchio bacucco come pensavo, credo che sia molto furbo invece. Ascoltatemi bene: il vecchio si serve di un aiutante per procurarsi le reliquie da rivendere o barattare alla gente del villaggio, ora non so se appartengono tutte al lithofagus, la nostra certamente sì, le altre dovrei esaminarle… Comunque se ciò fosse vero, dovremmo concludere che queste reliquie si trovano in un posto buio, probabilmente una grotta. Ecco perché per lo stregone la lampada a petrolio è così preziosa!»
Il ragionamento di Sewell fu subito condiviso da tutto il gruppo. Tutti quanti poi maturarono la convinzione che l’unico posto dove lo stregone poteva procurarsi le reliquie era all’interno delle grotte di Arauna, che si trovavano in fondo alla Gola di Valverde, a una quindicina di miglia a est del villaggio.

Ci si arrivava seguendo un sentiero battuto dai cacciatori, che si inoltrava nella giungla tra le montagne. In prossimità della meta si era obbligati a scendere in una ripida gola nascosta dalla vegetazione, il cui fondo era squarciato da una fitta rete di gallerie scavate nella roccia dall’erosione di un antico fiume sotterraneo, le grotte di Arauna appunto.
Non era esattamente un luogo dove poter fare un picnic: ragni e scorpioni enormi, serpenti tra i più letali, scolopendre di mezzo metro… A parte i giaguari, non ci sono animali feroci nelle Ande amazzoniche, ma tutto ciò che si muove è comunque potenzialmente assai pericoloso, e questo Greenstone, da biologo esperto, lo sapeva bene. Inoltre, anche la vegetazione poteva riservare brutte sorprese agli esploratori incauti: tutta la foresta pullulava di piante velenose, spine acuminate, fiori dai colori splendidi ma intrisi di tossine mortali.
Quella sera stessa Greenstone, Verdoux e i due giovani indios prepararono l’equipaggiamento necessario per l’escursione prevista il giorno seguente. La distanza tra l’accampamento e la Gola di Valverde non era molta ma la natura del percorso era tale che Sewell stimò che il viaggio sarebbe potuto durare tutta la giornata. Per questo decise di portare il necessario per poter trasferire l’accampamento nelle immediate vicinanze della gola. Una volta stabiliti laggiù, anche se provvisoriamente, avrebbero potuto svolgere le loro ricerche senza dover ripercorrere ogni giorno miglia e miglia nella giungla per tornare al villaggio.

La mattina dopo i quattro uomini partirono diretti a Valverde. Il cielo stava schiarendo e una bruma sottile ricopriva il terreno dando l’illusione di camminare immersi in un liquido bianco e impalpabile. Già dopo un’ora di cammino i raggi del sole filtravano attraverso le fronde degli alberi e un caldo opprimente iniziò a rendere il viaggio sempre più arduo.
Il sentiero dei cacciatori non era altro che una linea appena visibile creata a colpi di machete, attrezzo che gli indigeni impiegavano per farsi largo nella fitta vegetazione. Anche i quattro esploratori dovettero usarlo per poter avanzare in quel sottobosco sempre più intricato, e tutto questo contribuiva ad accrescere la fatica. Ognuno di loro poi doveva portarsi un fardello di attrezzature e vettovaglie che rendeva il cammino ancor più massacrante.
Sewell camminava in testa al gruppo, alla sua destra Juan avanzava sferzando con energia il machete per liberare il sentiero ormai quasi cancellato dalle piante che parevano crescere repentinamente ai suoi margini. Il giovane indio, come sempre silenzioso, masticava delle foglie che si era procurato al villaggio. Il ragazzo, vedendosi osservato, si girò, «Professore, ne volete un po’? Servono per la fatica…»
«Che roba è?»
«Sono foglie di coca», rispose Juan, «La gente qua le usa per alleviare la fame, la sete e la stanchezza. Vi fanno stare meglio, prendete…» Il giovane infilò una mano nella bisaccia che portava a tracolla ed estrasse una manciata di foglie verdi, le porse a Greenstone che accettò di buon grado. Pedro, a sua volta, fece altrettanto offrendone un mucchietto al paleontologo francese, il più provato del gruppo.
I quattro, quasi certamente stimolati dalle foglie, aumentarono il passo in direzione est.

A metà pomeriggio, col sole ormai alle spalle, Sewell e compagni giunsero finalmente sul bordo della gola. Fino a quel momento il tragitto era stato estenuante, ma ben presto tutti quanti compresero che la parte più complicata del viaggio sarebbe iniziata solo da lì in poi.
Dal sentiero al fondo della gola c’erano almeno un centinaio dì metri di dislivello da percorrere superando un formidabile intrico di rami e liane, oltre a pietre taglienti che spuntavano dal terreno ripido e in buona parte roccioso. Dall’alto era praticamente impossibile riuscire a vedere cosa li aspettasse giù in fondo, una cortina impenetrabile di fogliame aveva creato una barriera capace di impedire alla luce del sole di passare. Il che voleva dire che quel posto era dominato dal buio anche durante il giorno.
Dette premesse instillarono nel gruppo un vago e inatteso senso d’inquietudine e incertezza, e Greenstone pensò bene di rompere il silenzio per distogliere i compagni dai brutti pensieri.
«Sentite! Ora che siamo qui direi di sistemare tutto quanto per la notte. Ci accamperemo in quella radura là in fondo!»
Indicò un punto della foresta privo di alberi a margine di un crepaccio tra le rocce. Gli altri si rianimarono mettendosi tutti quanti al lavoro.
Il sole era appena scomparso, a quelle latitudini i tramonti sono brevi e il buio arriva presto. La prima cosa da fare era accendere un fuoco e così fecero. Poi finirono di sistemare il bivacco predisponendo le attrezzature per allestire la tenda il giorno seguente.
Juan e Pedro armeggiavano attorno al fuoco per preparare la cena, mentre i due scienziati discutevano su come organizzare le operazioni di discesa nella gola all’alba.
«Jacques, ve la sentite di scendere domani?» chiese Sewell all’amico.
«Ma certo parbleu, sono arrivato sin quaggiù e non me la voglio proprio perdere…» rispose. Gli occhi tradivano la stanchezza, ma quando parlava brillavano di eccitazione. Poi aggiunse: «A mille miglia a ovest da dove siamo ora, Darwin andava nel Pacifico a studiare le tartarughe e voi siete qui a un passo dallo scoprire la creatura più strabiliante che sia mai esistita… Lo so, lo so… Darwin è stato vostro maestro, che Dio l’abbia in gloria, però questa è la volta buona che l’allievo lo supererà. Sono pronto a scommetterci!»
Il tono del francese era entusiasta, era quello di un uomo che stava realizzando il sogno di una vita.
D’altra parte, Charles Darwin era morto due anni prima e Greenstone si trovava negli Appalachi in Nord America quando apprese la triste notizia. Da quel giorno il giovane scienziato scozzese si rammaricava sempre di non aver potuto partecipare ai funerali solenni del vecchio naturalista, cerimonia che si era svolta una mattina di primavera del 1882, nell’abbazia di Westminster a Londra.

Tuttavia, Jacques Verdoux era, suo malgrado, l’anello debole del gruppo…
Ormai prossimo alla sessantina, era uno stimato cattedratico dell’università parigina. Famoso in patria per aver fondato a Parigi il primo museo di storia naturale francese, dopo aver letto un trattato di Greenstone che elencava le sue teorie sull’esistenza del lithofagus, Verdoux, incuriosito, volle incontrarlo personalmente.
Si conobbero in occasione di un congresso svoltosi a Londra nel 1880 e divennero amici. Il paleontologo si appassionò talmente alle ricerche del collega scozzese che ne sposò integralmente la causa, scrivendo diversi articoli a suo favore e organizzando incontri tra lo stesso Greenstone e i suoi colleghi parigini. In cambio ottenne dall’amico una promessa: tutti i reperti trovati che fossero stati in grado di testimoniare l’esistenza del litofago, ed eventualmente il litofago stesso, sarebbero stati esposti nel proprio museo di Parigi.
Ma Verdoux pativa più degli altri i disagi della giungla. Aveva deciso con entusiasmo di unirsi al collega nell’avventura in Perù, ma ora doveva fare i conti con uno stato di salute precario che in quella situazione rischiava di peggiorare ulteriormente. Sewell intuiva le difficoltà dell’amico e si pentì di averlo convinto a partire per il Sud America offrendogli la possibilità di condividere la scoperta insieme a lui.
Otto mesi prima, i due scienziati si erano incontrati a Londra. Greenstone in quell’occasione informò Verdoux della sua imminente partenza per l’America Latina, confidandogli di aver raccolto nelle precedenti spedizioni abbastanza elementi per poter finalmente concludere le sue ricerche con un successo. Occorreva solo un ultimo viaggio. Fu a quel punto che gli chiese se volesse raggiungerlo in Perù per partecipare alla missione, e Jacques Verdoux accettò con gioia e senza esitare un solo istante.
Quella notte un cielo privo di nuvole permise alla luna quasi piena e a migliaia di stelle luccicanti di spandere la loro luce azzurrognola sulla radura attorno all’accampamento. Sewell rimase sveglio a lungo nel suo giaciglio prima di addormentarsi.
Dopo la cena i suoi tre compagni si erano sistemati attorno al fuoco e si erano assopiti quasi subito. Verdoux era caduto in un sonno pesante sopraffatto dalla stanchezza, mentre i due giovani indios giacevano curiosamente seduti poggiando le due schiene l’una contro l’altra, infagottati nei loro pesanti ponchos di lana di alpaca. 
I due dormivano, ma qualunque rumore insolito nel silenzio imperante li avrebbe immediatamente destati. Sewell, osservandoli, ne era sicuro, e si compiacque ancora una volta di averli al suo servizio.
Mille pensieri gli impedirono di prendere sonno quella notte. S’alzò e s’avviò verso il crepaccio distante poche decine di metri, giunto sul bordo della gola iniziò a contemplare l’oscurità che la celava. In qualche modo gli pareva di avvertire la presenza di innumerevoli creature che brulicavano e strisciavano nella voragine sottostante, buia e invisibile. Improvvisamente un rumore di passi lo fece trasalire, si voltò, «Juan… sei tu!»
«Sir Joseph, è pericoloso allontanarsi dal fuoco, quelli del villaggio dicono che questo territorio è zona di caccia del tigre delle montagne…»
«Lo so Juan, ma non sono di certo i giaguari a preoccuparmi stanotte, di solito quei gattoni stanno alla larga dagli uomini. Non sarà così per le creature che troveremo laggiù domani…»
I due rimasero in silenzio, pensierosi. Lo sguardo di entrambi era perso nel nero profondo della gola che incombeva davanti a loro.
Poi Sewell, come per spezzare un’inquietudine opprimente che cominciava a farsi strada nel groviglio di pensieri che lo avevano attanagliato per tutta la sera, tornò al fuoco del bivacco seguito da Juan.
Mentre l’indio si risistemava nell’insolita postura che condivideva con Pedro, Joseph Sewell si adagiò nel suo giaciglio e finalmente si abbandonò anch’egli alla stanchezza.
Dopo nemmeno un minuto il sonno riuscì a vincere ogni residuo pensiero.