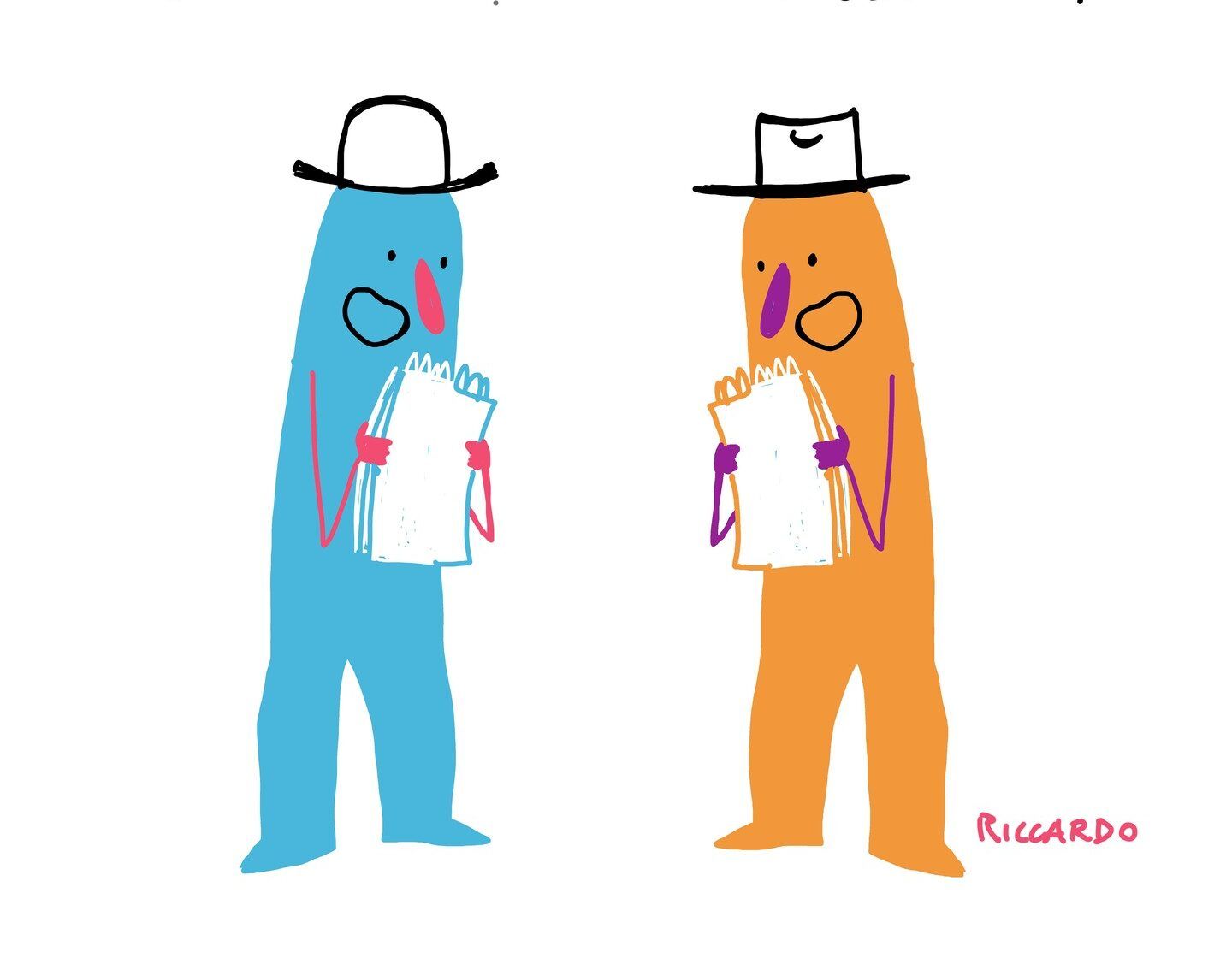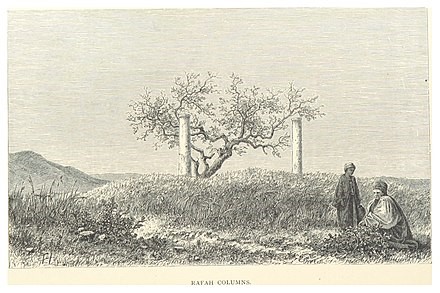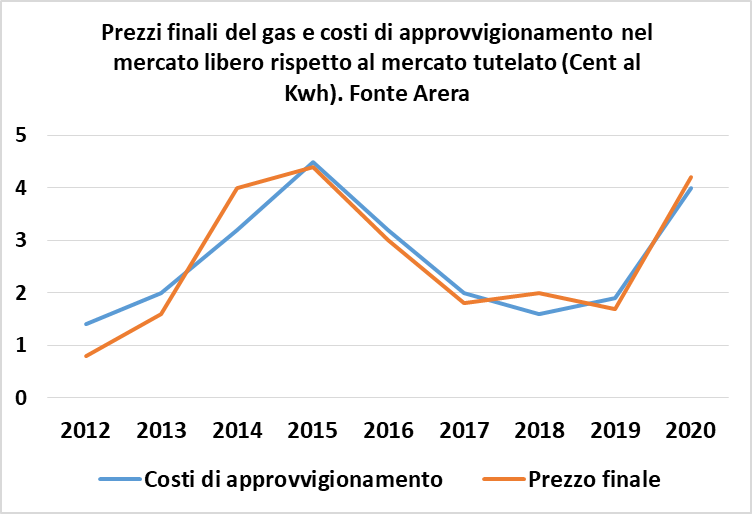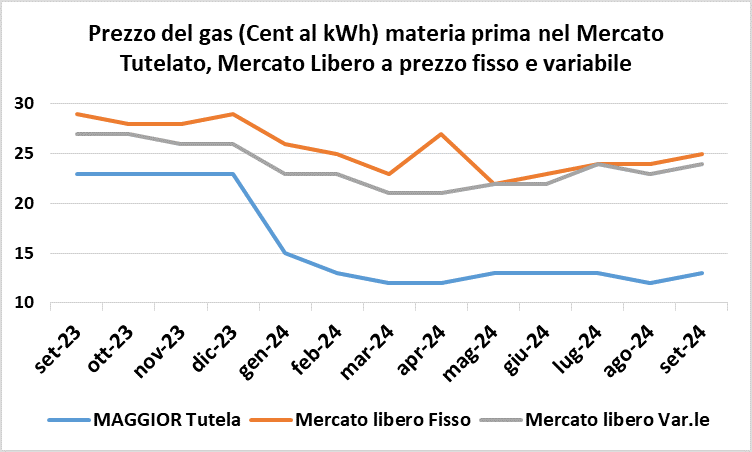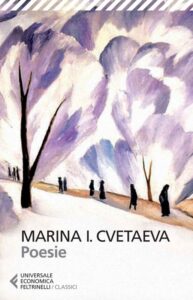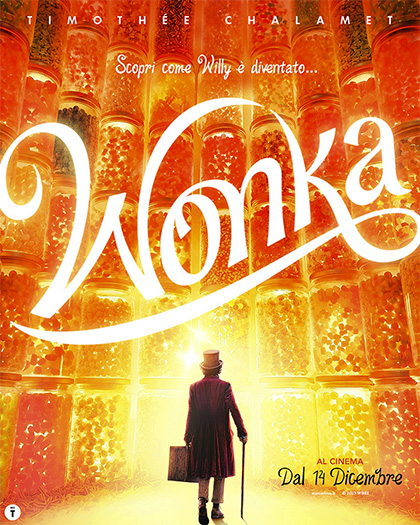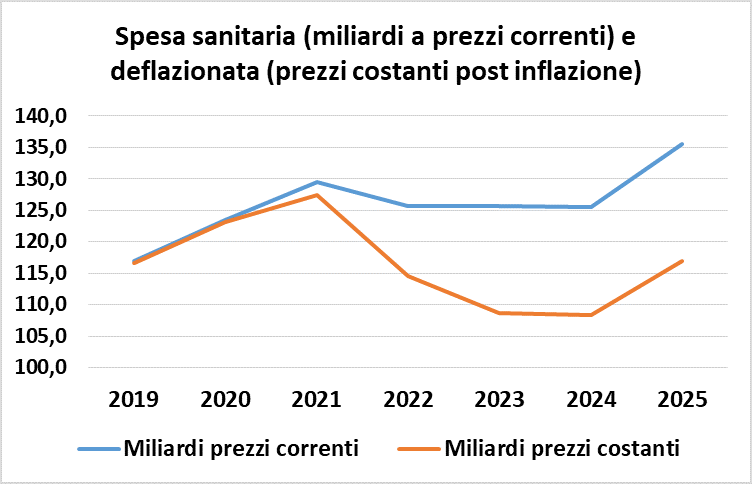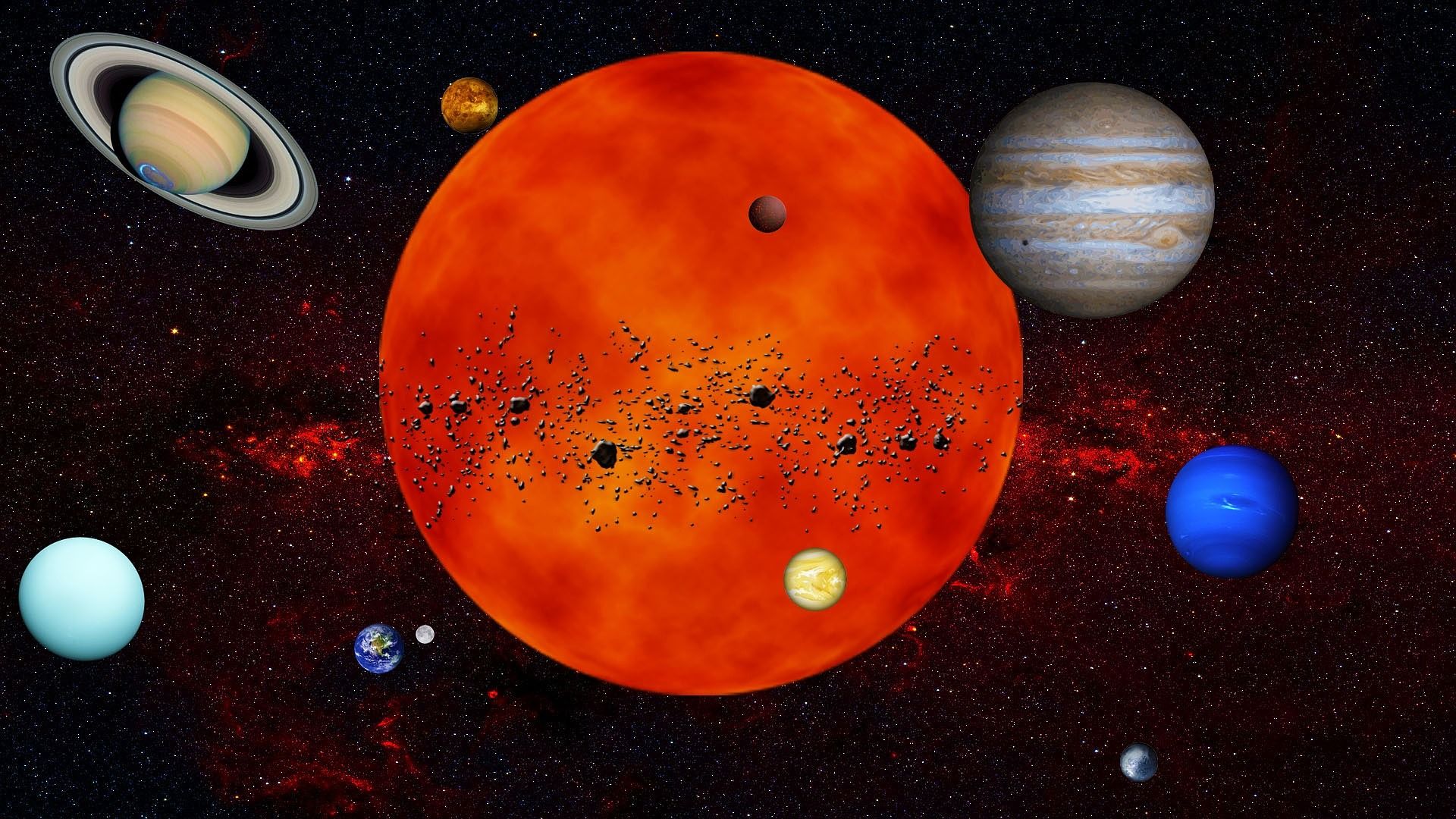Presto di mattina. Nascere è cadere nel tempo
Inizio d’anno
Continuare a scrivere è il mio proposito. Sarà come riprendere un viaggio, senza sapere dove ti porterà e fino a quando. Così lo chiedo come una grazia nel gesto di un affidamento: scrivere come «nascere è un cadere nell’ora». Ho, infatti imparato da Giuseppe Pontiggia che la scrittura è «esplorare ciò che ancora non si sa e portarlo alla luce».
È l’ora del nascere di nuovo. Non è solamente un esercizio di trascrizione delle proprie esperienze o ricordi perché «l’avventura della parola scritta è di riservare sorprese al suo autore. Quando inizia il suo viaggio, che può durare un libro o una pagina, sa il punto di partenza, ma non di arrivo. Il testo glielo rivela e può essere una conoscenza inesauribile».
 Scrivere è incontrare l’inatteso che ti sorprende, e scopri alla fine che il testo scritto ne sa più di te e tu impari cose nuove dalla tua scrittura: «Questo vale, in modo eminente, per il linguaggio poetico e narrativo. Ma vale in misura più circoscritta, ma non meno decisiva, anche per un saggio o un articolo.
Scrivere è incontrare l’inatteso che ti sorprende, e scopri alla fine che il testo scritto ne sa più di te e tu impari cose nuove dalla tua scrittura: «Questo vale, in modo eminente, per il linguaggio poetico e narrativo. Ma vale in misura più circoscritta, ma non meno decisiva, anche per un saggio o un articolo.
Scrivere è inventare – cioè etimologicamente trovare, dal latino invenire – qualcosa che non si sapeva e che il testo svela. Questo è il senso idealmente più importante dello scrivere» (Per scrivere bene imparate a nuotare. Trentasette lezioni di scrittura, Mondadori, Ebook, Milano 2020, 156; 145).
Da non dimenticare in questo viaggio sarà un altro consiglio di Pontiggia sull’uso delle citazioni: «Citare è un’arte difficile. Non è appropriarsi di una espressione, ma farla propria» (L’isola volante, Mondadori, Ebook, Milano 2018, 134).
«La parola poetica semente di Dio»
Continuerò poi ad intrecciare ancora le parole poetiche con la parola di Dio, con il pensiero dei teologi e le istanze della spiritualità cristiana, che pongono a loro fondamento l’ascolto della Parola. Uditore della Parola anch’io ho cercato infatti di fare mia la lectio spirituale del teologo Karl Rahner che ricordava come la poesia appartenga alla stessa essenza dell’uomo.
Per questo «la riflessione dei credenti, non può considerare a priori estraneo nulla di ciò che riempie le ore sublimi dell’uomo, che deve essere ricondotto integralmente a Dio, poiché in fondo in tutti i campi del mondo, per quanto siano differenti, deve maturare l’unica semente di Dio» (La parola della poesia e il cristiano, in Saggi di Spiritualità, Paoline Roma 1965, 231-232).
Di più. «Noi cristiani dobbiamo amare e difendere la poesia, perché dobbiamo difendere l’umano, poiché Dio stesso l’ha assunto nella sua realtà eterna» (ivi, 245).
Per Rahner occorrerà così andare incontro ad ogni poesia «veramente grande con cuore aperto e con semplicità, rispettoso e – forse dolorosamente e pieno di compassione – amante, poiché essa parla dell’uomo… Quanto più profondamente una grande poesia introduce l’uomo nei reconditi abissi della sua esistenza, tanto più lo costringe a fronteggiare autorealizzazioni umane oscure e misteriose, che si nascondono in quella equivocità nella quale l’uomo sostanzialmente non può dire con sicurezza se egli è in grazia o se è perduto» (ivi, 247).
Allevare la parola, portarla verso l’alto, verso il culmine di sé che è il cuore: «Coltivare la poesia è allora coltivare la vita, diventare uditori della parola della vita e viceversa: quando un uomo nel profondo del suo cuore impara ad ascoltare le parole del Vangelo veramente come parola la Dio, data da Dio stesso, allora incomincia a diventare un uomo che non può più essere completamente insensibile ad ogni parola poetica» (ivi, 244).
«Il tempo cuore dell’esistenza»
Così la natività e l’inizio dell’anno sono similmente un cadere nel tempo, luogo di una epifania, il venire alla luce. Nascere è così cadere nel cuore dell’esistenza, che si sottrae a qualunque forma di possesso; il tempo è la nostra unica condizione possibile, caratteristica essenziale della nostra vita.
 Così scrive Abraham Joshua Heschel (1907-1972): «Nella civiltà tecnica, noi consumiamo il tempo per guadagnare lo spazio. Accrescere il nostro potere sullo spazio è il nostro principale obiettivo. Tuttavia, avere di più non significa essere di più: il potere che noi conseguiamo sullo spazio termina bruscamente alla linea di confine del tempo: e il tempo è il cuore dell’esistenza.
Così scrive Abraham Joshua Heschel (1907-1972): «Nella civiltà tecnica, noi consumiamo il tempo per guadagnare lo spazio. Accrescere il nostro potere sullo spazio è il nostro principale obiettivo. Tuttavia, avere di più non significa essere di più: il potere che noi conseguiamo sullo spazio termina bruscamente alla linea di confine del tempo: e il tempo è il cuore dell’esistenza.
Conseguire il controllo dello spazio è certamente uno dei nostri compiti. Il pericolo comincia quando, acquistando potere sullo spazio, rinunciamo a tutte le aspirazioni nell’ambito del tempo. Esiste un regno del tempo in cui la meta non è l’avere ma l’essere, non l’essere in credito ma il dare, non il controllare ma il condividere, non il sottomettere ma l’essere in armonia» (Il Sabato. Il suo significato per l’uomo moderno, Rusconi, Milano 1972, 7).
Che il tempo sia superiore allo spazio lo ha anche ricordato papa Francesco nella sua prima Esortazione apostolica Evangelii Gaudium là dove ricorda: «Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. Il “tempo”, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto…
Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo… Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce» (nn. 222-223).
«Nascere è cadere nel tempo»
Nella raccolta poetica di Marina Cvetaeva, Dopo la Russia e altri versi, (Mondadori, Milano 1988, 39-41 a cura si Serena Vitale), si trova una poesia dal titolo La Sibilla – Al bambino, come a voler profetizzare la Natività del Bambino di Betlemme. A commento di questo testo, l’artista scrive: «Questi versi sono stati tratti dal futuro, per un’intima appartenenza [a esso]».
Al mio petto,
Bambino, aggrappati:
Nascere è cadere nel tempo.
Da stellari rocce di nessun dove,
Bambino mio,
Come sei caduto in basso!
Tu che eri spirito, sei diventato polvere.
Piangi, piccolo, per loro e per noi,
Nascere è cadere nell’ora!
Piangi, piccolo, ancora e ancora:
Nascere è cadere nel sangue,
E nella polvere,
E nel tempo…
Dov’è il bagliore dei suoi prodigi?
Piangi, piccolo: nascere nel peso!
Dov’è la vena delle sue grazie?
Piangi, piccolo: nascere nel conto,
E nel sangue,
E nel sudore…
Ma ti alzerai! Ciò che nel mondo è detto
Morte — è cadere nell’alto.
Ma vedrai! Ciò che nel mondo sono palpebre
Chiuse, è nascere alla luce.
Da oggi —
Per sempre.
La morte, piccolo, non è dormire ma alzarsi,
Non è dormire, ma tornare…
A nuoto, piccolo! Non è rimasto
Che un passo…
— Venire alla luce.
(Per questa traduzione sono ricorso a Lucio Coco, in Osservatore Romano, 23 dicembre 2024, 6).
Scopriamo così in questo testo che nel mistero del tempo il cadere contiene un alzarsi, il nascere per caduta un nascere verso la luce; non solo una discesa rovinosa: un tempo sepolto, ma un’ascensione: “un cadere nell’alto”.
Si proviene da Nessun dove, Stellari rocce sono il non luogo dell’Eterno come l’Assoluto ha la sua epifania nel relativo, così il Senza tempo si rivela nel tempo e nella storia e nel silenzio, partorisce la Parola: «Tu che eri spirito, sei diventato polvere d’uomo».
Il segreto del tempo: vi è un tornare dalla morte, a nuoto, onda dopo onda dove sigillate palpebre si dischiudono alla luce come dopo un sonno.
Il Sempre duraturo/Everlasting è il seme gettato nel tempo, esso contiene insieme potenzialità: un passato, sviluppo: un presente e compimento: un futuro. Il dispiegarsi del tempo è la vita stessa nelle sue possibilità infinite, nei suoi passaggi critici, pesantezza, sudore, pianto e sangue ma poi sei rialzato e ti è detto: «Non è rimasto/ Che un passo…/ — Venire alla luce».
Scrive la Cvetaeva: «Nel mondo io non amo ciò che è profondo ma ciò che è alto», e commenta nell’introduzione al testo Serena Vitale: «Alto e basso, vetta e valle sono le coordinate essenziali della sua geografia dell’assoluto, del suo stesso sistema poetico, modulato lungo un’impervia scala ritmica che mima il processo di catarsi con la fisica, gestuale teatralità dell’intonazione. E la montagna – la vetta – è il luogo da cui risuona la sua voce, che inizia sempre dalla nota più alta, dall’epifania dell’esclamazione, dall’acme del sospiro e dell’urlo, e non consente pause, discese, e incalza il lettore sempre più su, più in alto» (ivi, XVII-XVIII).
«Nascere è cadere nell’ora!»
«Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!” (Gv 12, 27-28). L’oscurità iniziò verso mezzogiorno (l’ora sesta) e si protrasse sino alle tre del pomeriggio (l’ora nona), ora dell’effettiva morte di Gesù: «Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Gesù, dando un forte grido, spirò» (Mc 15, 33; 37).
È difficile per me giunti a questo punto non far corrispondere al testo poetico della Cvetaeva – non giustapposto ma come uno specchiarsi dapprima, un rincorressi poi, l’intrecciarsi infine delle parole le une nelle altre – quelle di un inno poetico/celebrativo a Cristo della chiesa antica fatto proprio dall’apostolo Paolo, incastonato in modo mirabile nella lettera ai Filippesi. Si dispiega dall’alto, preesistenza in un movimento di abbassamento inaudito, dalla condizione di Dio a quella di schiavo e per questo abbassamento egli è stato innalzato, portato in alto e il suo nome sopra di tutti i nomi.
È la storia di Gesù Cristo in poesia: dall’umiliazione all’esaltazione (2,6-11).
L’annientamento e l’umiliazione di Gesù Cristo (2,6-8): caduto nel tempo
L’esaltazione e proclamazione di Gesù Cristo (2,9-11): caduto nell’alto
6 Colui che esisteva di un’esistenza divina
non cercò avidamente di conservare questa uguaglianza con Dio
7 ma alienò se stesso, prendendo esistenza di schiavo,
divenne uguale agli uomini;
e, ritrovato all’esterno come uomo,
8 umiliò se stesso (e) divenne ubbidiente fino alla morte,
fino alla stessa morte di croce.
9 Per questo Dio lo ha anche tanto innalzato
e gli ha donato il nome che (è) sopra ogni nome,
10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio
dei celesti e terreni e subterreni
11 ed ogni lingua confessi: Signore (è) Gesù Cristo,
a gloria di Dio Padre.
(Fil. 2, 6-11)
Questo ritratto cristologico è inserito in un contesto etico. È appello all’unità e unanimità del sentire; è preceduto infatti dall’esortazione di Paolo: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo». Come a dire: si trovi in voi, gli uni per gli altri, lo stesso suo sentire, lo stesso amore, la stessa forma della sua umanità.
Come Cristo Gesù ha preso la nostra umanità, così noi ci rivestiamo della sua e dunque assumiamo il suo stesso criterio di come valutarci nei confronti degli altri: un’umiltà che diventa responsabilità, che pensa all’altro prima che a se stesso. Un sentirsi responsabili al modo con cui Cristo si è reso responsabile di noi fino ad umiliarsi, annichilirsi nella polvere. E per questo è stato rialzato da un Altro ed elevato in alto il suo Nome.
La via delle comete
Iosif Brodskij ha definito Marina Cvetaeva «la voce più tragica di tutta la letteratura russa. La sua poesia è estremamente tragica, non solo nel contenuto – fin qui niente di nuovo, in particolare nella letteratura russa –, ma anche nella lingua, nella prosodia. La sua voce, la sua poesia, ti dà quasi l’idea o la sensazione che la tragedia sia all’interno della lingua stessa (Conversazioni, Adelphi, Milano 2015, [ed digitale 2017], 104) e tuttavia pur nelle sue esperienze drammatiche ha percorso il suo destino sempre cercando la sua via, inseguendo la luce di una stella, la via delle comete, che è la poesia, per esprimere anche oggi il cadere e l’innalzarsi, l’alto e lo sprofondo, il perdersi e il ritrovarsi della nostra condizione umana.
Il Poeta
Da lontano – il poeta prende la parola.
Le parole lo portano – lontano.
Per pianeti, sogni, segni … Per le traverse vie
dell’allusione. Tra il sì e il no il poeta,
anche spiccando il volo da un balcone
trova un appiglio. Giacché il suo
è passo di cometa.
(Dopo la Russia e altri versi, 93).
E con non poca meraviglia ho trovato nascosta tra le sue pagine una benedizione ed una confessione per l’anno appena nato che va a cadere nel tempo.
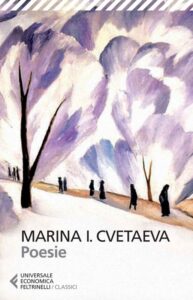 Benedico il lavoro d’ogni giorno,
Benedico il lavoro d’ogni giorno,
benedico il sonno d’ogni notte.
La grazia del Signore e – del Signore il giudizio,
la buona legge e – la legge della pietra.
E la mia porpora polverosa con tanti buchi …
E il polveroso bordone tutto raggi!
Ancora, Signore, benedico – la pace
in casa d’altri e il pane nel forno altrui!
lo sono una pagina per la tua penna.
Tutto ricevo. Sono una pagina bianca.
Io sono la custode del tuo bene:
Io crescerò e lo ridarò centuplicato.
lo sono la campagna, la terra nera.
Tu per me sei il raggio e l’umida pioggia
Tu sei il mio Dio e Signore, e io
sono terra nera e carta bianca.
(Marina Cvetaeva, Poesie, Feltrinelli, UEF, Milano 1992. 79-80)
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.