“La famiglia” di Cesare Pavese.
Una lettura
“La famiglia” di Cesare Pavese. Una lettura
Torino, aprile 1941. Cesare Pavese, tra il giorno uno e il trenta di aprile, scrive il racconto La famiglia. Un mese dopo farà il suo esordio narrativo con il romanzo Paesi tuoi. Cinque anni prima, confinato in Calabria a causa della sua vicinanza ai gruppi antifascisti di Giustizia e Libertà, ha iniziato a tenere un diario, che raccoglie in una cartella verde su cui annota le parole “Il mestiere di vivere”.
Da quasi un anno l’Italia è in guerra, e Pavese è nel pieno del proprio lavoro editoriale: l’adesione al PCI, le riflessioni sulla guerra e i dibattiti politici, la letteratura angloamericana finalmente tradotta in italiano. Presto, assieme a Ernesto de Martino, fonderà la “collana viola” einaudiana, la Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici che porterà in Italia l’opera di Jung e di Kerényi, di Propp e Malinowski, di Frobenius e Frazer.
Sono anni febbrili, anni di grandi narrazioni e studi. Il tuffo nel mito, infine quello nell’abisso.
Pavese riempie il manoscritto di correzioni e cancellature: ma solo dopo la sua morte La famiglia, ritrovata tra le sue carte, verrà pubblicata.
I protagonisti – il trentenne Corrado, l’antica amante Cate, il piccolo Dino, figlio di Cate e forse dello stesso Corrado – rivivranno, anche nei nomi, nei protagonisti de La casa in collina, scritto quasi sette anni dopo e pubblicato da Einaudi nel 1948.
Grandi sono le differenze tra le due opere: La casa in collina è un romanzo ambientato durante la guerra, quando Torino è sotto i bombardamenti e Corrado, rifugiato sulle alture langarole, incontra Cate e Dino in un gruppo di sfollati.
La famiglia invece è una novella, più breve, e si svolge sempre a Torino ma in tempo di pace (la parola guerra vi compare solo una volta, in una lettera in cui Corrado dice la sua inquietudine, e suona come una dichiarazione di poetica: «Mi convinco una volta di più che tutto succede come alla guerra: è indescrivibile»). Diversi nei due testi sono i sentimenti di Corrado verso il bimbo e diverso lo scioglimento, il finale. Ma i tre protagonisti sono gli stessi e molti aspetti combaciano.
La famiglia torna ora alla luce, per la cura di Marta Mariani, grazie alla casa editrice indipendente Divergenze (*).
Nel saggio introduttivo, Mariani evidenzia come i protagonisti de La famiglia «paiono a tutti gli effetti le matrici degli omologhi futuri» de La casa in collina; inoltre, partendo dalla celebre frase di Virginia Woolf per cui solo l’autobiografia è letteratura, rammenta che Davide Lajolo considerò il Corrado de La casa in collina «forse il personaggio nel quale Pavese ha messo più di se stesso, senza preoccupazioni»: poste quindi affinità e differenze tra le due opere, anche La famiglia è portatrice di elementi autobiografici importanti.
Rileva poi la cura maniacale, il lavoro più di incisione che di cesello, che traspare dalle cancellature e dalle varianti del manoscritto, osservando che Pavese «rinuncia a giocare con il colore o con il vocabolario: la sua formula gli impone un limite, una decorosa povertà».
Marta Mariani firma anche il breve saggio Ontologia di un uomo autunnale, che chiude il volume assieme a una nota finale di Lorenzo Campanella – che ha curato l’editing del testo – e a un sorprendente ritratto a carboncino.
Nella parte conclusiva del peritesto vi è l’indagine più specificamente connessa al piano interiore: Mariani pone in luce le risonanze del mito ne La famiglia come nella personale inquietudine di Pavese, fino al luogo in cui «il racconto si fa vera e propria confidenza in forma narrativa, illuminando quel disagio in modo diverso: nell’ossessione dell’uomo-scrittore di incontrare la bestia»: il luogo, anche, di una fragilità maschile innanzi al potere del mito, che rende il testo quanto mai attuale.
Campanella individua, quindi, una postura fondamentale del mondo pavesiano: «Perfino dove paiono uniti da qualche legame, i personaggi soffrono del silenzio rigenerante e feroce della solitudine».
Nell’edizione Divergenze il testo denso ed essenziale de La famiglia è incorniciato da un peritesto che, con densità, offre quanto occorre a inquadrare l’opera sia sul versante testuale sia su quello autoriale, e ad apprezzarne la lettura sul crinale che si snoda tra i due versanti: un crinale quasi indicibile, perché La famiglia è una novella.
E una novella porta sempre in sé un segreto. E infatti, già nel titolo, La famiglia è avvolta da un segreto.
Il rapporto tra testo e paratesto non è mai banale: non sempre ce ne avvediamo subito, ma l’armonia tra un testo e la sua presentazione editoriale – e la cura con cui si è perseguita questa armonia – segneranno la lettura, o le riletture, e il ricordo del contenuto del libro, come un grappolo di suoni armonici.
La cura di Divergenze si manifesta anche nella scelta di materiali inconfondibili: cifra distintiva delle sue edizioni sono l’impaginazione ampia e ariosa, l’uso di un carattere graziato specifico quale il Divergent (variante del Garamond stilizzata ad hoc), la grafica di semplice eleganza, la mano soffice e assieme fragrante di carta e cartoncino di alta qualità anche sotto il profilo ecologico.
Nel caso de La famiglia, a un testo curato con grande rispetto e racchiuso da un apparato esauriente ma essenziale, Divergenze unisce un omaggio: la copertina in cartoncino viola chiaro, opaco, in tinta unita. Il colore che Pavese stesso aveva scelto per le copertine della Collana viola.
(*) Cesare Pavese, La famiglia, a cura di Marta Mariani, Belgioioso, Divergenze, 2024.
Per leggere i contributi di Silvia Tebaldi su Periscopio clicca sul nome dell’autrice




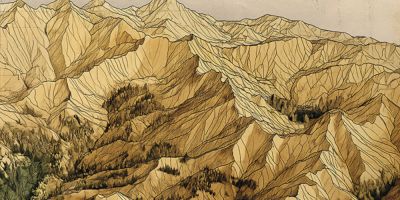







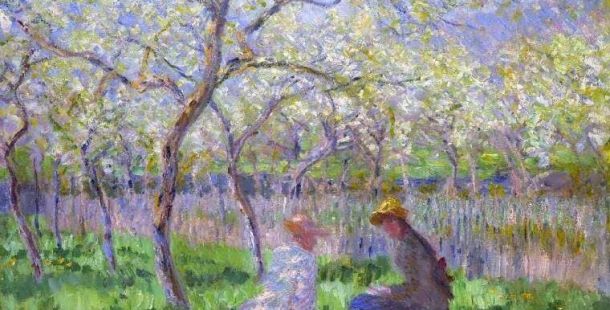



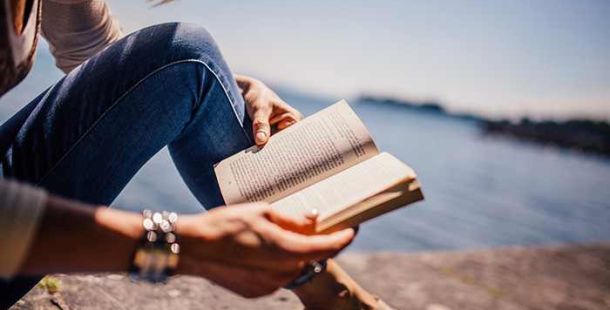

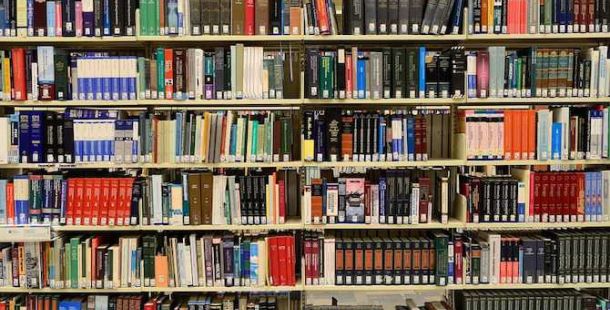
Lascia un commento