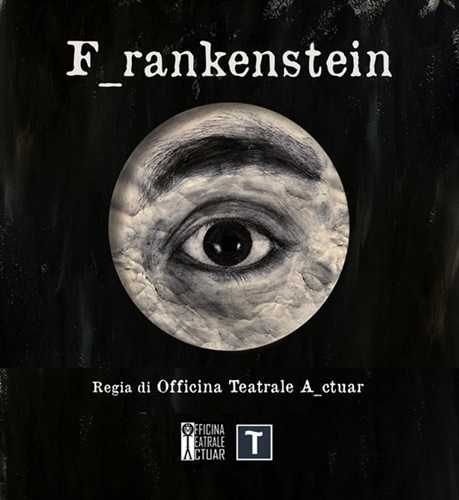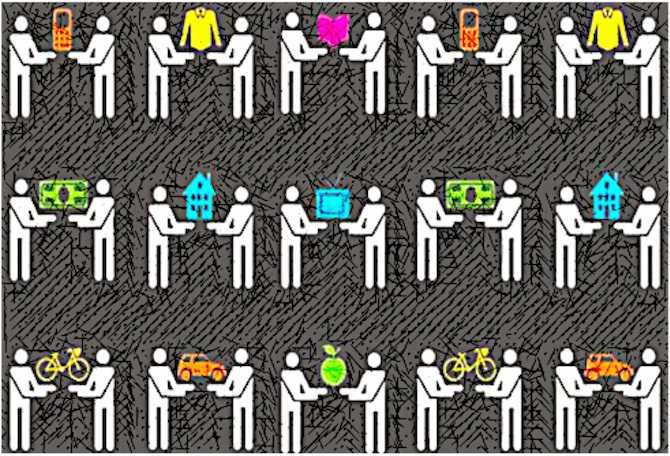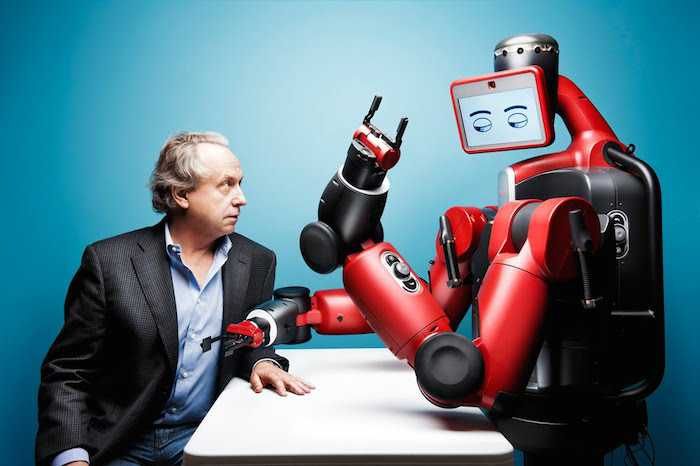LA PROPOSTA
Agenda online, eventi di strada e archivi digitali: idee per una città che crea conoscenza
(Pubblicato il 6 gennaio 2016)
Mappare, informare, mostrare, conservare: ecco una serie di appunti pratici di cose da fare per una città pervasa di stimoli, in grado di generare conoscenza. Scopo: passare da un modello astratto, idealtipico, a un luogo reale, da vivere subito, concretamente. La nostra città, Ferrara, arricchita in poche mosse.
Primo punto: far sapere. Questo è il vero problema, non certo la mancanza di offerta. Eppure si sente dire spesso – a sproposito – che a Ferrara non capita mai niente. Vero magari in ambito imprenditoriale. Ma nulla di più falso se si parla di cultura. A Ferrara si svolge una quantità impressionante di eventi e di iniziative, ogni giorno ci sono occasioni interessanti di incontro e confronto. Pensiamo non solo ai festival o agli appuntamenti ricorrenti, ma a dibattiti, mostre, concerti, proiezioni; ai trecento e passa incontri che si tengono ogni anno in biblioteca e alle quotidiane iniziative organizzate da istituzioni pubbliche e associazioni private. Tanto per dire: nei due weekend compresi fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre in città si sono svolti Unifestival, il Premio Estense, la rassegna di Music Emergency, le conferenze dell’istituto Gramsci sulla democrazia, la mostra sulla Videoarte ai Diamanti, la rassegna gastronomica “L’Europa a Ferrara” e il Ferrara tango festival all’acquedotto, il concerto per Federico Aldrovandi, gli eventi “Iperurbs” di Wunderkammer legati alla valorizzazione del Volano, la mostra “Muse, donne in bicicletta”… E qualcosa certamente dimentichiamo. Ma è solo un esempio.
Il fatto è che spesso le cose non si sanno, forse perché è carente o inappropriata l’informazione e non c’è una corretta e capillare promozione degli eventi. Eppure i giornali e la tv la loro parte la fanno. Listone magazine pubblica persino una comoda agenda degli appuntamenti, gli organizzatori in genere diffondono newsletter a soci e simpatizzanti, ma evidentemente non basta. Perché sono in tanti a lamentarsi che non c’è niente. Salvo poi scoprire in ritardo (e magari rammaricarsi) di avere perso questo o quell’appuntamento.
Ferraraitalia è promotrice di un manifesto-appello per ‘Ferrara città della conoscenza’ che ha già raccolto oltre 140 adesioni [leggi]. Il presupposto è che tutta la vita è apprendimento, l’obiettivo è che la città fondi la propria crescita sul sapere e per questo ne favorisce la ricerca, la creazione, la condivisione, la valutazione, il rinnovo e l’aggiornamento continuo. Di questi temi si è recentemente discusso anche all’interessante ‘world caffè’ organizzato alla Città del ragazzo.
Un buon primo passo sarebbe quello di far conoscere da subito ciò che già si fa, informando capillarmente per favorire la partecipazione. Servirebbe dunque una banca dati condivisa che potesse fungere da luogo di raccolta e distribuzione delle informazioni, in cui ciascun soggetto inserisse i propri eventi e al quale ciascun cittadino potesse accedere: un’agenda digitale online consultabile attraverso il web da qualunque postazione pubblica o privata, attraverso varie chiavi di interrogazione (tema, data, luogo, relatori, organizzatori…). Ci provò una decina d’anni fa la Camera di commercio a mettere in piedi una cosa del genere, ma i tempi probabilmente non erano maturi. Oggi lo sono.
A monte, per quanto possibile, sarebbe opportuno coordinare le attività onde evitare o limitare le sovrapposizioni. In questo senso l’agenda digitale agevolerebbe anche gli organizzatori che, consultandola preventivamente, avrebbero l’opportunità di stabilire giorni e orari in considerazione di quanto già programmato e inserito in banca dati.
Mentre per divulgare l’informazione, oltre a utilizzare i canali pc, tablet, smartphone, auspicabile sarebbe l’uso di tabelloni elettronici connessi alla rete e dislocati in vari punti della città, non solo del centro ma anche dei quartieri esterni e dei principali accessi urbani.
Utile risulterebbe anche una newsletter destinata agli utenti iscritti all’ipotizzato servizio di agenda digitale. Al riguardo, detto per inciso, è incomprensibile che le pubbliche amministrazioni ancora non provvedano ad acquisire un’anagrafe digitale che, accanto ai principali dati sensibili di ciascun cittadino residente (nome e indirizzo), includa anche il recapito mail per la trasmissione di informazioni e documenti digitali.
Nel nostro caso un database del genere sarebbe utilissimo (passo preliminare) per realizzare un censimento dei bisogni formativo-culturali, tracciare una mappatura degli utenti dei servizi, favorire l’aggregazione di comunità web, promuovere forum e confronti tematici, agevolare lo scambio di esperienze, ricevere feedback e richieste, focalizzare tematiche e problemi da approfondire sulla base degli interessi espressi, anche per fornire ad a enti e associazioni elementi di orientamento delle loro attività.
Secondo punto: far vedere. Si può immaginare uno sforzo ulteriore: non solo far sapere, ma mostrare. Ecco, allora, un impegno mirato a ‘portar fuori’ gli eventi, farli uscire dai luoghi chiusi e sfruttare le piazze, i giardini, i parchi pubblici, ossia i luoghi dove le persone si muovono, affinché possano ‘inciampare nel sapere’, trovarlo anche senza cercarlo, imbattercisi anche senza una precisa intenzione. Replicare cioè quel meccanismo trascinante tipico dei festival, quando le città sono invase dalla cultura e dagli spettacoli.
Quello atmosferico è un problema superabile. Parlando della nostra città, si può osservare come Ferrara sia ricca di portici e di luoghi coperti contigui alle piazze, che potrebbero fungere da riparo in caso di condizioni avverse. Qualche esempio? La galleria Matteotti e il portico di San Crispino accanto al Listone. E, sempre nei paraggi, i portici di via Gobetti, tristi a causa dei negozi ormai quasi tutti chiusi: rianimarli non sarebbe male… In fondo a San Romano c’è il chiostro della chiesa sconsacrata che ospita il museo della cattedrale. Sul fronte di Porta Reno la chiesa di San Paolo di portici ne ha due, accessibili da piazzetta Schiatti e dallo sterrato attualmente inutilizzato sotto la torre dei Leuti, all’angolo con via Capo della Volte. E anche davanti alla banca c’è un ampio loggiato.
Ma c’è un piccolo portico anche nella piazza del Municipio e un altro accanto a piazzetta Sant’Anna. E poi ce n’è uno lungo e suggestivo in piazza Ariostea, quello delle suore Stimmatine. E poi in piazza Savonarola e dai giardini del castello. L’elenco potrebbe continuare ed estendersi alla periferia. Questo per dire che immaginare di organizzare eventi all’aperto non è assurdo perché molti spazi sono riparati o vicini a luoghi pubblici coperti, come appunti portici e loggiati.
Fare ‘cultura in piazza’ con continuità per tutto il tempo dell’anno, oltre a garantire visibilità immediata offrirebbe una forte e trascinante sensazione di fervore, di laboratorio sempre attivo, di città che pulsa sapere e conoscenza. Appunto.
Terzo passo: conservare. Infine sarebbe necessario serbare memoria. A vantaggio di chi è interessato ma non ha la possibilità di esserci e magari di chi vuole rivedere e riascoltare, offrire l’opportunità di recuperare i materiali in forma audiovisiva, creando archivi multimediali e banche dati accessibili online che consentano di rivedere e ascoltare. In questo modo si garantisce l’opportunità di un ‘accesso differito’ e si salvaguarda la documentazione di ciò che si è fatto.. Trattenere in un archivio multimediale – accessibile gratuitamente a tutti – reperti audio e video di eventi, incontri, conferenze è un dovere civile.
Non si deve pensare a grandi costi per un’operazione del genere. Tecnicamente la realizzazione non comporta oneri significativi. E prevedibilmente gli organizzatori e gli stessi utenti volentieri potrebbero collaborare, conferendo i loro filmati, le loro immagini fotografiche, le loro registrazioni digitali. Servirebbe principalmente un lavoro di coordinamento e di razionalizzazione. Ma in questo modo si preserverebbe e si renderebbe fruibile nell’interesse di tutti (e senza barriere spazio-temporali) un grande patrimonio che ora va colpevolmente disperso.
Una ‘città della conoscenza’ è ben più delle cose elencate e realizza un progetto per certi versi rivoluzionario. Ma mentre si ragiona dei suoi connotati e si definiscono le linee teoriche di sviluppo è bene anche cominciare concretamente a declinare in azione l’intenzione, traducendo i presupposti astratti in piccole ma significative esperienze.