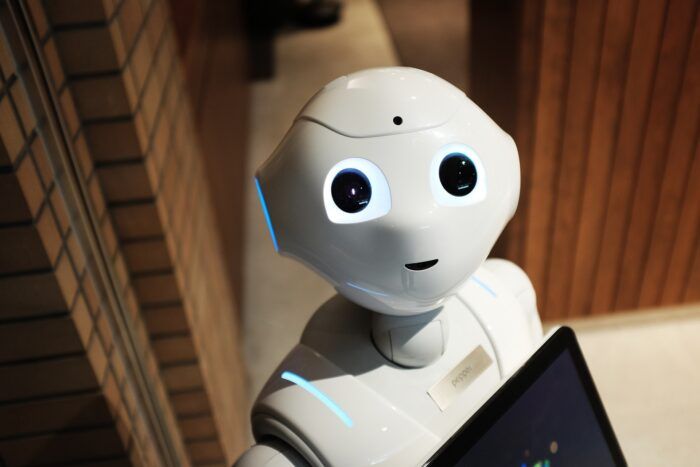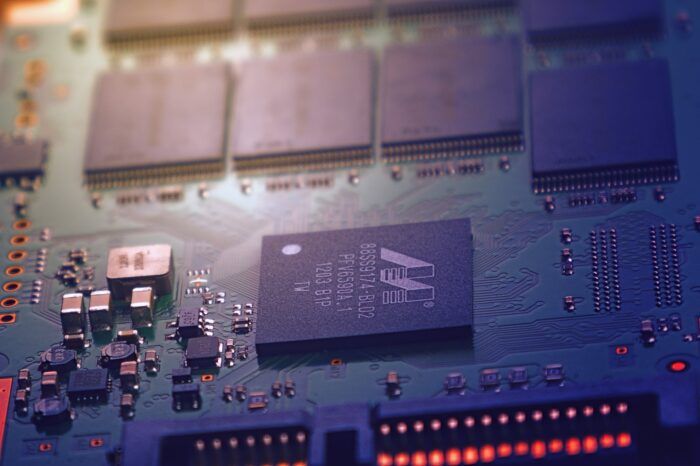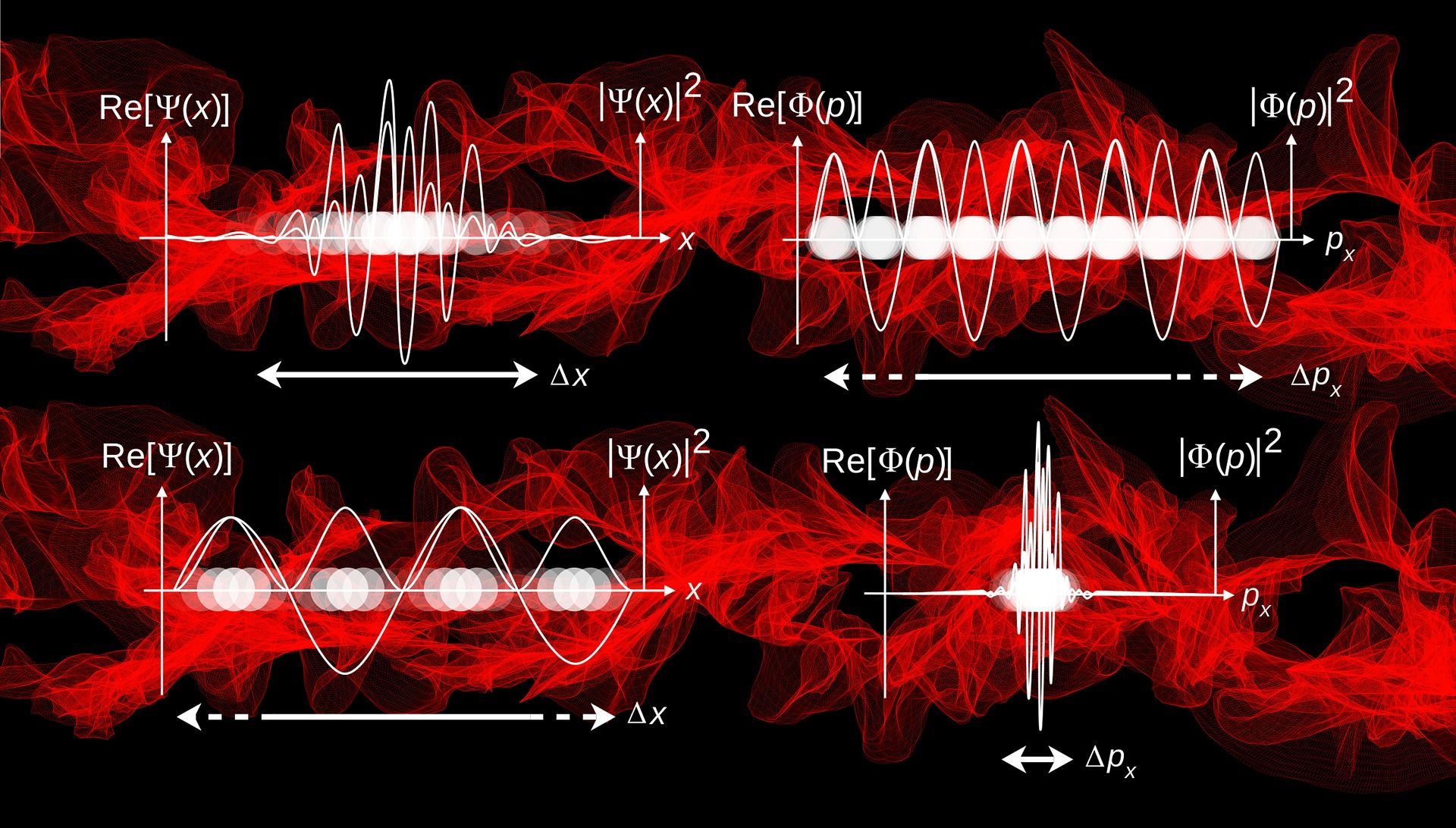É SOLO UN’IDEA IN ALTA MAREA…..
Intervista a Diego Cignitti, in arte Cigno
di Michele Kraisky
ROMA. Abbiamo come ospite un musicista, cantautore e insegnante di una delle scuole di musica più prestigiose d’Italia, il Saint Louis College of Music di Roma, che ospita ogni anno centinaia di nuovi aspiranti musicisti. Il suo nome è Diego Cignitti, in arte ‘Cigno’.
 Un paio di mesi fa è uscito Udine, un singolo accattivante, dalle atmosfere evocative e soffuse. Udine come simbolo, come una città immaginaria, pur se realmente esistente, un luogo in cui la solitudine e la creatività convivono accanto alla vita di sempre. Mondi paralleli, un po’ come le città invisibili di Italo Calvino. Cigno è un under 30, ma nel profondo dell’anima sente di appartenere a generazioni passate come mentalità e mondi musicali, pur esprimendo un sound attuale e apprezzato anche dai più giovani. Ci parlerà del suo singolo, ci esporrà le sue opinioni personali sulla situazione della musica di oggi e delle influenze che più lo hanno segnato. Ci darà anche la sua opinione sulla situazione dei musicisti in questo periodo nero, un periodo in cui accadono fenomeni del tutto nuovi, come la vendita su piattaforme online dei diritti d’autore di grandi artisti – da Dylan a Neil Young in poi -ed altro ancora.
Un paio di mesi fa è uscito Udine, un singolo accattivante, dalle atmosfere evocative e soffuse. Udine come simbolo, come una città immaginaria, pur se realmente esistente, un luogo in cui la solitudine e la creatività convivono accanto alla vita di sempre. Mondi paralleli, un po’ come le città invisibili di Italo Calvino. Cigno è un under 30, ma nel profondo dell’anima sente di appartenere a generazioni passate come mentalità e mondi musicali, pur esprimendo un sound attuale e apprezzato anche dai più giovani. Ci parlerà del suo singolo, ci esporrà le sue opinioni personali sulla situazione della musica di oggi e delle influenze che più lo hanno segnato. Ci darà anche la sua opinione sulla situazione dei musicisti in questo periodo nero, un periodo in cui accadono fenomeni del tutto nuovi, come la vendita su piattaforme online dei diritti d’autore di grandi artisti – da Dylan a Neil Young in poi -ed altro ancora.
M: Buonasera Diego, anzitutto grazie davvero per la tua disponibilità. Dunque, è uscito qualche mese fa, a fine 2020, il tuo singolo Udine. A cosa ti sei ispirato per questo brano? A una canzone, a un evento particolare, oppure altro?
D: Allora…prendo spunto dalla tua domanda: non credo che un brano nasca dal nulla. Esiste un mondo di riferimenti a cui attingo, questo è rapportabile anche alle altre arti che conosciamo e a qualsiasi attività creativa. Sicuramente dentro c’è il mio universo musicale, chiamiamolo ‘Immaginario musicale’; nello specifico le sonorità anni ’80. Che significa dunque ? Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino che si chiama Subiaco e ho l’impressione che nelle piccole cittadine di provincia la moda arriva qualche anno dopo, per cui nei miei anni ’90, che ho vissuto a Subiaco, in realtà erano ancora gli anni ’80 per quanto riguarda i riferimenti musicali ed estetici. Mi viene in mente ad esempio McGyver, che guardavo quando avevo la febbre e non andavo a scuola, la pubblicità della cedrata Tassoni, o la sigla degli Stadio e di Lucio Dalla su Raiuno (ride ndr).
M: Questo singolo ha una sonorità davvero particolare, un misto tra indie, pop, rock e musica psichedelica. Tu che mi dici ?
D: Sì, in realtà non è un genere ben definito, questo probabilmente è un punto a sfavore per la sua comprensione, ma credo che per Udine sia un punto a favore, perché ha una propria personalità ed è originale. Questa dimensione sognante e rarefatta probabilmente la porterò avanti anche nei prossimi brani che usciranno.
M: Pensi che nei prossimi mesi potrai farai dei live? Ne hai qualcuno in programma o in streaming per caso?
D: Beh, sicuramente me lo auguro. I live mancano molto a tutti, sento molti amici che stanno male per questo motivo. Purtroppo questo brutto periodo sta mettendo a dura prova molti lavoratori, e ovviamente non parlo solo del mondo degli artisti. Mi manca molto la parte preparatoria del live, che considero importantissima, e anche la parte più fisica, quando si suda e si vive il palco. Live in streaming per adesso in programma non ne ho, ne ho fatti alcuni precedentemente, ma in realtà questo livestreaming secondo me è solo un palliativo.
M: Pensi che i live in streaming siano una buona soluzione per i musicisti in questo periodo di semi lockdown o comunque di limitazioni? E oltre a questo come pensi che i musicisti possano trovare degli sbocchi nei prossimi mesi o anni?
D: Secondo me sono un palliativo i live in streaming, sono un surrogato…ma detto ciò vanno bene, gli artisti hanno bisogno di espressione, il pubblico di ‘vibes’ positive e soprattutto di buona musica ! Quindi ben vengano per ora. Per quanto riguarda gli sbocchi che avranno i musicisti in futuro con i livestreaming…credo che le cose andranno di pari passo, perché il livestreaming serve e risolverà molti problemi, e contemporaneamente conviveranno sia la dimensione online e quella offline per mandare avanti i progetti dei musicisti.
M: Si parla molto di nuove leggi per garantire un sussidio per i lavoratori dello spettacolo…. Qualcosa sul modello francese, da finanziare con i soldi del Recovery Plan. In ogni caso chi lavora nel mondo del cinema, della musica e del teatro ha subito grossi danni, molti di questi già hanno rinunciato e sono costretti a cercare altri lavori che nulla hanno a che fare con la loro passione e il loro talento.
D: Sì, secondo me questa sarà un’occasione unica ed irripetibile per il riconoscimento del nostro mestiere! Nel Nord Europa i musicisti sono tassati e la situazione è sotto controllo… C’è purtroppo questa brutta consuetudine nel nostro paese nei confronti degli artisti, nel senso che chi non ha una partita Iva o chi non è tracciato per lo Stato è come se non lavorasse, e in questa maniera non ha diritto a sussidi e contributi. Dunque facciamo in modo che il nostro diventi un mestiere riconosciuto proprio come gli altri. Questo è un discorso che in Italia purtroppo va approfondito, perché nei Paesi del nord Europa, dove sono sicuro che la gestione funziona meglio, il musicista è più integrato nella società, di questo sono certo! Se facciamo parte dell’Europa e dall’Europa riceviamo fondi così importanti è bene che ci adeguiamo ai loro standard
M: Vuoi aggiungi qualcosa se vuoi per i nostri lettori e per i tuoi ascoltatori?
D: Mah, aggiungo solo che sono su Instagram (mi trovate come ‘Cigno’) ed è uscita da poco una session proletaria in cui si mescola il blues con i prodotti e la tradizione dell’artigianato. Non aggiungo altro.”
M: Prossimamente uscirà anche un nuovo brano, giusto?É
D: Sì certamente, ma per adesso non ne parlo ancora. Dico solo a chi ha progetti : “Tenete duro e stringete i denti in questo periodo di difficoltà, che alla fine si vedranno i risultati! Ringrazio te e tutti i lettori del vostro giornale che amano la musica!
M: Grazie a te Diego! Ci vediamo presto.