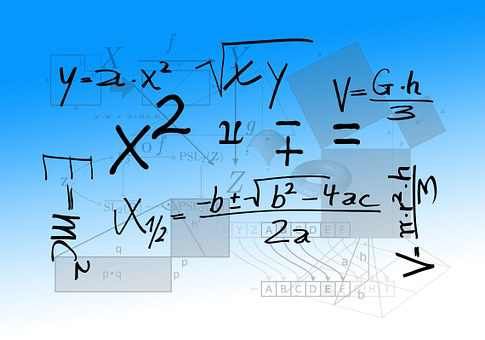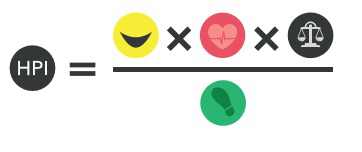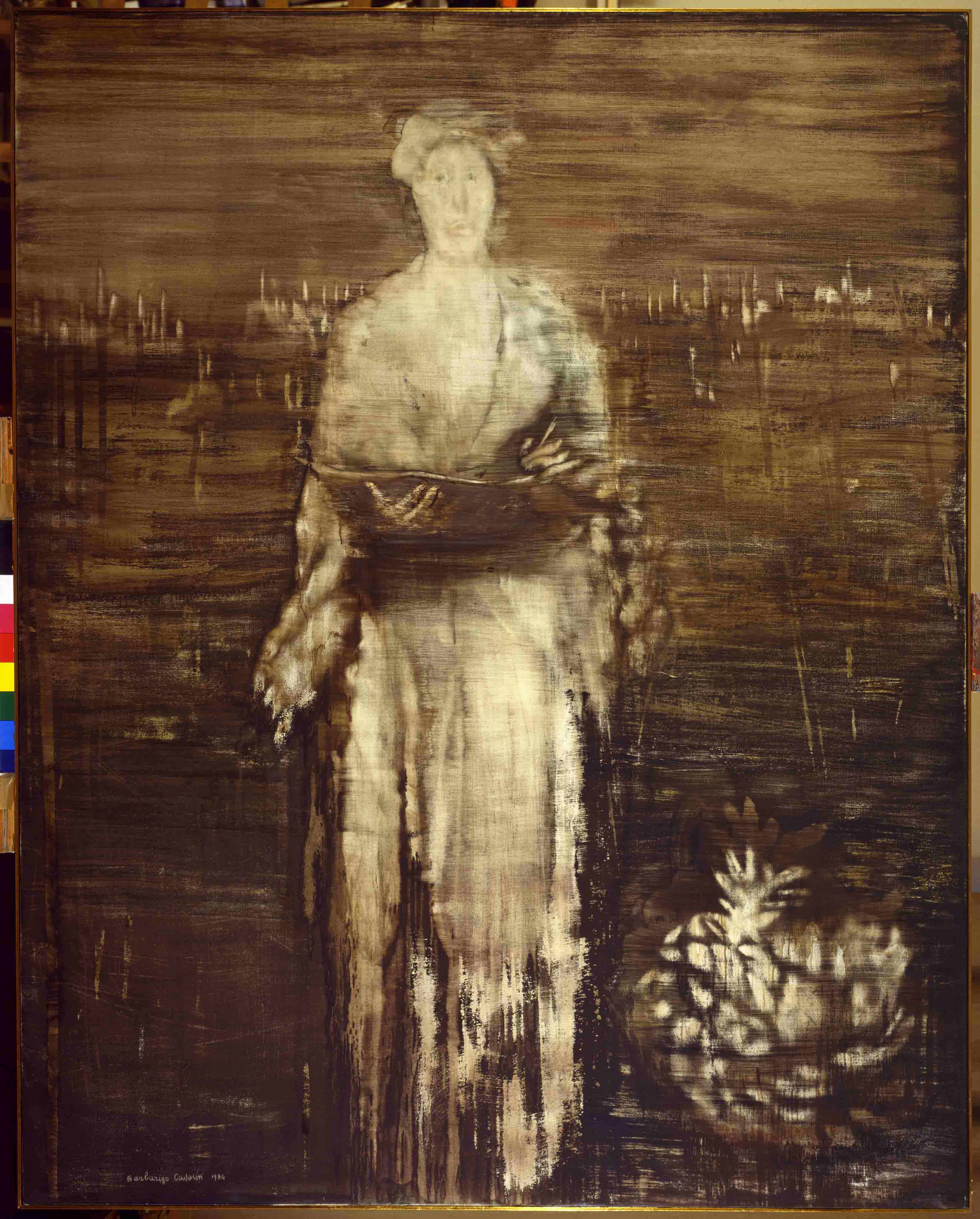Disassociarsi da una setta significa rimanere soli, tagliare i ponti con la famiglia e gli amici. Significa non avere più un passato, rinnegandolo a te stesso o nascondendolo a chi ti è vicino nella tua nuova vita. Significa dover ricordare un bambino che giocava solo nelle scale dei condomini nei quali la mamma era andata a predicare e a cui viene fatto credere che l’isolamento lo preservi dalla contaminazione “delle cattive compagnie” (cioè tutti coloro che sono fuori dalla setta).
Questa è la storia di Emidio Picariello, informatico di professione, e autore del libro “Geova non vuole che mi sposi”, nel quale ha raccontato la sua esperienza di vita all’interno della setta dei Testimoni Di Geova e di come, in seguito ad un lungo percorso di ricerca di sé stesso, se ne sia disassociato.
Cosa significa essere “disassociato”? Cosa comporta a livello sociale e umano?
Dipende molto da quanto presto sei uscito. Sei solo, nessuna delle persone con cui sei cresciuto ti rivolge la parola. Io nel frattempo mi ero coltivato qualche amicizia al di fuori dei testimoni di Geova, avevo praticato un po’ di mondo, quando ero solo “poco spirituale” e non ancora dissociato (tecnicamente non sono stato disassociato, ma me ne sono andato io, ma è un tecnicismo, mi avrebbero buttato fuori comunque). Quindi riparti da zero. Però è anche una occasione. Ti fai gli amici che vuoi, crei i legami che hanno valore. Credo che si dia più importanza alle relazioni, dopo averle perdute tutte. Le famiglie invece reagiscono secondo la loro sensibilità. L’indicazione dei testimoni è quella di isolare il più possibile il disassociato per aiutarlo a capire che è un peccatore e quindi aiutarlo a pentirsi. Poi ognuno interpreta secondo la propria sensibilità. Comunque i rapporti si riducono, nel mio caso i miei genitori non mangiano con me, per esempio. Alcuni non parlano del tutto più con i loro figli, altri sono più aperti. Poi ci sono alcuni disassociati che sono usciti da testimoni di Geova in modo più traumatico di altri, o che comunque trovano giusto o necessario dedicare la propria vita all’antiproselitismo. Io credo che non facciano del bene né a sé, né a coloro che li osservano. L’unica strada possibile è quella di rifarsi una vita. Il che può sembrare un controsenso, detto da me che ne sto scrivendo, ma io credo di essermi ritrovato a parlare di questo un po’ per caso.
Aiutaci a capire: come può essere tratteggiata, al di fuori dei soliti cliché, la figura del Testimone di Geova ligio alla dottrina?
Quello che a volte sfugge è la pervasività dell’essere testimone di Geova. Non vuol dire semplicemente andare in giro a predicare ogni tanto, ma vuol dire avere uno stile di vita preciso con un sacco di regole sull’abbigliamento, sull’alimentazione, sulla salute (in questi due casi è una sola regola: niente sangue). Insomma essere testimoni di Geova non vuol dire essere cattolici, è più raro che ci siano sfumature. I testimoni di Geova non praticanti di fatto non sono testimoni di Geova.
Si tratta di una setta chiusa? Come sono regolati i rapporti con chi ha una fede diversa?
Credo che sulla chiusura non ci sia timore di smentita. Le pubblicazioni dei testimoni di Geova parlano chiaramente di come le cattive compagnie corrompano le utili abitudini. Mio padre mi diceva sempre che le cattive compagnie sono quelle che non hanno le tue stesse utili abitudini, come predicare o andare in sala del Regno. Dopodiché io avevo una amichetta che abitava nel mio palazzo e l’ho frequentata fino alla preadolescenza, ma è stata l’unica eccezione: niente pomeriggi di gioco dai compagni di scuola, niente feste con gli amici non testimoni, niente di tutto questo. Restavamo spesso fra noi, il sabato e la domenica, con altri testimoni di Geova. Poi le attività di predicazione e adunanze assorbivano molto del nostro tempo. Per il resto la dottrina è chiara: viviamo nel mondo ma non facciamo parte del mondo, dicono.
Ho letto che non sono ammessi i rapporti pre matrimoniali, men che meno l’omosessualità: come reagisce la comunità quando si viene a scoprire che una persona che fa parte della comunità “ha peccato”?
Se a scoprirlo è un membro della comunità, va dal peccatore e gli chiede di confessarsi agli “anziani” della congregazione. Se il peccatore non lo fa allora sarà chi l’ha scoperto a fare da delatore. A quel punto c’è un “comitato giudiziario” durante il quale vengono chiesti i particolari del peccato. La cosa può essere molto imbarazzante, se si pensa che gli anziani sono tutti uomini e casomai il peccatore è una ragazza giovane costretta a raccontare nel dettaglio le proprie prime esperienze. Se c’è pentimento, ci saranno soltanto delle sanzioni (il fatto di non poter rispondere pubblicamente alle domande che vengono fatte alle adunanze, il fatto di essere “segnato” e quindi di non potere essere frequentato a scopo di svago, ma solo a scopo spirituale, per esempio). Se non c’è pentimento si viene disassociati. La disassociazione comporta che nessuno ti può più rivolgere la parola. Se decidi di provare a farti riassociare devi andare in sala del regno e sederti nelle sedie in fondo, entrare quando è cominciata, non parlare con nessuno, uscire prima che finisca, fino alla riassociazione che arriva al più presto dopo sei mesi di questo comportamento. L’omosessualità è peccato. L’omosessuale deve praticare la castità, se vuole essere testimone di Geova. Credo che nessun commento si possa aggiungere a questo articolo dal loro sito ufficiale. https://www.jw.org/it/pubblicazioni/riviste/g201012/spiegare-punto-di-vista-bibbia-omosessualit%C3%A0/
Quanto la tua educazione è stata influenzata dall’appartenenza a questa setta? Immagino il non poter partecipare banalmente alla festa di compleanno di un compagno di scuola…
Molto, nel male ma anche nel bene. Ho molto sofferto l’isolamento e la difesa della sospensione dell’incredulità – quella cosa che il lettore prova mentre legge un romanzo, e che invece il testimone di Geova abita quotidianamente. Essere un bambino che crede così fermamente nel fatto che il diluvio sia un avvenimento storico e al contempo che non partecipa a qualunque cosa abbia a che fare con Natale, Compleanni e feste di qualunque tipo, non è facile. Dall’altra parte credo di dovere parte del mio eloquio fluente e della mia faccia tosta agli anni passati a prepararmi per la predicazione e predicando.
Sei nato da dei genitori Testimoni di Geova o si sono convertiti in età adulta?
Mio padre è diventato testimone di Geova intorno all’adolescenza, periodo durante il quale stava cercando una sua dimensione religiosa, esplorando soprattutto le varie religioni protestanti. In questa sua ricerca si è imbattuto, se non fra i primissimi, sicuramente fra i primi in Italia, nei testimoni di Geova arrivati dagli Stati Uniti e l’hanno in qualche modo conquistato. Lui ha poi convertito tutta la sua famiglia. Mia madre invece fu contattata in predicazione da quella che sarebbe poi diventata sua suocera. Quindi possiamo dire che quando sono nato io tutta la mia famiglia era ben strutturata all’interno dei testimoni di Geova.
Mi racconti aneddoto o ricordo di te bambino…
Il mio principale parco giochi erano le scale dei palazzi dove mia madre predicava. Certo, ogni tanto scendevo anche in giardino con gli altri bambini del palazzo, ma prevalentemente passavo i pomeriggi con mia madre e un’altra testimone di Geova e predicavamo. Loro predicavano, io facevo lo scivolo sulle scale, prendevo a calci i sassi, giocavo con quel che avevo.
Hai mai fatto proselitismo? Qualche aneddoto?
Quando ho finito la seconda media ero già un testimone di Geova battezzato, così decisi che volevo diventare un pioniere regolare. Era una cosa piuttosto atipica per un bambino della mia età, perché consisteva nell’impegnarsi a predicare 3 ore al giorno per tutto l’anno. L’ho fatto per 5 anni, fino alla 4 superiore compresa. Quindi ho molto tentato di fare proseliti, ma non ci sono riuscito. Paradossalmente la cosa più vicina al proselitismo l’ho fatta involontariamente anni dopo, dopo l’uscita del libro, quando una ragazza che voleva uscire dai testimoni di Geova mi ha contattato. Voleva sapere se era possibile essere normali, dopotutto. Mi sono limitato a spiegarle che sì, l’alternativa a essere testimone di Geova può essere semplicemente non esserlo e non è automatico diventare un loro detrattore strampalato e dedicato ad attaccarli. Ce ne sono, però, e ai testimoni di Geova fanno credere che l’unica alternativa a essere testimone è quella.
Come si coniuga il far parte dei Testimoni di Geova e far parte della società attuale?
È soggettivo. Ci sono persone che dedicano tutta la vita ai testimoni di Geova e lì concentrano tutte le loro possibilità di carriera e tutti i loro interessi. Queste non hanno davvero nessun contatto con l’esterno. Poi ci sono persone un po’ più moderate. Le prime fanno carriera nei testimoni, le altre meno. In generale se frequenti non testimoni di Geova tendenzialmente non lo sbandieri ai quattro venti. Se no sei “poco spirituale” e quelli poco spirituali mal si integrano con quelli “più spirituali”. Quelli “più spirituali” aiutano quelli che lo sono meno. Le dinamiche all’interno di un gruppo chiuso come quello della “congregazione” sono da manuale di psicologia sociale.
Come è il rapporto tra Testimoni di Geova e il “potere” /carriera nella nostra società?
Credo che sia già emerso da quello che si è detto fin qui. I testimoni di Geova sono carrieristi come tutti, chi più, chi meno. Solo che trovano sfogo per le loro ambizioni all’interno dell’organizzazione. Personalmente ho conosciuto pochissime persone che avessero un ruolo di rilievo nella società esterna.
Come e quando è giunta la crisi? Immagino sia un processo lungo e laborioso…C’è stato un episodio scatenante?
La crisi è un processo lungo. Non per sempre l’incredulità può essere sospesa. Poi è come una crepa, se metti in discussione qualcosa cominci a mettere in discussione tutto, non puoi scegliere a cosa credere. L’episodio scatenante per quel che mi riguarda – e per molti che sono usciti nella post adolescenza o in quel periodo hanno cominciato il processo – è stato il sesso. Ho trovato una ragazza, sempre testimone, ma che non era particolarmente ligia alle regole. Poi ci sono stati ripensamenti, passi indietro, passi avanti. C’è però un momento in cui ho detto: sì, è difficile, ma io non ci credo. A quel punto il processo è irreversibile. Se hai pensato una volta sola, a voce alta “ma io non ci credo” ormai devi solo trovare la tua strada per uscirne.
Ci sono delle aperture dottrinali rispetto all’attuale evoluzione sociale?
Non credo. Vedo una certa riduzione di impegno, le adunanze sono diventate due giorni a settimana, dai tre che erano, Quando ero bambino le assemblee estive duravano 1 settimana, poi 4 giorni, adesso credo 3. C’erano sessioni serali, adesso durano poche ore al giorno. I pionieri regolari facevano 90 ore al mese, ora credo ne facciano una settantina. Da un punto di vista dottrinale invece non credo sia proprio cambiato niente. Cioè, ci sono variazioni sull’attesa della fine, del resto quando ero bambino dicevano che sarebbe venuta prima che le persone nate nel 1914 fossero diventate vecchie. Ora che sono tutte morte – o quasi – diventa difficile difendere quella posizione, ma hanno trovato qualche escamotage logico-linguistico per allungare la “generazione” del 1914. Però da un punto di vista di regole di comportamento le cose non cambiano mai.
Geova non vuole che ti sposi…anche tua mamma continua ad opporsi?
Ormai mi sono sposato e ho fatto due figli, mi sa che qualunque opposizione non sia più praticabile. Ovviamente quello era solo un titolo di un blog e poi di un libro, una estrema sintesi: più che altro i miei mi avrebbero voluto testimone di Geova, ma io non lo sono e non lo ero quando mi sono sposato, così nessuno dei miei parenti testimoni è venuto al mio matrimonio. Per un periodo mia madre ha sperato di poter convertire mia moglie, credo che adesso abbia capito che anche quella strada è impraticabile. Per loro se non sei testimone di Geova stai male, alla fine il paradosso è che non avere nessun contatto con te, lo considerano un segno di affetto. Dopotutto ho fatto finta per anni di non essere mai stato testimone di Geova, di non averci niente a che fare. Ma poi con il matrimonio, il fatto che i miei non sarebbero venuti ha riaperto vecchie ferite e soprattutto mi ha costretto a un fatto pratico: dovevo spiegare ai miei nuovi parenti che cosa stava succedendo. Solo per questo ho aperto il blog (www.ildisassociato.net), perché a quel punto era necessario raccontare tutta la storia.
E’ uscito da poco nelle sale “ragazza del mondo” che racconta la vicenda di una ragazza che , come te, ha deciso di lasciare la comunità di Geova. Cosa ne pensi?
Come si dice in questi casi ho un piccolo conflitto di interessi: ho fatto una consulenza per loro. Volevano accertarsi che nella sceneggiatura non ci fosse nessun errore marchiano. Quando ho visto il film avevo un po’ paura che non fossero riusciti a restituire il clima, la parte emotiva, lo spirito. Invece devo dire che sono rimasto davvero piacevolmente sorpreso, tutto è estremamente accurato. Sicuramente se volete sapere qualcosa in più su come funzionano davvero i testimoni di Geova, andare a vederlo può essere una buona idea.