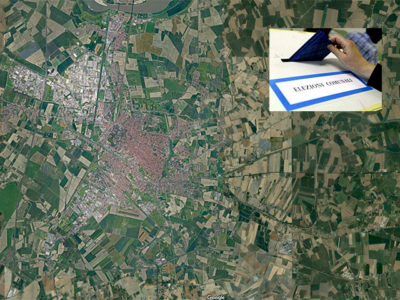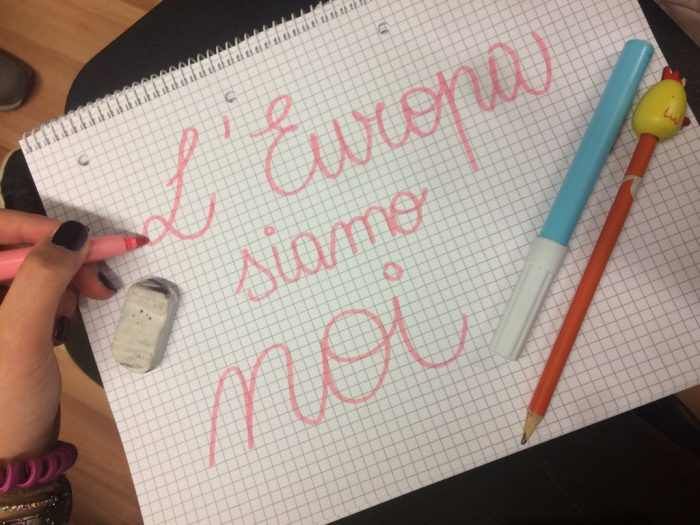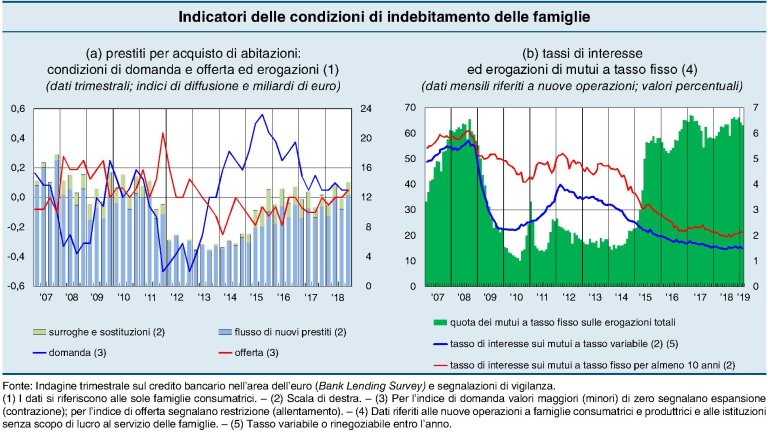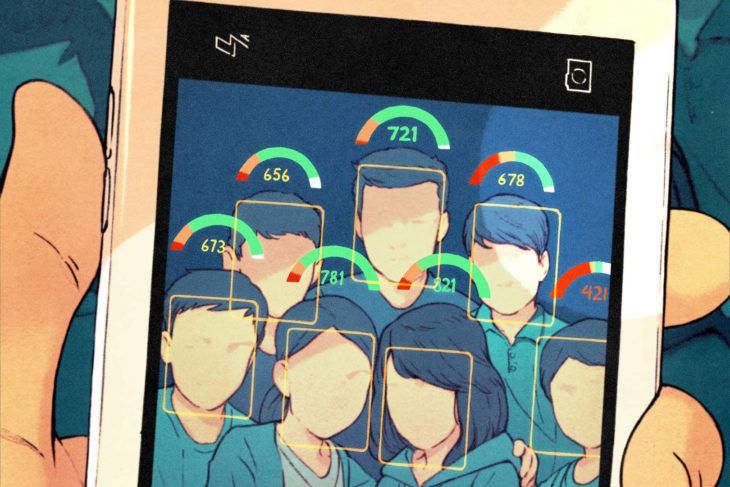A cura di Sergio Gessi e Francesco Monini
– prima parte –
Abbiamo invitato nella redazione di Ferraraitalia i candidati a sindaco del centrosinistra per rivolgere loro alcune domande. Andrea Firrincieli, Roberta Fusari e Aldo Modonesi hanno gentilmente accolto l’invito. Solo Alberto Bova ha declinato l‘invito, ritenendosi equidistante tra i due schieramenti in campo a Ferrara.
SERGIO GESSI
Vi ringraziamo per la disponibilità a questo confronto. Il dibattito elettorale è vivo e siamo ormai alle ultime battute, ci è parso opportuno e necessario sollecitare alcune riflessioni mirate su punti che consideriamo rilevanti, in modo da fornire agli elettori alcune risposte più precise e concrete, al di là dei valori e delle idee che stanno alla base dei programmi che ciascuno di voi ha elaborato.
FRANCESCO MONINI
La prima domanda che vi farei è questa. Il dibattito impostato dalla destra e da Alan Fabbri si è concentrato sul tema della sicurezza. Quali sono le tre priorità per Ferrara che vi sentite di indicare? Convenite che la sicurezza sia il problema fondamentale, il più sentito dai cittadini, oppure se ci sono temi più importanti, più decisivi su cui puntare, su cui porre l’attenzione?
Infine: tutti dicono che, per la prima volta, il governo di Ferrara è ‘contendibile’, e potrebbe toccare alla destra? Che ne pensate?
ROBERTA FUSARI
Le mie priorità: 1) Ambiente che vuol dire anche Salute; 2) Economia che vuol dire Lavoro; 3) Partecipazione che vuol dire un modo diverso di rapportarsi dei cittadini tra loro e con l’Amministrazione, e viceversa naturalmente.
La sicurezza non è sicuramente tra le mie priorità. Anzi, affrontare le tre priorità che dicevo e dando risposta al tema dell’ambiente, del lavoro e della partecipazione per me significa rispondere anche al tema della sicurezza. Agitare il tema della sicurezza come fa la destra significa solo fare vuota propaganda.
Certo, anche nella nostra città, nella nostra comunità, i cittadini vogliono sicurezza, ma occorre affrontare il problema in modo serio e articolato e andando nel merito dei problemi, delle situazioni, proporre soluzioni concrete, caso per caso. Non basta scandire slogan come fa la destra di Alan Fabbri.
ALDO MODONESI
Vorrei fare alcune considerazioni sulla contendibilità di Ferrara. Io penso che non ci sia un comune in Italia che oggi non sia contendibile. E questo accade da almeno una decina di anni a questa parte, a causa di tanti fenomeni, compresa una estrema volatilità dell’elettorato. Quindi penso che il tema della contendibilità ci sia anche in queste elezioni amministrative, c’è a Ferrara come nel resto dei comuni che vanno al voto anche in questi mesi. Non bisogna essere preoccupati di questa sfida, anzi bisogna essere consci della situazione e trovare ancora più stimoli rispetto a quelli ai quali eravamo abituati nelle tornate elettorali precedenti.
Se devo descrivere la mia città in estrema sintesi, penso che Ferrara abbia due problemi:
Il calo demografico. Una città in cui nascono 750 bambini e muoiono 1.900 persone è una città che se non immagina per se stessa delle politiche di medio e lungo periodo è destinata ad implodere nel giro di qualche decennio.
Il secondo problema è un problema di natura ambientale. Guardiamo al cambiamento climatico che riguarda il nostro territorio: erano 3 forse 4 mesi che non pioveva: il livello del Po fino a 15 giorni fa era più basso di quello medio dei mesi estivi. Ci si aggiunga anche la situazione particolare geografica della nostra città e del nostro territorio: siamo in fondo alla valle padana e quindi serve non solo curare quello che produci ma guardare anche a tutto quello che viene prodotto a monte, che ti arriva via terra, via aria, via acqua, via sotterranea.
MONINI
Dunque, calo demografico e questione ambientale. Quali risposte mettere in campo?
MODONESI
Ci sono due sole risposte a questo tipo problemi.
La prima si chiama lavoro: aumentare la capacità attrattiva del nostro territorio. Vuol dire invogliare gli studenti universitari a fermarsi, vuol dire attivare politiche serie ed efficaci di integrazione per i nuovi cittadini, quali essi siano, migranti extracomunitari, cittadini europei, o anche solo persone che decidono di spostarsi da una parte della nostra provincia per venire in città. Vuol dire dare le sicurezze giuste e necessarie per mettere su famiglia.
L’altra risposta è la riorganizzazione dei servizi. La riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, politiche educative e per la famiglia, politiche di accesso alla casa, una modifica della politica dei trasporti in modo da ridurre le distanze tra il centro e le periferie, tra le generazioni, tra le professioni. Questo, preso tutto insieme, vuol dire immaginarsi un welfare di comunità diverso, che dia opportunità a chi cresce e certezze a chi invecchia.
ANDREA FIRRINCIELI
Per me la prima priorità è il benessere della persona. Per benessere della persona si intende tutto quello che include la sanità, la salute, l’ambiente. Basta sfogliare i giornali e si capisce come la situazione stia lentamente, ma neppure tanto lentamente degradando. Sull’obbiettivo persona e il suo benessere occorrono iniziative efficaci e urgenti
Poi c’è il tema dell’economia, del lavoro. Occorre rendere più attrattiva la nostra città e legare in maniera più forte il momento dell’istruzione al momento del lavoro. L’integrazione scuola-lavoro spesso viene vissuta come un momento di passaggio, senza darle il peso e il significato che deve avere se vogliamo migliorare la situazione attuale.
Il benessere sociale, la possibilità per tutti di vivere insieme in modo armonico e positivo, dipende soprattutto dai presupposti che ricordavo: la cura del benessere della persona e lo sviluppo dell’integrazione scuola-lavoro. Per mettere mano a tutto questo dobbiamo partire prima di tutto dalle famiglie, dar loro un sostegno maggiore. Anche i protocolli sul bullismo e il cyberbullismo, i protocolli contro la violenza sulle donne e gli abusi ai minori, alla fine sono troppo spesso scollati da quella che è la ricaduta sulle famiglie. Io ho percepito, avendoci lavorato per tanti anni, che tra quello che si vorrebbe fare e quello che in realtà viene fatto c’è una distanza abissale. C’è un problema enorme che è quello della violenza familiare che non si riesce a gestire, come pure il dramma delle truffe agli anziani. In una città sempre più vecchia come Ferrara, chi si occupa degli anziani? Lo facciamo troppo poco. Dobbiamo farlo molto di più e meglio.
MONINI
Vorrei sentire il tuo parere sul tema sicurezza
FIRRINCIELI
Sulla sicurezza, che nemmeno io considero la priorità, dobbiamo però ascoltare attentamente i cittadini. Non possiamo raccontarcela: se uno va a parlare con le persone sente che esiste ed è diffuso un allarme sicurezza. Allora c’è da chiedersi come mai improvvisamente la gente percepisca così questa situazione anche in assenza di episodi di criminalità diffusa. Perché siamo arrivati a questo punto? Se non partiamo da questa domanda, se non ci mettiamo in ascolto, non potremo risolvere il problema.
Tornando al benessere sociale, lasciando da parte l’integrazione, intendo anche la cura di qualcosa di fondamentale. Perché è vero che i nostri indici demografici sono in calo, ma è vero che ci dobbiamo curare di quello che abbiamo. Nelle famiglie dobbiamo mettere mano, dare loro un contributo importante. Non dobbiamo fare in modo tale che tutte queste iniziative di enti e di organizzazioni rimangano sulla carta: i protocolli sul bullismo e il cyberbullismo, i protocolli contro la violenza sulle donne e gli abusi ai minori, alla fine sono troppo spesso scollati da quella che è la ricaduta sulle famiglie. Io ho percepito, avendoci lavorato per tanti anni, che tra quello che si vorrebbe fare e quello che in realtà viene fatto ci sia una distanza abissale. E quindi c’è un problema enorme che è quello della violenza familiare che non si riesce a gestire, le truffe agli anziani. Visto che abbiamo un calo demografico e il numero degli anziani aumenta, perché non ci preoccupiamo di loro? Chi è che si occupa di loro? Noi continuiamo a leggere di questi anziani che hanno 3.000 euro da parte, i soldi del funerale e improvvisamente spariscono.
MONINI
Aggiungo una considerazione. L’ultima ‘grande idea’ per Ferrara è quella di “Ferrara città d’arte e di cultura”, lanciata quasi 30 anni fa da Roberto Soffritti , sindaco di Ferrara per 16 anni e che qualcuno ricorda come ‘il Duca’. Grazie anche al ‘maestro’ Franco Farina, a Paolo Ravenna, a Carlo Bassi e tanti altri, è stata una grande intuizione, una idea che ha avuto successo e che ancora oggi da i suoi frutti. Certamente Ferrara ha fatto dei passi in avanti: sul turismo e l’indotto del turismo, il recupero del centro storico, Abbado al Comunale, le grandi mostre, eccetera. Oggi però molte città hanno seguito la stessa strada, Ferrara ha tante concorrenti: non sto parlando di Venezia o Firenze, ma della stessa Rovigo…
GESSI
Siamo nel terzo millennio. Forse occorre una nuova idea forza. Quale considerate essere la precipua vocazione di Ferrara e come immaginate la città nel 2030?
FUSARI
C’è la necessità di avere una visione d’insieme. Io sono venuta a Ferrara nel ’91 quando non c’erano neppure le Mura. Credo che occorra partire proprio dalla specificità del territorio ferrarese, dal nostro non essere – e io dico per fortuna – sulla via Emilia, una posizione che da un certo punto di vista ha consentito di preservare questo territorio e che da sempre è stato letto invece come un punto di debolezza. Ora è venuto il momento di trasformare questo punto di debolezza in quello che veramente è: un valore. Noi abbiamo una caratteristica territoriale, un valore riconosciuto addirittura dall’Unesco, città e Delta del Po, e un territorio straordinario. Allora la vocazione del futuro, questa città nel 2030, è accettare un’altra sfida come fu allora quella di 30 anni fa. Fare di Ferrara la capitale del verde europea. Capitale europea del verde quest’anno è Oslo, il prossimo sarà Lisbona. Lavorare su quello significa darsi una strategia per poter arrivare a questo obiettivo. Dobbiamo darci una strategia sulla sostenibilità, quindi intendo il termine ‘verde’ nel senso più ampio, una sostenibilità intesa non solo come ambientale ma anche economica e sociale. Una strategia comune da perseguire tutti assieme, ognuno nelle sue peculiarità: istituzioni pubbliche, privati, associazioni di categoria, università. Una strategia per far sì che il nostro territorio non sia più il fanalino di coda dell’Emilia Romagna. E la prima ricaduta pratica per noi cittadini, se lavoriamo sull’ambiente è avere più salute per tutti.
GESSI
Stai sostenendo come priorità la scelta della green economy? E come si finanzia un passaggio epocale del genere?
FUSARI
Se seguiamo questa strada, d’ora in poi, sempre di più la green economy e l’economia circolare saranno settori che porteranno lavoro. Nuovi settori, nuovi mestieri, nuova occupazione. Per affrontare il cambiamento climatico e la promozione della green economy sicuramente servono risorse extra bilancio comunale, ma l’Europa da tempo finanzia questo tipo di interventi. Dobbiamo lavorare su questo tema e con questo obbiettivo. Poi: diventiamo capitale europea del verde? Sì, no, non importa. Lavoriamo in questa direzione che ci porterà comunque lavoro e intanto miglioriamo la qualità del nostro ambiente.
MODONESI
Io penso che si debba fare un percorso assolutamente condiviso con tutte le forze in campo per lavorare sulle peculiarità del nostro territorio. Farlo in un’ottica profetica come un po’ è stata la visione di quella proposta ormai trent’anni: dal grande progetto Mura , al potenziamento dei percorsi museali, al parco urbano che oggi stiamo fruendo nel loro pieno sviluppo. Si tratta di proseguire su questa strada, rafforzando quello che è un percorso che in questi mesi abbiamo definito all’interno del Patto del lavoro, ovvero ottenere l’insediamento di nuove imprese, anche all’interno dell’area del petrolchimico. Vuol dire fare percorsi sostenibili dal punto di vista ambientale, sia per quanto riguarda le produzioni che per quanto riguarda le tipologie di impianti. Significa ottenere la creazione di nuovi e buoni posti di lavoro, significa una maggior integrazione tra formazione e avvio al lavoro.
MONINI
Il problema è sempre quello del come avviare questa nuova stagione. Con quale strategia, con quali alleati? Con quali fondi?
MODONESI
Rendere attrattivo il nostro territorio per le imprese vuol dire sfruttare a pieno quelle che sono le nostre caratteristiche. Vuol dire avere il coraggio di dire che c’è la necessità di una marcia diversa da parte in modo particolare dello Stato su quelle che sono le politiche di infrastrutturazione. Il tema delle infrastrutture è un tema che c’è. Oggi chi va a Bologna in treno capisce quanto sia necessario avere un potenziamento su quella linea e non solo per quanto riguarda le Frecce o Italo. Per chi va a Bologna oggi in auto sembra di essere su una camionabile: è necessario mettersi in corsia di sorpasso e una volta su due si creano incidenti. Sono interventi non più rimandabili, perché da sempre interventi di questo tipo si collegano con quelli che sono i punti nevralgici dello sviluppo di un territorio.
Vuol dire certamente un maggior coinvolgimento dell’Università, nel rispetto delle sue autonomie. Le Università sono gelose delle proprie autonomie e forse la nostra lo è ancora di altre. E’ giusto che faccia i propri percorsi di sviluppo e di crescita, però c’è la necessità non solo di immaginare un rapporto con l’ente pubblico, un rapporto non semplicemente legato ad una messa a disposizione di servizi. Ci vuole anche qui una programmazione per aiutare gli studenti ad insediarsi in città, dove sicuramente si deve studiare e si deve studiare anche bene, ma si deve offrire a questi studenti di rimanere, una volta che diventano laureati. Quindi se c’è un limite è quello dell’accompagnamento al lavoro. Quindi: più impegno su questo versante dell’Università come del mondo produttivo ,
Facendo campagna elettorale, sto girando il territorio e sto parlando con tanti imprenditori. Mi sono accorto che ci sono, ci sarebbe, necessità di nuove assunzioni. Tante imprese della zona della piccola e media industria hanno bisogno di ingegneri o di personale con alte qualifiche, ma scontano un percorso di inserimento lavorativo molto faticoso, che potrebbe invece essere molto più semplice se strutturato con un dialogo intermedio tra sistema delle imprese e l’Università.
GESSI
Anche l’economia della cultura, cioè tutto l’indotto che vive attorno a ‘Ferrara Città d’Arte e di Cultura’ andrebbe qualificato e potenziato. Ho l’impressione che abbiamo ancora tanta strada da fare.
MODONESI
Hai ragione, c’è ancora un grosso lavoro da fare attorno alla vocazione culturale della nostra città. Noi abbiamo strutturato un progetto organico in questi anni che mirava ad ampliare la presenza turistica a Ferrara. Lo sviluppo del polo museale: il primo è quello dell’arte moderna e contemporanea Diamanti e Massari, il secondo legato al polo di Schifanoia sulle arti antiche, il terzo con il Meis e il quarto legato al Castello. Abbiamo messo in campo idee e progettualità, ed è un’esperienza positiva e che ci viene riconosciuta a livello non solo nazionale ma internazionale. Da Roma abbiamo avuto recentemente alcuni ‘no’, ingiustificati, ma continueremo a insistere, perché bloccare i fondi di questo o quel progetto significa un colpo non solo allo sviluppo della rete museale cittadina, ma allo sviluppo economico complessivo di Ferrara.
Alla fine se vuoi avere più visitatori devi metterli nelle condizioni di avere musei con spazi adeguati con book-shop ecc. E non c’è un museo con questo tipo di ambizione che non abbia accettato la sfida di innestare un pezzo di contemporaneo in quella che è una scrittura storica. Il primo selfie che ci facciamo al Louvre è con la Piramide, il secondo con la Gioconda.
FIRRINCIELI
Vorrei parlare di un’altra vocazione di Ferrara. Di come l’ho vissuta io in tanti anni di attività. Attraverso il mio ruolo ma anche vivendo in prima persona il mondo del volontariato.
La vocazione di Ferrara secondo me, in questo momento, si manifesta molto nel volontariato e nella solidarietà. Io vedo che Ferrara è piena di associazioni, di volontariato, di gente che si dà da fare nel campo sociale, nel settore delle persone con difficoltà, nel settore dell’aiuto agli emarginati. Sul cuore di Ferrara bisognerebbe puntare molto di più. La vocazione di Ferrara è avere un cuore importante, un cuore grande. E questo tipo di vocazione è trasversale a tutto: al mondo della cultura e a qualsiasi altra situazione. Ferrara nel 2030? Mi viene in mente La città volante di Roberto Pazzi: se noi non cerchiamo di radicare un po’ di più la città e la sua Amministrazione alla realtà che le persone vivono ogni giorno, rischiamo di arrivare a quella città volante.
1.continua – leggi qui la seconda parte del dibattito