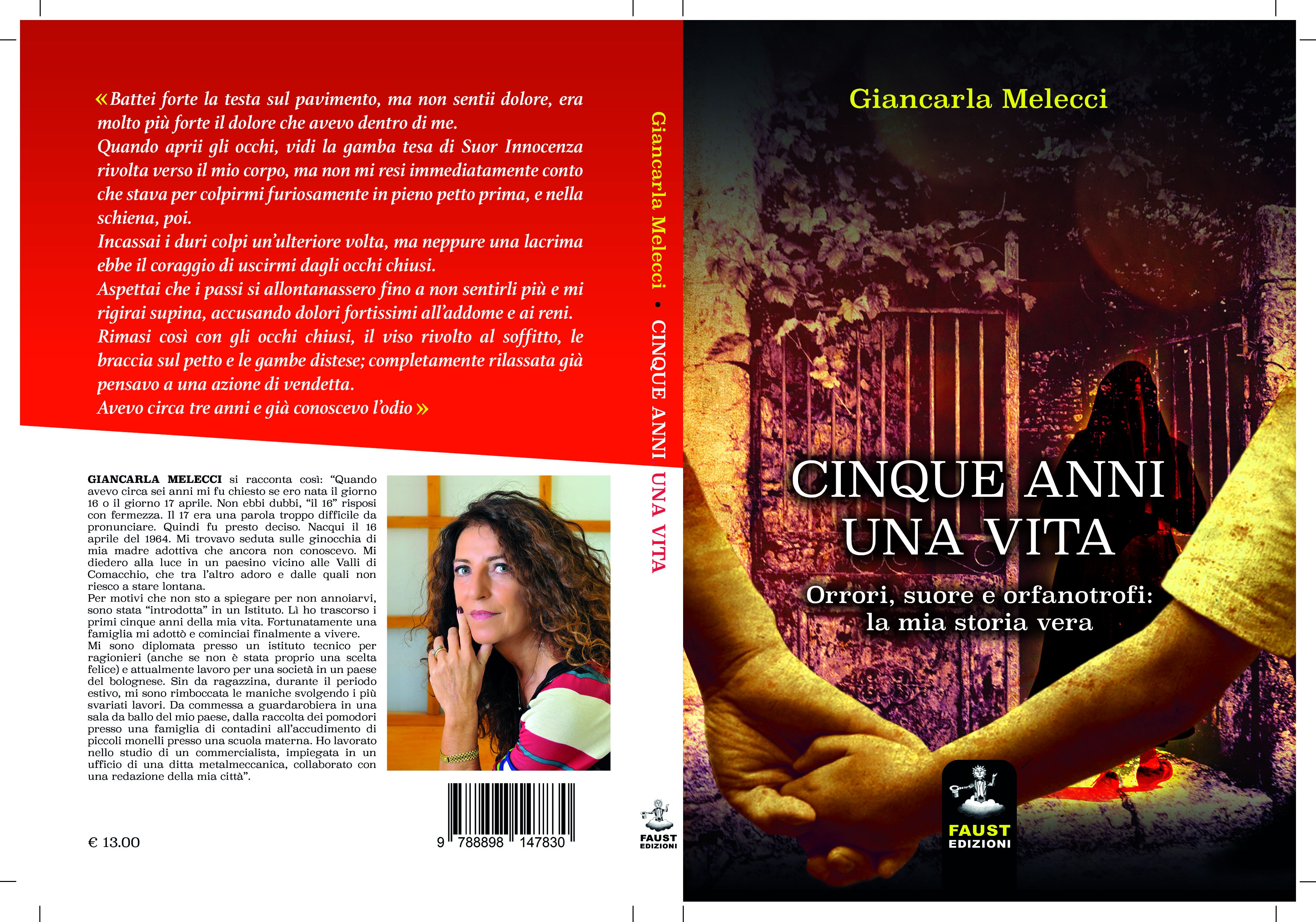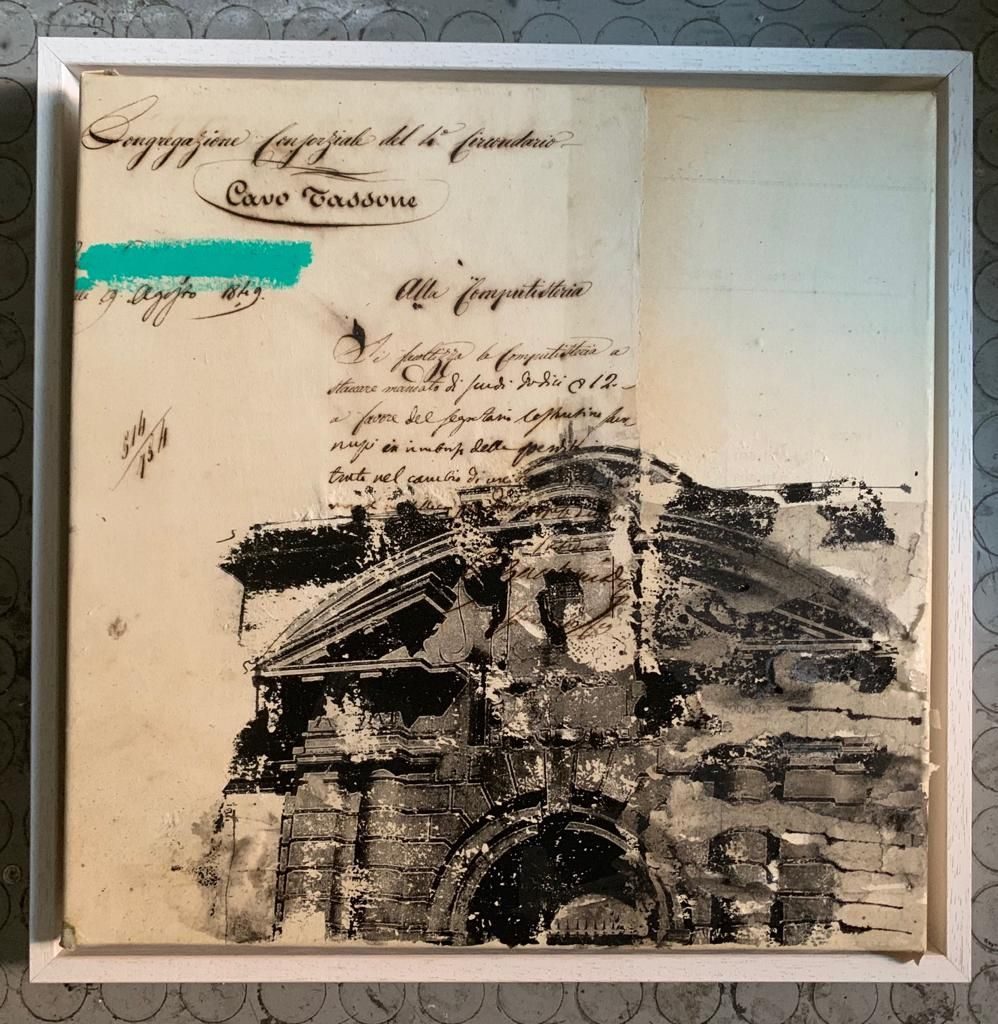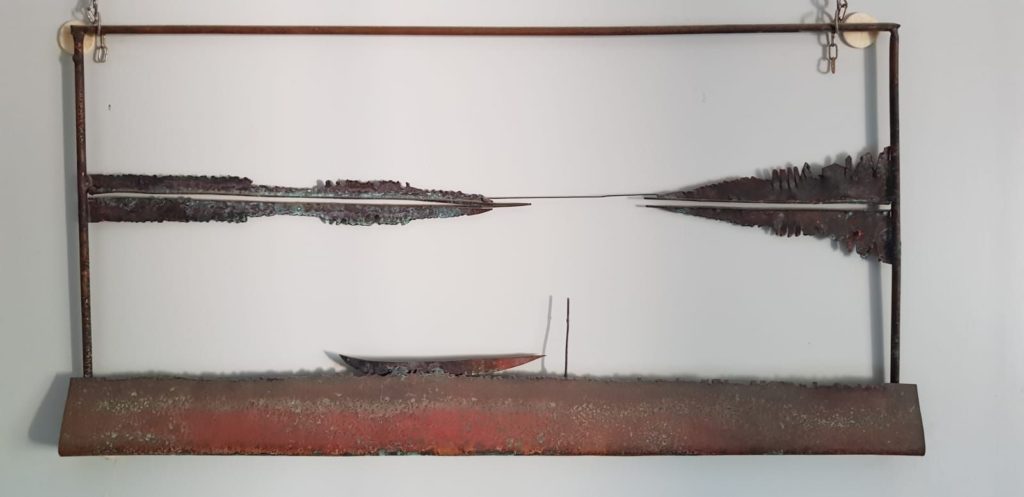da: ufficio stampa Comune di Ferrara
Più di 250 ospiti provenienti da 38 paesi e da 5 continenti per 250 ore di programmazione e 122 incontri, questi i numeri della XIII edizione di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune di Ferrara, presentato mercoledì alla Sala degli Arazzi del Palazzo Municipale di Ferrara.
“Questo festival – ha dichiarato Chiara Nielsen, vice direttore di Internazionale – è un’impresa collettiva che non riguarda solo noi e i giornali esteri che rendono per tre giorni Ferrara la redazione più grande del mondo, ma riguarda il coinvolgimento di tutte le realtà cittadine e che trasformano il festival in un momento di incontro tra tante anime e personalità. Quest’anno il filo rosso tra gli appuntamenti sarà il tema dell’emergenza climatica declinato in ogni settore, dall’economia alla società. Ricorderemo anche teatri di crisi dove l’attualità è incandescente. Inoltre, come ci siamo prefissi da diversi anni, ci saranno tante donne e si parlerà tanto di carcere. Come sempre non mancheranno i momenti di intrattenimento e una ricchissima programmazione per bambini”.
[Qui il programma completo]
“Diamo il benvenuto al festival di Internazionale – ha dichiarato il sindaco del Comune di Ferrara, Alan Fabbri – nella nostra bellissima Ferrara, patrimonio dell’Unesco, città ricca di storia e di tradizioni. Questi tre giorni dedicati a temi di grande attualità rappresentano, per tutti, un’occasione di riflessione sulle dinamiche che muovono politica ed economia, a livello nazionale e internazionale, e sulle ricadute che queste hanno sulla vita di ogni cittadino. Il valore intrinseco di una manifestazione come questa, sta nel dare spazio al confronto tra idee, anche diverse, senza limitazioni dettate da logiche di appartenenza. Siamo certi che dagli spunti che il festival saprà proporre potranno nascere ulteriori momenti di riflessione, capaci di arricchire l’intera comunità nella consapevolezza che le vicende del presente e del futuro ci appartengono e sono determinate dal percorso, dalle scelte e dalle idee di ciascuno di noi”.
Ad una settimana dalle grandi manifestazioni internazionali del 27 settembre scorso, parte il festival di Internazionale a Ferrara che ha scelto come filo conduttore le mobilitazioni che in tutto il mondo chiedono alla politica di agire contro il cambiamento climatico: #FerraraForFuture. Racconteranno il loro attivismo i protagonisti delle manifestazioni #FridaysForFuture: Maxime Lelong, organizzatore della prima Marcia per il Clima a Parigi, Daze Aghjl, attivista britannica di Extinction rebellion e Alexander Fiorentini, esponente di #FridaysForFuture Italia. Il premio Anna Politkovskaja, con cui si aprirà il festival, andrà alla giornalista ambientale nigeriana Augustina Armstrong-Ogbonna che per la sua inchiesta del 2016 sulle attività di dragaggio della società dell’ex Ministro degli Interni nigeriano Emmanuel Iheanacho è stata minacciata, sorvegliata dalle forze di sicurezza dello Stato e costretta a fuggire negli Stati Uniti.
Si parlerà del Brasile di Bolsonaro con Mônica Benicio, compagna di Marielle Franco, femminista brasiliana e attivista lgbt assassinata a marzo 2018, mentre il giornalista cileno Patricio Fernàndez con i colleghi Luz Mely Reyes, dal Venezuela, e Carlos Salinas Maldonado, dal Nicaragua, parleranno della svolta a destra nei governi dei loro paesi favorita dalla crisi economica e degli scandali di corruzione della sinistra. Approfondimenti anche sul Medio Oriente: dalla Siria allo Yemen fino alla rivalità tra Iran e Arabia Saudita che sta destabilizzando la regione. Ne discuteranno il professore Pejman Abdolmohammadi dell’Università di Trento, Stéphane Lacroix, politologo francese e il giornalista de L’Orient-Le Jour, Anthony Samrani.
Religione e nazionalismo saranno invece al centro del dibattito tra il politologo francese Olivier Roy e Monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo della diocesi di Ferrara e direttore della fondazione Migrantes. Sarà ospite del festival di Internazionale Shoshana Zuboff, attivista e professoressa alla Harvard Business School, autrice del libro The Age of Surveillance Capitalism che affronta il tema del controllo dei cittadini attraverso l’uso dei big data. Di tecnologie e futuro del lavoro discuteranno Maurizio Landini e il giornalista britannico Paul Mason, autore del recente Il futuro migliore (Il Saggiatore, 2019). Come ogni anno non mancheranno incontri dedicati al tema dei diritti umani e dei diritti delle donne. Dagli Stati Uniti, il giornalista Shane Bauer, la visual artist Nigel Poor e l’ex detenuto Earlonne Woods, co-conduttore e ideatore del podcast Ear Hustle, racconteranno come si vive all’interno delle prigioni americane. Un focus particolare sarà dedicato a come gli uomini che lavorano nell’industria culturale propongono l’immagine della donna. Ne parleranno Ellen Maria Tejle, promotrice della campagna A-rating per valutare i film in base alla rappresentazione delle donne, Christina Knight, copywriter e direttrice creativa svizzero-inglese, e Livia Podestà che promuove una corretta rappresentazione di genere sui media allo Swedish Institute di Stoccolma. Attenzione puntata anche sui diritti delle donne in Medio Oriente con Farahnaz Forotan, giornalista afghana, Fatima Faizi, corrispondente del New York Times da Kabul, e Rafia Zakaria, scrittrice e avvocata pachistana. Dialogheranno di femminismi la scrittrice e regista francese Virginie Despentes e il filosofo spagnolo Paul B. Preciado, filosofo della teoria queer e di studi di genere. E a Ferrara verrà lanciato l’European Network for Women Excellence, un database che raccoglie voci di donne autorevoli in tutta Europa.
Non mancheranno le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori, fra gli altri il francese Edouard Louis. Infine, il cinema, la fotografia, il giornalismo per bambini e la musica. Alice Rohrwacher con Lazzaro Felice e Phaim Bhuiyan, che ha debuttato nei cinema italiani con Bangla. L’inchiesta di Laia Abril, fotografa e artista spagnola, lavoro multimediale sui rischi e le conseguenze dell’aborto illegale. Mentre dedicato al meglio del giornalismo per bambini sarà l’incontro con lo scrittore Davide Morosinotto e le giornaliste di due delle realtà internazionali editoriali più interessanti nel settore: Cécile Bourgneuf di P’tit Libé, Inge Kutter di Zeit Leo. Dedicati alla musica due appuntamenti speciali: sabato sera il concerto del cantautore italiano Diodato e domenica l’esibizione della band dei Musicisti per i diritti umani.
Appuntamento rinnovato anche per questa edizione con i documentari su attualità, diritti umani e informazione di Mondovisioni a cura di CineAgenzia, con la rassegna di audiodocumentari Mondoascolti, a cura di Jonathan Zenti e con i laboratori dedicati a bambine e bambini. Internazionale a Ferrara è un festival senza barriere architettoniche e accessibile a tutti. Alcuni degli incontri saranno tradotti nella Lingua dei segni italiana.
Michele Pinelli, delegato alla Terza Missione Università di Ferrara
“La diffusione del sapere, del dialogo e della riflessione sono le basi su cui si fonda la ormai solida e duratura collaborazione dell’Università di Ferrara con il Festival. Il coinvolgimento dell’Ateneo ha diverse manifestazioni: dall’apertura di palazzi di prestigio e aule per accogliere appuntamenti e incontri del programma ufficiale al tradizionale workshop organizzato dal Master in giornalismo scientifico. Novità di quest’anno, lo stand Unife presente in piazza Trento Trieste, in cui sarà possibile raccogliere informazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo e su come immatricolarsi e in cui saranno presenti le nuovissime linee di abbigliamento e oggettistica griffate Unife. Ma soprattutto, lo stand veicolerà il messaggio del progetto di crowdfunding dedicato alla raccolta fondi per progetti di ricerca dell’Ateneo ad alto valore scientifico e con ricadute concrete sulla collettività”.
Francesca Molesini, Assessore alla Cultura del Comune di Portomaggiore
“Per il quarto anno il Comune di Portomaggiore aderisce al programma del Festival di Internazionale a Ferrara, ospitandone in Sala Consiliare l’unica tappa ‘fuori sede’. Sabato 5 Ottobre alle 10, avremo l’onore di incontrare la vincitrice del Premio Anna Politkovskaja 2019, Augustina Armstrong-Ogbonna, giornalista multimediale nigeriana, specializzata in informazione sull’ambiente e sviluppo sostenibile. Verrà intervistata dal giornalista Edoardo Vigna, caporedattore del magazine Sette del Corriere della Sera, dove cura anche la rubrica Afrasia e titolare del blog Globalist su corriere.it. Sarà un’importante occasione di confronto e approfondimento su una delle tematiche attualmente più rilevanti a livello mondiale”.
Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio di Ferrara
“Internazionale ci ricorda quanto complesse e difficili siano ancora oggi le problematiche del nostro tempo, che è importante documentare con misura critica, trasparenza e coraggio raccogliendo e valorizzando i fermenti di riscatto e di progresso che pure non mancano, e che si manifestano in tanti campi e settori, anche particolarmente avanzati e innovativi, e specialmente tra le nuove generazioni. Sono convinto che il Festival saprà, ancora una volta, assolvere un ruolo cruciale per promuovere il confronto pubblico sui problemi ancora aperti e sulle prospettive da perseguire”.
Chiara Magni, responsabile Public engagement di MSF Italia
“Anche quest’anno porteremo a Ferrara la nostra testimonianza dalle crisi umanitarie in cui operiamo – come il Venezuela, la Libia, l’Ebola in RDC – ma anche sulle sfide in corso per garantire le cure a chi ne ha bisogno. Oggi pazienti affetti da malattie come HIV, Tubercolosi ed Epatite C continuano a morire perché non hanno accesso ai trattamenti salvavita, ancora inadeguati, inaccessibili o troppo costosi. Ne parleremo celebrando i venti anni della nostra Campagna per l’Accesso ai Farmaci, che dal 1999 opera per promuovere l’accesso alle cure. Al corner di MSF in piazza Trento e Trieste una speciale installazione interattiva sul tema della Luna – anch’essa inaccessibile fino a 50 anni fa – coinvolgerà il pubblico e lo inviterà a fare la propria parte perché il diritto alla salute sia davvero garantito”.
Valentina Preti, Ufficio Comunicazione Alce Nero
“Torniamo al Festival di Internazionale perché troviamo qui il naturale contesto per affrontare le tematiche che mettiamo al centro del nostro lavoro. In particolare, quest’anno portiamo a Ferrara il progetto “Siamo fatti di terra”: un ciclo di eventi nati per approfondire, insieme ad agronomi, nutrizionisti e ricercatori, lo stretto rapporto tra la salute del pianeta e quella delle persone, partendo da un’agricoltura responsabile, biologica. Saremo al Teatro Nuovo domenica 6 ottobre alle 11:30″.
Daniele Bertarelli, Presidente della cooperativa Sociale CIDAS
“Anche quest’anno CIDAS conferma il sostegno al Festival Internazionale a Ferrara. La nostra cooperativa sociale è nata nel 1979 dalla volontà di un gruppo di famiglie di ragazzi con disabilità, che si è associato per fornire servizi a loro tutela. Oggi, 40 anni dopo, ci siamo ulteriormente specializzati nella cura della disabilità con 7 strutture tra centri socio riabilitativi residenziali e diurni, e un centro socio occupazionale. Nel tempo la cooperativa si è sviluppata ed attualmente offre anche servizi socio sanitari per anziani, attività educative per l’infanzia e l’adolescenza, fornisce trasporto sanitario, gestisce servizi rivolti all’accoglienza ed integrazione dei migranti, si occupa di mediazione sociale ed inclusione lavorativa, in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro del nostro lavoro ci sono sempre i diritti di cura e i bisogni degli ospiti e delle loro famiglie, per questo abbiamo proposto al Festival un appuntamento sull’affettività e la sessualità delle persone con disabilità, che vedrà la partecipazione di esperti del settore tra cui un nostro educatore.
Inoltre, dato il nostro impegno per l’inclusione delle persone migranti, con una nostra insegnante di italiano per stranieri, parteciperemo all’incontro sull’arricchimento linguistico e culturale dato dalla presenza nelle nostre comunità di persone di altri paesi”.
Luca Grandini, responsabile provinciale Cna Artistico e Tradizionale Ferrara
“Come ogni anno la Cna di Ferrara partecipa a Internazionale con l’eccellenza degli artigiani e dei sapori tradizionali delle nostre terre, in collaborazione con la strada dei Vini e dei Sapori. L’esposizione dell’artigianato artistico, la cena per i giornalisti e il mercato dei sapori artigiani sono altrettante dimostrazioni che uno sguardo sul mondo aperto e senza pregiudizi ben si concilia con la consapevolezza profonda delle proprie tradizioni”.
Paolo Bruni, presidente Cso Italia
“Le pere IGP dell’Emilia Romagna non sono solo straordinari frutti autunnali pieni di gusto e proprietà nutrizionali ma rappresentano anche una vera e propria bandiera del Made in Italy nel mondo. Sono coltivate esclusivamente in aree storicamente vocate tra le quali spicca Ferrara che, rappresenta la culla mondiale della produzione di pere seguita da Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna.
Il patrimonio produttivo della pericoltura emiliano romagnola rappresenta un importante traino per l’export agroalimentare che, come è noto è una delle voci più significative del pil nazionale. Una bandiera quindi che rappresenta i produttori italiani e che quest’anno sta vivendo una crisi drammatica legata alla presenza massiccia della cimice asiatica. Una crisi che rischia di mettere in ginocchio il settore. Per questo è importante unire le forze e le competenze per sostenere tutta la filiera”.
Francesca Tamascelli, responsabile Doc Servizi Ferrara
“Doc Press è la cooperativa dei giornalisti indipendenti nata per promuovere un giornalismo sostenibile e di qualità. I soci, che si sono dati un regolamento interno, puntano sulla professionalità, la cooperazione e utilizzano l’opportunità data dallo sviluppo di nuove tecnologie. Partecipiamo al Festival di Internazionale con una serie di iniziative e, tra queste, l’incontro ‘Cooperazione e nuove tecnologie per un giornalismo forte e sostenibile’ – venerdì 4 ottobre alle 15,30 – nell’Arci Bolognesi di Ferrara. Durante il Festival, del quale condividiamo i valori, vogliamo incontrare e parlare con il maggior numero possibile di giornalisti freelance. Ai colleghi vogliamo raccontare cosa facciamo e capire se possiamo sviluppare insieme opportunità. Doc Press fa parte di Doc, la rete di professionisti nei settori di Arte, Cultura, Industria Creativa e Impresa Culturale che gestiscono la propria attività in cooperativa per ottenere più vantaggi e tutele”.
Serena Scarfi, responsabile organizzazione mostra World Press Photo
“Anche quest’anno siamo felici di portare la mostra World Press Photo a Ferrara perché crediamo che sia la più importante rassegna internazionale di fotogiornalismo che, attraverso il linguaggio della fotografia, è in grado di restituire la complessità dell’umanità attuale. Ci auguriamo che la mostra rappresenti uno strumento di riflessione e di apertura verso la diversità e le paure, spesso indotte dai mezzi di comunicazione di massa. Per questo invitiamo tutti a visitare la mostra che si terrà al Padiglione d’Arte Contemporanea dal 4 ottobre al 3 novembre 2019”.




















 Cosa ne pensa di questa risoluzione del Parlamento Europeo?
Cosa ne pensa di questa risoluzione del Parlamento Europeo?