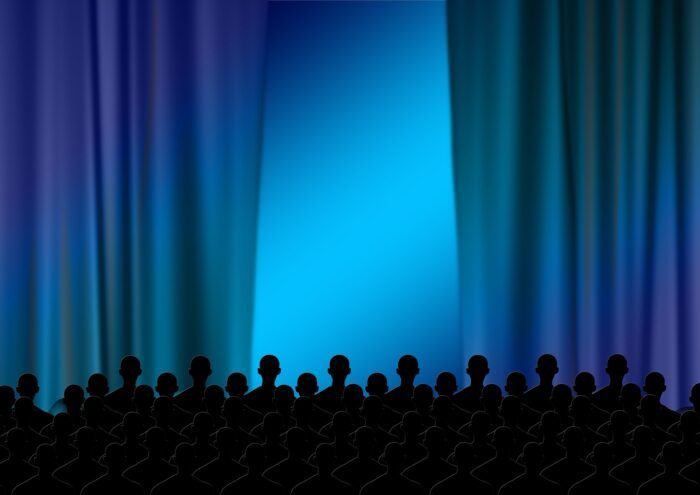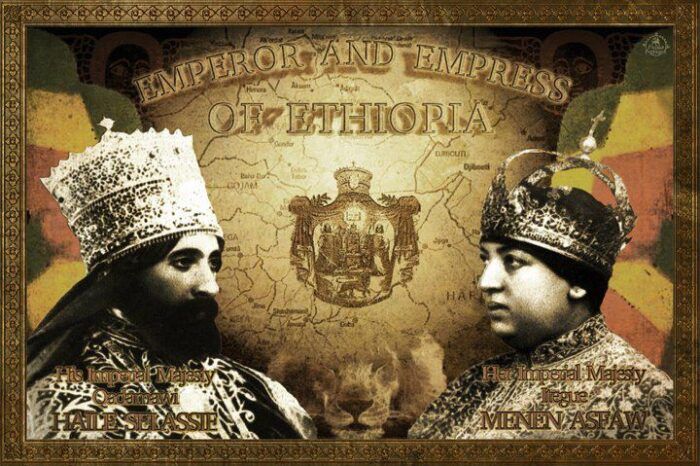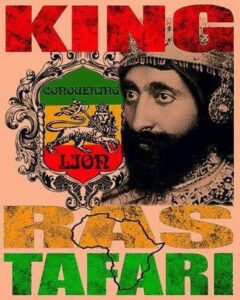UNA VITA MIGLIORE
Provai grande delusione quando finirono le speranze di dar vita a una società migliore, trasformata dagli ideali del Sessantotto. Certo quel movimento aveva le sue contraddizioni e la lotta a una società ingiusta era troppo spesso motivata da frustrazioni e rancori personali, dalla noia di un’esistenza troppo comodamente borghese o dall’aspirazione a un potere alternativo non meno elitario. Ma è innegabile che in quel periodo fiorirono nobili ideali di emancipazione e fratellanza tra gli uomini che ancora oggi meritano di essere perseguiti. Per molti anni ho ricercato vanamente un’attività che in qualche modo potesse ridarmi quell’entusiasmo e quella voglia di realizzare qualcosa al di là dell’angusta sfera della dimensione personale.
Poi, un giorno, del tutto casualmente, ho cominciato a praticare lo Yoga e ho appreso così che lo Yoga classico, diversamente da molte fantasiose e discutibili interpretazioni contemporanee, non si limita solo a migliorare la gestione equilibrata delle risorse personali (fisica, energetica e mentale), ma che non può prescindere anche dalla ricerca dell’armonia con l’ambiente circostante: uomini, animali, natura. Questo perché alla base dello Yoga, così come di altre discipline orientali, c’è una visione di sostanziale unità della vita e dell’interdipendenza delle sue manifestazioni. Il benessere profondo, dunque, necessita di realizzare unione con la Vita (yoga vuol dire unione) e svolgere il proprio ruolo in sintonia con gli eventi, in ogni momento della giornata. Centrati quanto più possibile nel Sé interiore, si affrontano le diverse situazioni della vita, cercando di dare il meglio in ogni occasione. Si vive così profondamente soddisfatti per il solo fatto di essere, comunque, dovunque.
Questa visione della vita è evidentemente diversa dalla ricerca della felicità, così come viene intesa nella società occidentale contemporanea, in cui si ricerca generalmente il piacere che deriva dal possedere quantità sempre più crescenti di beni materiali e dalla capacità di assumere ruoli sociali che ci distinguano per importanza e ci facciano sentire ‘migliori’ degli altri. Realizzarsi è diventato desiderare qualcosa, essere qualcuno.
Ma il benessere materiale e il successo personale non sono mai sufficienti, e gli individui, per quanto possano avere o essere, sono ben lontani dalla felicità. Molte persone vivono una tensione ininterrotta e nevrotica verso un piacere effimero e di breve durata; stimolati da una costante pressione dei mezzi di comunicazione, ricercano in modo ossessivo la conquista di sempre nuovi desideri.
Con il prevalere dei valori tecnico-economici, per cui il successo è misurabile in termini di denaro e di notorietà, ci si allontana però dalle esigenze umane più profonde. Manca sempre più un quadro di riferimento condiviso e un comune senso della vita; ciò provoca l’accentuarsi di un individualismo che alimenta un concetto di libertà senza limiti, dove tutto è praticabile per riempire solitudine e vuoto esistenziale. Viene esaltata la retorica di una libertà di scelta che nasconde irresponsabilità, incapacità di autodisciplina e sacrificio. La vita è spesso percepita priva di senso e di scopi degni di essere perseguiti.
Credo sia ormai evidente la necessità di sviluppare un diverso modello sociale, in sintonia con l’attuale globalizzazione, processo di interdipendenze economiche, sociali, culturali, politiche e tecnologiche, che può essere visto come opportunità di operare con una visione unitaria del mondo.
L’importanza del singolo va inquadrata all’interno della comunità umana, dalla quale si può ricevere posizione e significato; è fondamentale che gli individui si sentano uniti dalla consapevolezza di lavorare in una comune direzione e sappiano perseguire esigenze e scopi comuni. Solo se si riesce a vedere il vantaggio di superare i propri interessi particolaristici, si può costruire un mondo giusto e solidale, in cui si ponga un limite allo sfruttamento delle risorse umane e ambientali e si adotti uno sviluppo sostenibile, finalizzando le politiche economiche globali alla lotta contro la disuguaglianza e la povertà. Un tale modello di sviluppo sposa «un modello ‘ecologico’, in base al quale la vita delle parti è tanto migliore quanto migliori sono le relazioni tra le parti» (G, Pasqualotto, East & West, Marsilio).
Risulta ormai urgente porre le basi di un nuovo umanesimo, che metta l’uomo al centro e consideri la tecnica come strumento per la sua realizzazione e felicità, contrastando la tendenza che vede gli uomini al servizio dei beni e della ricchezza. Determinante è un rinnovamento della cultura, tramite l’integrazione di tutte le conoscenze umane, e dell’educazione, con cui alimentare la crescita di individui capaci di costruire un mondo migliore.
Ritengo indispensabile che i diversi tipi di conoscenza sviluppati in ogni parte del pianeta possano connettersi utilmente; in particolare, ritengo auspicabile l’integrazione tra la scienza e la spiritualità.
Lo sviluppo dell’atteggiamento scientifico e del sapere critico-razionale, che hanno portato a indubbi successi relativamente alla qualità e alla durata della vita – (basti pensare agli effetti delle tecnologie di produzione alimentare e della scienza medica) – non è sufficiente a interrogarsi e a progredire sui significati del vivere.
La conoscenza sempre più forte del legame tra gli esseri e il loro mondo, la percezione di questo legame globale è piuttosto l’oggetto caratteristico di una “via del cuore”, una funzione dell’anima, la cui cura resta, ancora oggi, di fondamentale importanza. Proprio l’aspetto spirituale, con la sua visione di una dimensione unitaria dell’uomo e della vita, merita una rinnovata interpretazione, che ispiri azioni di ricerca e sperimentazioni, le quali pragmaticamente offrano soluzioni per superare le attuali criticità sociali dell’Era globale.
Può essere utile una spiritualità che non necessita dell’adesione ad alcun credo religioso, e che al tempo stesso non lo escluda, che non sia necessario catalogare con nessuna formula e che possa essere patrimonio di chiunque, ma che soprattutto si esprima e sia valutata in fatti concreti, in azioni e comportamenti che aiutino il cammino degli esseri umani; che si fondi sulla reale aderenza a principi e valori comuni di fratellanza umana e rispetto dell’ambiente, concretamente espressi nel quotidiano con sentimenti di vicinanza, comunione, condivisione e coesione tra gli esseri. Questi valori devono guidare le scelte, orientare il desiderio, indicare il senso di ogni attività, costituire oggetto fondamentale di trasmissione educativa, fornendo un senso di appartenenza che dia forza per superare le capacità meramente individuali.
Si potrà così coltivare un Uomo globale, che potrà affrontare utilmente le sfide del futuro, comprendendo quanto la collaborazione sia lo strumento più efficace per ottenere i risultati desiderati; egli dovrà avere come obiettivo il migliore destino comune per l’umanità intera, conscio dei legami tra gli individui. Sarà pertanto necessario coltivare apertura mentale, flessibilità e disponibilità a ridiscutere le proprie conoscenze, alla luce di nuove possibilità, trovando ogni volta il pensiero e l’azione più adatta per raggiungere un nuovo equilibrio adatto al mutare degli eventi. Sempre più privo di soluzioni già pronte per l’uso, ovunque e comunque valide, l’essere umano è spinto a sviluppare la consapevolezza, oltre che delle connessioni tra i vari saperi, dei limiti di ognuno di essi e a scegliere liberamente tra più opzioni, nonché a sapere ridiscutere le sue convinzioni quando queste si dimostrino superabili.
Questa consapevolezza è la base più adatta per disegnare un futuro pragmaticamente utile per una visione della vita da cui sviluppare chiarezza, ordine e valore, in sintonia con le conoscenze più moderne. Con questa idea pratico e insegno da molti anni EduYoga, un metodo che ho sviluppato a partire dalle ‘vie’ dello Yoga classico, che ha l’obiettivo di educare il praticante a realizzarsi con generale soddisfazione, esprimendosi in ogni momento della vita con la miglior sintonia possibile al mutare delle situazioni. Ritengo che un percorso di evoluzione e di cambiamento consapevole, nel rispetto delle proprie esigenze e di quelle dell’ambiente circostante, possa supportare lo sviluppo di individui che, migliorando se stessi e le loro relazioni con il mondo che li circonda, siano portatori di benessere, pace e cooperazione.
Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di verificare che anche il mondo dello Yoga non nasconde pericoli e contraddizioni. Ho frequentato insegnanti che plagiavano i loro allievi, sono stato costretto ad allontanarmi dalla più grande associazione italiana di insegnanti di yoga perché, insegnando gratuitamente, sono stato accusato di svolgere concorrenza sleale nei confronti dei “professionisti” dello Yoga e ho commesso il terribile errore di credere che donare senza pretendere nulla in cambio fosse in sintonia con un percorso di ricerca spirituale. Ciò nonostante continuo nella mia attività di ricerca e di condivisione perché, indipendentemente dalle inevitabili contraddizioni, penso ancora che perseguire un ideale apprezzabile, seppur con un adeguato senso della realtà, mi aiuti a cercare un’esistenza migliore per me e per gli altri, con i quali condivido questo viaggio della Vita.