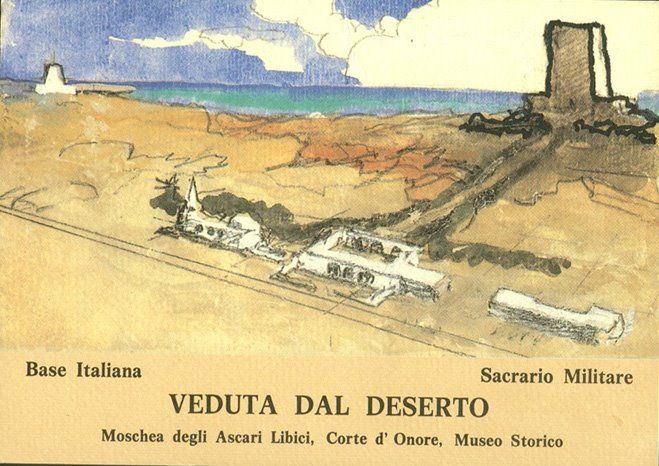DDL Zan e ingerenze vaticane:
riflessioni dietro le quinte
Il 17 giugno scorso la Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato vaticana scrive una Nota verbale, che l’inglese mons. Paul Richard Gallagher (praticamente il ministro degli Esteri di papa Francesco), ha consegnato ‘informalmente’ all’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani. [Qui]
Il dito è puntato al disegno di legge che porta il nome dell’on. Alessandro Zan del Pd, approvato alla Camera il 4 novembre 2020 e attualmente all’esame del Senato, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.
Il motivo delle due pagine scarse è duplice.
- Alcuni contenuti, specie sulla ‘criminalizzazione’ delle condotte discriminatorie per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, “avrebbero l’effetto – testuale – di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario”. Il motivo del rilievo è che Sacra Scrittura, Tradizione e Magistero, considerano la differenza sessuale secondo una prospettiva antropologica ritenuta non disponibile, perché derivata dalla stessa Rivelazione divina.
- In secondo luogo, la Nota cita i commi uno e tre dell’articolo due dell‘Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana di revisione del Concordato del 1929 [Qui], siglato il 18 febbraio 1984 dagli allora presidente del Consiglio dei ministri, Bettino Craxi e segretario di Stato, card. Agostino Casaroli. Commi nei quali si riconosce alla Chiesa cattolica piena libertà di svolgere la propria missione, magistero e ministero, nonché pari libertà ai cattolici (associazioni e organizzazioni) di riunione, pensiero, parola, scritto e ogni altra forma d’espressione.La Segreteria di Stato vaticana conclude auspicando una “diversa modulazione del testo normativo”.
Fin qui i fatti, su cui è bene fare una prima sosta perché già motivo di un ampio dibattito.
Si può parlare di un fatto senza precedenti, di un passo compiuto senza, o addirittura contro, il consenso del papa, o di ingerenza sullo Stato italiano?
Innanzitutto “non è un caso eccezionale – scrive il direttore de Il Regno, Gianfranco Brunelli (22 giugno) -, tantomeno è la prima volta”. Per quanto, scrive Avvenire (23 giugno), “è un passo diplomatico piuttosto raro”.
Sul punto, però, ci sono anche i dietro le quinte raccontati dai bene informati.
Massimo Franco (Corriere della Sera 21 giugno), scrive che da tempo, fra curia e gerarchia, sarebbero in atto forti pressioni per una presa di posizione netta e dura, rispetto a una linea giudicata di eccessiva timidezza dei vescovi e del suo presidente, card. Gualtiero Bassetti. “Esponenti come l’ex presidente della CEI Camillo Ruini – scrive Franco – hanno dato voce a chi voleva un atteggiamento di netta contrarietà”.
Lo stesso Brunelli allarga l’analisi con altri elementi di preoccupazione: “qualcuno maldestramente pensa di conseguire un qualche obiettivo o interesse nell’innescare uno scontro e non modificare il DDL”. “O qualcuno nel Pd, – conclude Brunelli – partito sempre più in crisi politica, pensa di trovare la propria identità facendo di questa materia una battaglia ideologica, invece di disinnescarla, conseguendo un obiettivo equilibrato; o qualcun altro ha immaginato di utilizzare la partita di uno scontro con la Chiesa per mettere ulteriormente in difficoltà il Pd”.
Se le cose stanno così, si delinea uno scenario – diremmo di stampo statunitense – in cui la polarizzazione degli opposti prevale sullo spazio delle soluzioni: “Lo scontro salirà – avverte Brunelli – e una cosa è certa: ci faremo male un po’ tutti”.
Pare fuori luogo, poi, pensare che la Nota sia stata scritta senza il consenso di papa Francesco o, peggio, che non ne fosse a conoscenza.
Sull’ingerenza, invece, la pensa così Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Nev.it): “Una vera e propria interferenza del Vaticano”.
Secondo Vincenzo Pacillo, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico all’Università di Modena e Reggio Emilia (Huffington Post 23 giugno), “è più che un’interferenza, perché perturba il dibattito pubblico e mina il principio della laicità dello Stato”.
Tema sul quale è intervenuto in Senato lo scorso 23 giugno il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con parole che andrebbero imparate a memoria: “Laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, è tutela del pluralismo e delle diversità culturali”. Lo ha detto precisando di non voler entrare nel merito della discussione, che è prerogativa del Parlamento.Non sono sembrate solo parole di rispetto istituzionale.
In effetti, c’è stato chi – come la vaticanista Lucetta Scaraffia (QN 23 giugno), o Cesare Mirabelli, costituzionalista e oggi consigliere generale dello Stato della Città del Vaticano (Avvenire 23 giugno) – invece dell’ingerenza ha preferito porre un problema di libertà di pensiero e parola. Principio che non riguarda solo Chiesa e cattolici nel caso specifico.
E qui il problema si complica, a causa di almeno due ordini di considerazioni.
Ammesso che ci sia ancora spazio per una serena discussione (visto lo scenario di scontro che sembra delinearsi), l’obiezione vaticana sul DDL Zan, a quanto pare, non è solo questione di difendere posizioni all’insegna del conservatorismo o, peggio, di un oscurantismo anacronistico.
- Il costituzionalista Emanuele Rossi (Il Regno 10/2021) ha sollevato dubbi su alcuni passaggi chiave del testo normativo in discussione. Rispetto all’articolo 604 bis del Codice penale (che punisce reati di discriminazione e violenza per motivi razziali, etnici e religiosi), il DDL Zan allarga le fattispecie criminose a chi istiga o commette atti di discriminazione anche per motivi legati al sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità, oltre a coloro che promuovono, dirigono, partecipano o prestano assistenza a organizzazioni che, analogamente, incitano alla discriminazione o violenza per gli stessi motivi.
Rispetto al 604 bis, non risulta ampliato il reato di propaganda, ma solo quello di istigazione e qui si porrebbe il problema di rimettere al giudice il compito di definire se un atto sia configurabile come propaganda (non punibile) o istigazione (punibile). - Un secondo dubbio giuridico sarebbe l’aggiunta, per la qualificazione della particolare vulnerabilità della persona offesa, della categoria di odio fondato sulla sfera sessuale. Anche in questo caso il compito di stabilire se si è in presenza di fatti compiuti con intento discriminatorio o con odio, verrebbe affidato al giudice.
Siccome l’articolo 25 della Costituzione dice che le fattispecie di reato devono essere tassative e determinate, se le circostanze in cui si commetta violenza in ambito sessuale sono sufficientemente chiare, così non parrebbe per la fattispecie dell’istigazione.
“Mi pare – commenta l’esperto – che in questo modo si crei una sorta di labirinto nel quale dovrà muoversi il giudice chiamato a risolvere casi concreti: con qualche dubbio sulla tassatività e determinatezza – costituzionalmente necessarie – della fattispecie incriminatoria”.
Con l’aggravante che, visto il clima italico, se anche una denuncia non dovesse approdare a una condanna, “l’effetto mediatico – conclude Rossi – potrà consentire di raggiungere l’obiettivo di condanna sociale”. Tema noto nel dibattito giuridico come: “uso simbolico-espressivo del diritto penale”.
C’è poi un secondo ordine di considerazioni in ambito ecclesiale, da mettere su uno dei piatti di questa complicata bilancia.
Il riferimento è al caso scoppiato lo scorso 15 marzo, con la pubblicazione del Responsum che la Congregazione per la dottrina della fede ha dato a un dubium sulla benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso.
Sorvolando sulle critiche al documento vaticano (come ha fatto l’arcivescovo di Vienna, card. Christoph Schönborn, con il suo “non essere contento” per la risposta negativa partorita dalle Sacre Stanze), il teologo Andrea Grillo (Il Regno 8/2021), ha messo in fila alcuni temi che dentro la Chiesa toccano un nervo scoperto. Fra questi, è sempre meno sostenibile continuare a considerare il tema dell’omosessualità con sole argomentazioni teologiche, prescindendo dalle acquisizioni del mondo scientifico.
In secondo luogo, è ormai forte nel dibattito ecclesiale il bisogno di mettere mano, ad esempio, al numero 2357 del Catechismo (gli atti di omosessualità sono intrinsecamene disordinati e contrari alla legge naturale): la scienza moderna esclude che sia una malattia.
Per tornare alla Nota vaticana, l’affermazione di “una prospettiva antropologica non disponibile” in realtà da tempo è messa in discussione dalla teologia, perché progressivamente ne comprende i condizionamenti storici oltre al fondamento sulla Rivelazione divina.
Come si vede, ci sarebbe molto lavoro da fare sul tema in tutti i fronti, se solo prevalesse la volontà di cercare soluzioni, rispetto all’irrigidimento ideologico delle posizioni, ciascuno in nome della propria verità.
Cover: foto da nexquotidiano.it (licenza Wikimedia Commons)