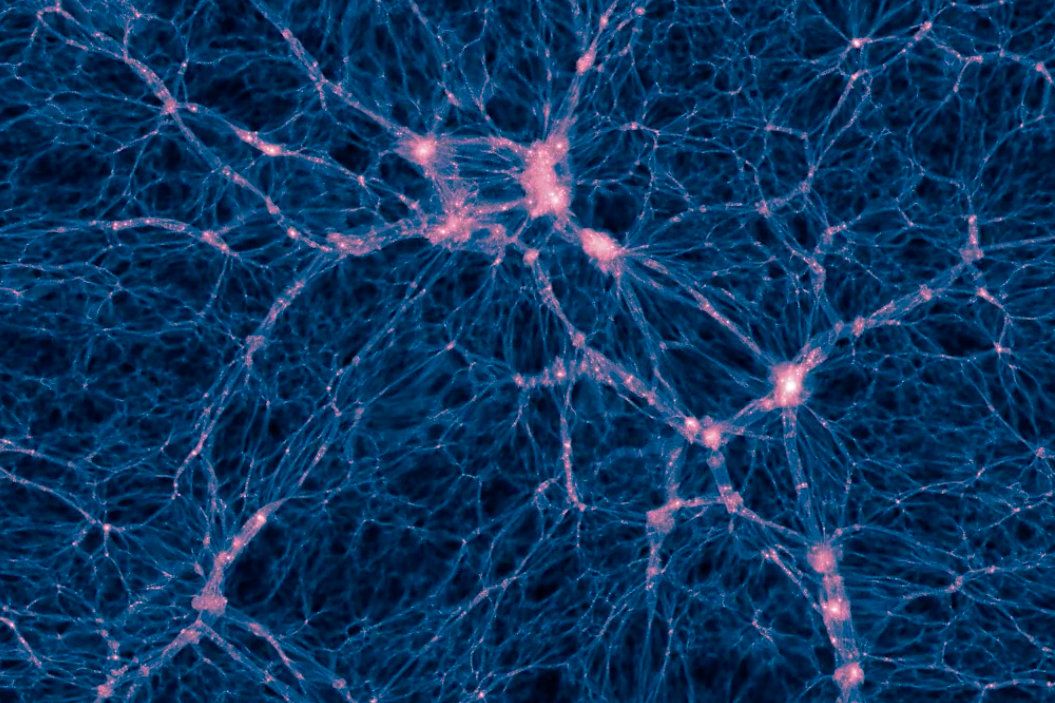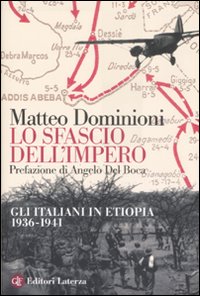PRESTO DI MATTINA
Uscì il seminatore a seminare….
Uscì il seminatore a seminare… «Ed il seme di un nuovo cielo s’interra nel freddo infinito./ È l’aurora del frutto. Quella che ci dà i fiori/ e ci unge del santo spirito dei mari./ Quella che diffonde vita sulle sementi/ e nell’anima tristezza di qualcosa di vago. È un bacio azzurro che la Terra accoglie.»(Federico García Lorca, Tutte le poesie e tutto il teatro, 366; 101; 1258).
Sono come cento sementi, ho pensato rileggendo le Cento parole di comunione di Carlo Maria Martini [Qui] nel cono di luce delle cinquanta parole García Lorca. Il testo fu scritto da Martini nel settimo anno del suo ingresso come vescovo di Milano il 10 febbraio 1980, ministero episcopale retto fino al 2002. In quella tappa del settimo anno Martini si domandava se non fosse stato possibile scrivere una Carta di comunione di intenti, non più ampia di un biglietto da visita, per dire in cento parole il cammino pastorale che stava facendo con la sua chiesa, lo stile pastorale volto a favorire l’incontro con la gente, il modo della parola di Dio di donarsi agli uomini e le donne del nostro tempo.
Non fu difficile per lui trovare una parabola di cento parole – per la precisione 98 – nel testo greco di Mc 4,3-8: la parabola del prodigo seminatore. Più di qualunque altra essa contiene infatti quello che si potrebbe chiamare un «abbozzo di antropologia pastorale». Quale uomo è incontrato dalla Parola di Dio? Chi è colui che è chiamato alla sua amicizia, a vivere l’alleanza e la comunione racchiusa in quell’invito? Divenendo uditore di quella Parola, l’uomo si scopre capace di una relazione dialogica; non terra desolata, ma capace di ospitare il seme della parola dell’altro. Per la via del linguaggio sente allora di doversi incamminare verso un ‘dove’ che non conosce ancora; chiamato fuori di sé a divenire ciò che segretamente è fin da principio, dimora degli affetti che si genereranno con la pratica dell’ospitalità che costruisce poco a poco comunione. La parola è per l’uomo la sua aurora, come il seme lo è per la terra; ed il “bacio azzurro” di cielo, che la terra riceve dal seme, è promessa di fecondità futura per l’uomo, di commensalità che sarà piena, attorno a una mensa comune, che principia allo spuntare dell’aurora quando “il seme di un nuovo cielo s’interra nel freddo infinito”.
La parabola del seminatore prodigo – letteralmente il gesto del “cacciare in avanti”, di chi “agisce avanzando”, “spinge fuori” e che in Giovanni si fa pastore che fa uscire il suo gregge, chiama ed è seguito perché riconosciuto dalla sua voce – ci interroga sullo stile della Parola che si dona senza sapere prima il suo destino. E ancor più ci chiama a comprendere il senso di uno stile pastorale, quello del Seminatore, che va incontro alla gente senza parsimonia, senza risparmio, senza selezionare prima il terreno su cui gettare il seme e verificare se sia buono oppure no.
E «il terreno – scrive Martini – è l’uomo, è l’umanità, sono i singoli uomini, è ciascuno di noi. Noi siamo terra in attesa del seme, terra ricca di potenzialità e di succhi vitali… La terra significa dunque l’uomo, la nostra gente, pronta a ricevere il seme della parola di Dio, capace di accoglierlo e di fargli produrre frutto. La terra senza seme è brulla e infruttuosa, la terra seminata può diventare un giardino rigoglioso. Accogliere la Parola significa credere. L’uomo si realizza nel credere, così come il terreno si realizza nel ricevere il seme». Noi siamo fatti allora per accogliere la Parola e portiamo frutto nella misura in cui ci rendiamo disponibili all’ascolto, a riceverne il seme. Ma non si può forzare la libertà con mezzi esteriori. Sarebbe vano piegarla con costrizione, perché ciò che viene seminato è un amore, un’amicizia, un’alleanza di comune destino che fruttifica solo nella forma di una libertà che si affida e che acconsente anche all’altro, sempre tramite la sua libertà, di donarsi.
Nel simbolo del seme entra in scena l’altro personaggio della parabola: «Il seme è la parola di Dio (Lc 8,11). Il vero protagonista di tutta la storia del campo è la Parola. La Parola seminata, la Parola calpestata, la Parola soffocata, la Parola dissipata, la Parola accolta e che mette radici nel terreno per poi germinare, fino a produrre il cento per uno. Questa Parola non è semplicemente qualcosa di estrinseco, di aggiunto all’uomo – ricorda ancora Martini – qualcosa di cui l’uomo possa fare anche a meno. Terreno e seme sono stati creati l’uno per l’altro. Non ha senso pensare al seme senza una sua relazione con il terreno. E quest’ultimo senza il seme è deserto inabitabile».
Favorire, sostenere, incoraggiare, difendere pure il rapporto con la Parola è dunque mettersi dalla parte dell’uomo, rispettarne la coscienza, come il terreno più sacro e inviolabile in cui entrare solo se invitati, in punta di pedi, con le scarpe in mano, a piedi nudi come fece Mosè avvicinandosi al Roveto ardente; «difendere semplicemente l’uomo, i suoi spazi di espressività e di relazione autentica, i suoi orizzonti di senso». Essere cristiani significa allora anche «avere riconosciuto il primato e la principalità di questa Parola. Vuol dire riconoscere che essa è attiva fin dalle origini del mondo, e che ci raggiunge e ci interpreta in ogni momento della nostra vicenda umana».
La Parola è schierata per l’uomo, spalla a spalla nella lotta della vita. Si pone in sua difesa, è suo partner, è amica e compagna amorosa nel viaggio che condurrà il seme caduto nel terreno a diventare spiga. Anche per la parola di Dio: «Quanto morir perché la vita nasca», ci ha ricordato Clemente Rebora.
Così tra semente e terreno non solo destini incrociati, ma un unico destino: «La Parola è per il terreno. La sua efficacia si manifesta non in astratto, ma nel suscitare, interpretare, purificare, salvare la vicenda storica della libertà umana. La Parola incontra e incrocia le aspirazioni dell’uomo, i suoi problemi, i suoi peccati, le sue nostalgie di salvezza, le sue realizzazioni nel campo personale e sociale». Un unico destino di umanità e santità lega la Parola a noi.
«Ma chi è questa parola?» – si domanda Martini e la sua risposta: – «è la Parola che si è fatta uomo e ha preso la sua dimora in mezzo a noi. La centralità e l’unicità di Gesù Cristo è infatti anche la “singolarità” di Gesù Cristo: cioè il suo essere non un qualunque ideale religioso, sia pure altissimo, non una personalità profetica generica, ma “questo Gesù, che voi avete ucciso – annuncia Pietro alla folla che lo ascolta nella narrazione degli Atti degli Apostoli – e che è stato risuscitato dai morti». È questa stessa Parola sprofondata nella sterilità del terreno a capovolgerne il destino, a renderlo fecondo, abitabile sino a generare in esso la risurrezione.
Scrive ancora Martini che «il vero protagonista dell’azione pastorale è dunque la Parola: tutta la storia del cammino pastorale di una comunità è la storia, non tanto delle sue realizzazioni esteriori, dei suoi raduni, dei suoi congressi, delle sue processioni o delle sue iniziative; ma quella della semina abbondante e ripetuta della Parola, e della cura affinché questa parola trovi le condizioni per essere accolta»; ed invita a praticare l’interiorità nello stile conciliare: “Tutti i cristiani apprendano la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine Scritture. L’ignoranza delle Scritture infatti è ignoranza di Cristo” (cf. Dei Verbum, 25).
Se la Parola mette radici nel cuore, nell’intimo, nel luogo delle decisioni più profonde e umane si «inizia un cammino di interiorità e di convinzioni non solo di gesti e di abitudini. I gesti e le abitudini sono utili se nascono da una convinzione interiore, la esprimono, la incarnano e la irradiano. Senza libera convinzione interiore non c’è cristianesimo. L’uomo è fatto per la Parola e trova se stesso nell’ascolto della Parola; l’uomo merita perciò il massimo rispetto e va servito con attenzione e dedizione, sempre, aiutandolo a trovare la verità di se stesso e la sua autenticità; la “contemplazione” è la dimensione ideale e necessaria per l’accoglienza della Parola: togliere sassi le spine, la dissipazione».
Presentando questo testo delle cento sementi di Martini, così scrive il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla: «Credo che tutto il magistero di Martini possa essere riassunto in questo intento: favorire il «meraviglioso scambio» (admirabile commercium) tra la coscienza e la Parola, tra il terreno dell’umano e il seme della Parola. È l’incontro in cui coscienza e Parola, terreno e seme devono perdere qualcosa per arricchirsi reciprocamente: il terreno perché deve essere dissodato e diserbato per accogliere il seme; il seme perché deve morire nel terreno della coscienza per far germogliare in esso lo stelo e il frutto».
Perché così prodigo il seminatore? Perché disperdere e scialacquatore così il buon seme? Perché gli sta a cuore l’uomo più di se stesso e non smette di seminare in lui la parola, al modo del pastore che va in cerca della pecorella smarrita, lasciando le altre novantanove con grande rischio e pericolo nell’ovile. Cento sono le pecore e non si siederà a mensa a fare festa se ne mancherà anche una sola. La risposta di Martini è questa: «La coscienza si sviluppa e si evolve in maniera misteriosa e imprevedibile. Persone su cui avevamo posto fiducia e cure che procurano amare delusioni e, viceversa, altre su cui non avremmo scommesso niente rivelano potenzialità insospettate. È per questo che la parola viene seminata dappertutto, anche sul terreno sassoso, perché qualsiasi terreno, anche il meno adatto, può dare il suo frutto. “Non esiste nessuna persona che per sua natura sia del tutto impenetrabile alla Parola”».
Uscì il seminatore a seminare, camminando sulla seta.
Già si è aperto il fiore dell’aurora …
Che infantile dolcezza
nel mattino quieto!
Gli alberi protendono
le loro braccia a terra.
Un soffio tremulo
ricopre le sementi,
e i ragni distendono
le loro strade di seta
– raggi sul cristallo limpido
dell’aria
(García Lorca, Poesie).
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]