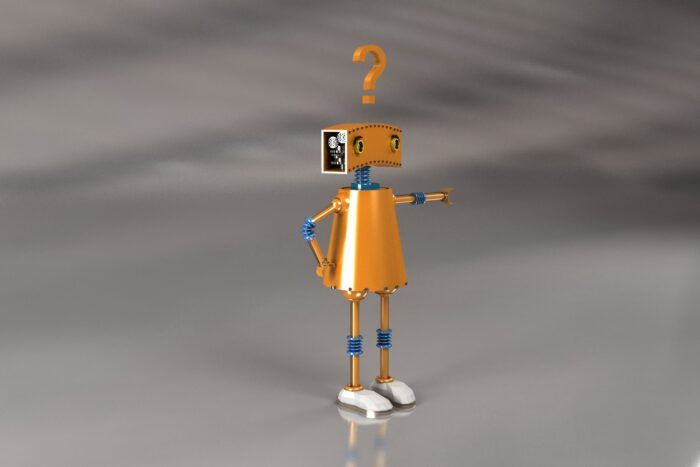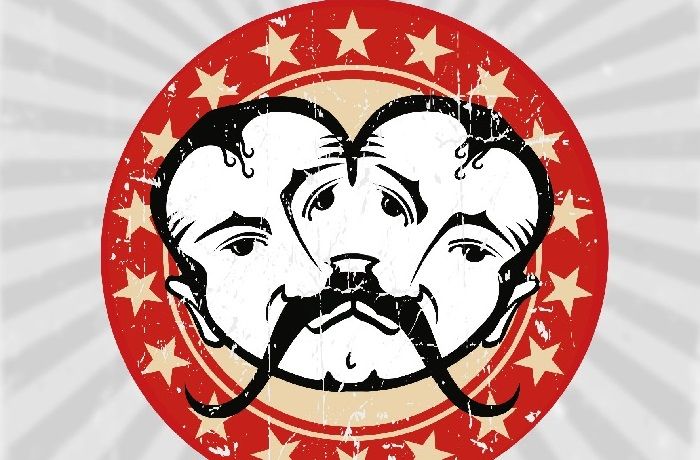“Una rosa, solo una rosa”: questo chiese Belinda al padre che partiva per un viaggio in pieno inverno, nella fiaba scritta da Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780) [Qui] e poi inserita, nella sua versione toscana, da Italo Calvino nella raccolta di fiabe italiane. Anziché un gioiello o una veste splendente, come reclamarono le sorelle, Belinda, la Bella, domandò il folle dono di un’unica rosa, un dono all’apparenza impossibile, fuori tempo, fuori stagione, fuori di questo mondo. Chiese non già qualcosa che la migliorasse dall’esterno, ma un dono per la sua interiorità: un aiuto a vedere in profondità, quello che fa percepire, oltre la facciata, l’intimo di ogni cosa, lo spirito di attenzione: unzione penetrante. Una rosa appunto, una e molteplice, intima e manifesta, una pluralità unita, inscindibile nei suoi petali e nell’unzione del suo profumo, integra nel suo centro che è recondito e dovunque. L’interiorità, come la rosa, è custode del multiforme mistero della gioia, quello che scaturisce dall’esperienza dell’amicizia e della comunione.
Così lo spirito è l’ospite che ci ospita, e l’interiorità è la dimora in cui accade una metamorfosi non diversa da quella che si sviluppa nella fiaba di Belinda. Una metamorfosi dall’insipienza, dall’inconsapevolezza, dall’insensibilità ai sensi spirituali, che diviene passaggio dall’oscurità al chiarore, dalla chiusura all’ospitalità: il riconoscimento e l’accoglienza dell’altro, del quale scoprire, al di là delle apparenze, il dono nascosto. Restituita alla chiaroveggenza dello spirito che svela in profondità il vero, il bene e il bello che apparirà solo alla fine, Belinda esclamerà «non mi sembra più un Mostro e se anche lo fosse lo sposerei lo stesso perché è perfettamente buono e io non potrei amare che lui». È la metamorfosi così giunta a compimento, rotto l’incantesimo che oscurava la visione.
Scrive acutamente Cristina Campo «La metamorfosi del Mostro è in realtà quella di Belinda ed è soltanto ragionevole che a questo punto anche il Mostro diventi Principe. Ragionevole perché non più necessario. Ora che non sono più due occhi di carne a vedere, la leggiadria del Principe è puro soprammercato, è la gioia sovrabbondante promessa a chi ricercò per prima cosa il regno dei cieli. Per condurre a tale trionfo Belinda, il Mostro sfiorò la morte e la disperazione, lavorò con la pervicacia della perfetta follia notte dopo notte, apparendo alla fanciulla reclusa, rassegnata ed impavida nell’ora cerimoniale: l’ora della cena, della musica. Chiuso nell’egida dell’orrore e del ridicolo («oltre che brutto purtroppo sono anche stupido») rischiò l’odio e l’esecrazione di quella che gli era cara: discese agli Inferi e ve la fece discendere. Non meno – e non meno follemente – fa [lo Spirito di] Dio per noi: notte dopo notte, giorno dopo giorno».
Come ogni fiaba ‒ ha osservato Cristina Campo ‒ anche questa «ci narra l’amorosa rieducazione di un’anima affinché dalla vista si sollevi alla percezione, per riconoscere ciò che soltanto merita di essere apprezzato. Percepire è riconoscere ciò che soltanto ha valore, ciò che soltanto esiste veramente. E che altro veramente esiste in questo mondo se non ciò che non è di questo mondo? L’amicizia del Mostro per Belinda è una lunga, una tenera, una crudelissima lotta contro il terrore, la superstizione, il giudizio secondo la carne, le vane nostalgie», (Imperdonabili, 11-13).
Belinda ‒ ho pensato tra me e me ‒ chiedendo quell’unica rosa, non ha forse domandato la chiaroveggenza, il dono dello Spirito “il dolce ospite dell’interiorità”, “la beatissima, luce che invade nell’intimo”? È così che lo invoca l’inno liturgico nella festa di Pentecoste. Dono dell’attenzione profonda, quella generata dal desiderio dell’incontro con l’altro; dell’intimità aperta, capace di sviluppare l’esercizio della contemplazione senza la quale ‒ direbbe Simone Weil ‒ la bellezza invocata e ricercata non può rinascere. Dono che unisce differenziando, che scruta le profondità dell’umano in cui ospitare l’altro; unzione che fa splendere e porta in piena luce i volti; rugiada che impreziosisce e rinnova la faccia della terra: “Emitte spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae”.
Invocare la venuta dello Spirito è chiedere di poter riconoscere e accogliere uno spirito di sapienza e di intelligenza, di conoscenza e di pietà, uno spirito di tenerezza e di resilienza, spirito fiducioso che crede invincibilmente all’amore e così genera speranza. È domandare di vedere con gli occhi interiori la potenza e la bellezza spirituale della Materia, del bene e del vero imprigionati nella sostanza informe o deforme, inanimata e spenta, per accorgersi dello sprigionarsi in essa del fuoco. È dello spirito sconcertare, scompigliare rimescolare, riplasmare, perché è forza e movimento di trasformazione e trasfigurazione. Egli “irriga ciò che è arido”, “sana ciò che sanguina”, “lava ciò che è sordido”, “piega ciò che è rigido”, “scalda ciò che è gelido”, raddrizza ciò che è sviato”.
«Spirito ardente, Fuoco fondamentale e personale, Termine reale di un’unione mille volte più bella e desiderabile della fusione distruttrice ideata da un qualsiasi panteismo, degnaTi di scendere, ancora questa volta, sulla fragile pellicola di materia nuova in cui oggi si avvolgerà il Mondo, per darle un’interiorità. Ancora una volta, il Fuoco ha compenetrato la Terra. Non è caduto fragorosamente sulle cime, come il fulmine nella sua violenza. Ha forse bisogno di sfondare la porta il Maestro che vuole entrare nella propria casa? Senza scossa, senza tuono, la fiamma ha illuminato tutto dall’interno. Dal cuore dell’atomo più infimo all’energia delle leggi più universali, essa ha invaso, uno dopo l’altro e nel loro insieme, ogni elemento, ogni meccanismo, ogni legame del nostro Cosmo in modo così naturale che questo, potremmo credere, si è spontaneamente incendiato», (Teilhard de Chardin, Inno dell’Universo, Milano Brescia 1992, 11; 13).
Domani è Pentecoste; la beata Pentecoste. Le celebrazioni dell’anno liturgico si sono sviluppate gradualmente secondo le esigenze delle comunità cristiane che all’inizio, la domenica, celebravano il giorno del Signore, la sua Pasqua. La celebrazione annuale della Pasqua era considerata la “grande domenica”, perché si allargava, moltiplicava i giorni come fossero un unico giorno. Essa incluse così i giorni del triduo pasquale e la settimana dell’ottava di Pasqua, per poi allargarsi in una cinquantina di giorni fino al culmine della Pentecoste: la grande domenica del Cristo risorto asceso al cielo e datore con il Padre dello Spirito. Da questa “domenica distesa” inizia il «giorno nuovo», che i Padri della Chiesa han chiamato «l’ottavo giorno» perché in esso confluiscono e trovano compimento i sette giorni della creazione e tutti i giorni del mondo a venire.
Come ricorda Alfredo Cattabiani in due suoi testi (Calendario, Milano 1993; Florario, Milano 1997) Pentecoste è chiamata anche “Pasqua delle rose”. Per questo, volendosi rappresentare visivamente la discesa dell’unico Spirito in multiformi fiammelle sui discepoli radunati con Maria nel cenacolo, in molte chiese durante la messa di Pentecoste si facevano piovere rose, fiori e talora addirittura batuffoli di stoppa accesa dal soffitto al canto della sequenza Veni, Sancte Spíritus, emítte cǽlitus lucis tuæ rádium. Così le rose diventavano raggi di luce, simboli della discesa dello Spirito che, come narra l’evangelista Luca, quel giorno si manifestò sui discepoli come lingue di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro: tanto che, pieni di Spirito santo, essi cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Doveva essere uno spettacolo unico la Pentecoste celebrata nel Pantheon a Roma nel rione Pigna durante il medioevo. Costruito come tempio dedicato a tutte le divinità pagane dell’impero, fu trasformato in chiesa cristiana con il titolo di Sancta Maria ad Martyres. Mentre il papa benediceva la gente raccolta in preghiera, dal lucernario della cupola cadevano sui fedeli una pioggia scrosciante di petali di rose.
La rosa è classificata da Cattabiani tra i “fiori dell’assoluto”: tant’è che insieme al fuoco ben si presta a simboleggiare lo spirito e la sua audacia che spera contro ogni speranza. Non diversamente dal fuoco infatti, sensibile a ogni cosa, anche lo Spirito tutto attraversa senza mescolarvisi, tutto abbraccia senza che nulla lo possa comprendere. Ma non meno pregnante è l’analogia dello Spirito con la rosa, in cui tutto converge verso il centro, un’unità che, a sua volta, si irradia ed è irradiante di una pluralità differenziata e multiforme, delicata, odorosa, dipinta nei suoi petali che sprigionano, affrettandosi lentamente, da essa come ad intenerire perfino le spine dello stelo che la sorregge.
Lo Spirito a Pentecoste è audace, coraggioso, osa l’impossibile, ardisce là dove tutto sembra perduto. Si spinge fin dentro la morte di acque putride; riapre i giochi e le sorti che erano stati decretati chiusi con sentenza definitiva: quale illusione, mi viene da pensare al cartiglio (il titulus crucis) fatto scrivere in più lingue da Ponzio Pilato e appuntato alla sommità della croce.
Non viene meno lo Spirito alla sua missione, quella di inoltrarsi intrepido e consegnarsi all’oscurità muta e ambigua dell’Avvenire, penetrando in esso «con olio di letizia invece che con l’abito del lutto, con un canto di lode al posto di un lamento» (Is 61, 1-9). Non indietreggia in questo esodo cosmico. Precorritore e ‘cursore’ nell’infinitamente piccolo, ‘vettore’ nell’infinitamente grande, ‘errante’ nell’infinitamente complesso. Egli avanza, indicando sempre la posizione di inserimento o quella del raccordo, il punto di incontro, l’arrivo e la partenza, l’orientamento e le prospettive che si irradiano da essi. Questo lo fa e rifà anche con noi, come un vasaio al tornio che non getta l’argilla deformata, ma la riplasma sempre di nuovo, con la stessa determinazione ardente con cui spinse Mosè ed il popolo ad attraversare il Mare Rosso e ad abitare per quarant’anni il deserto prima di approdare alla terra promessa; con la stessa risolutezza con cui spinse Gesù nel deserto per poi discendere su di lui come dono di consolazione, di liberazione, di perdono, di gioia trasformandolo nel Vangelo del Regno, buona notizia per le genti.
E così, è ancora lui che genera l’audacia della nostra fede, di quella fede che opera come libertà che si affida, resa capace di praticare l’abisso dell’alterità per scoprivi anche Dio: «Se uno dicesse: “Io amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede», (1Gv 4,20). Scrive ancora quel “pellegrino dell’Assoluto” che fu Teilhard de Chardin: «La Fede cristiana vi sembra lavorare nell’irreale, costruire nelle nubi? È perché, precisamente, non avete tentato di ‘lanciarvi’, sorretti da essa, nello spazio in cui, sola, essa vi permette di ‘vedere avanzando’. Il legame misterioso che correla, nella nostra anima, le facoltà di vedere e di agire, è questo: la realtà si rivela solo a coloro che sono abbastanza audaci per ‘deciderla vera’ e mettersi a edificarla in se stessi. Il Cristo ‘si sperimenta’ come tutti gli altri oggetti con l’operazione della Fede, è il Cristo stesso che appare, che nasce, senza nulla violare, nel cuore del Mondo… Ma ripetiamolo ancora una volta: “In verità, in verità vi dico, soltanto gli audaci accedono al Regno di Dio nascosto, sin d’ora, nel cuore del Mondo. Colui che, senza porre la mano all’aratro, penserà di averle intese, è un illuso. Bisogna tentare. Di fronte all’incertezza concreta del domani, bisogna esserSI abbandonati alla Provvidenza. Nella penombra della Morte, bisogna essersi costretti a non volgere gli occhi verso il Passato, ma a cercare, in piene tenebre, l’aurora di Dio: “più ci sentiamo affondare nell’Avvenire infido e oscuro, e più penetriamo in Dio”, (La fede che opera, in La vita Cosmica, Milano, 423; 425).
Domani quando pregherò con le parole del nuovo messale sul pane e sul vino dicendo «Padre santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito» cercherò di ricordare questo frammento poetico di Th. S. Eliot: «E tutto sarà bene, e/ tutte le cose saranno compiute./ Quando le lingue di fiamma si avvolgeranno/ nel coronato sviluppo di fuoco/ E il fuoco e le rose saranno uno», (Quattro Quartetti, Book ed. Ferrara 2002, 76).
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]