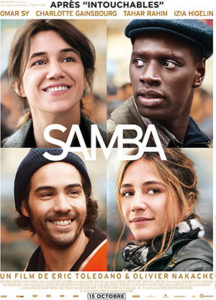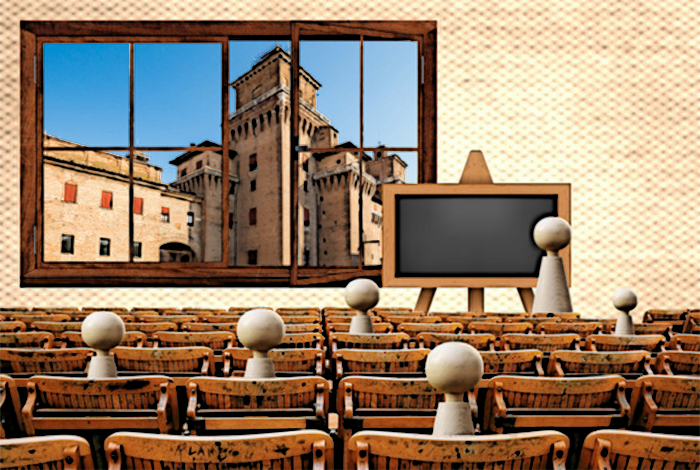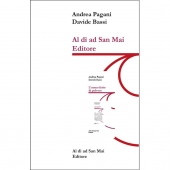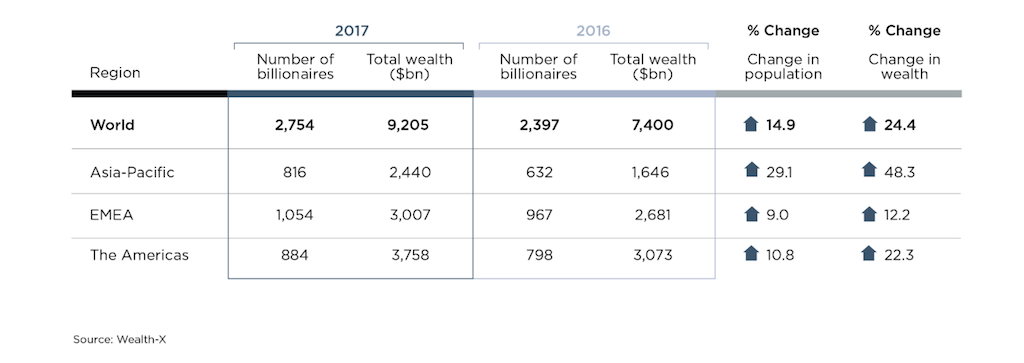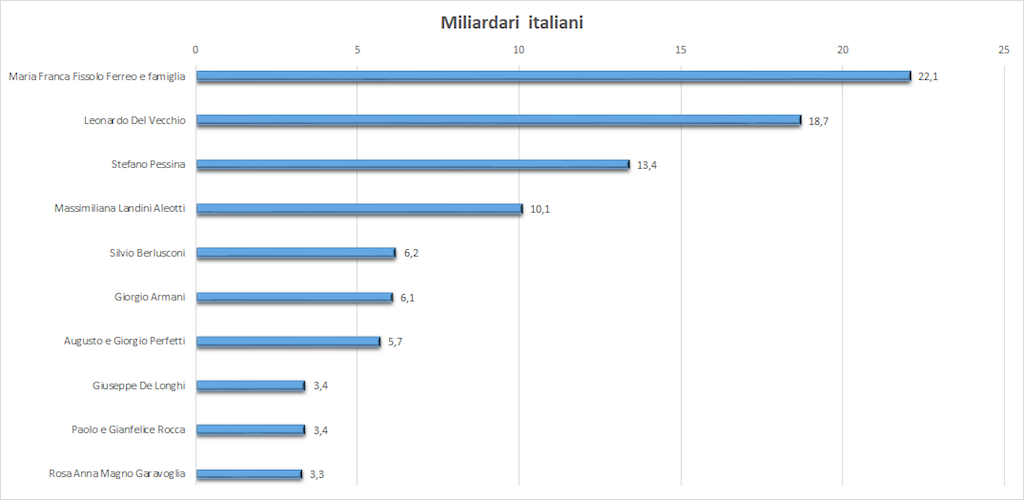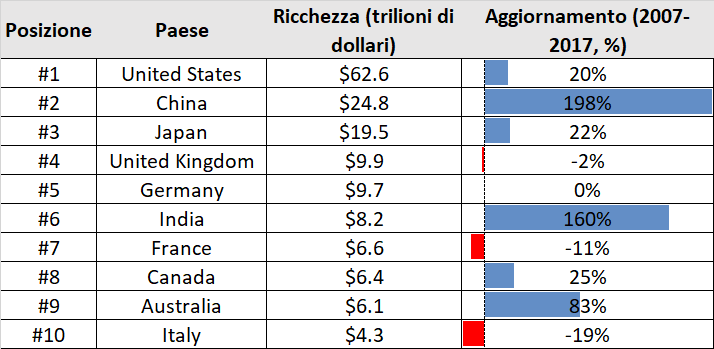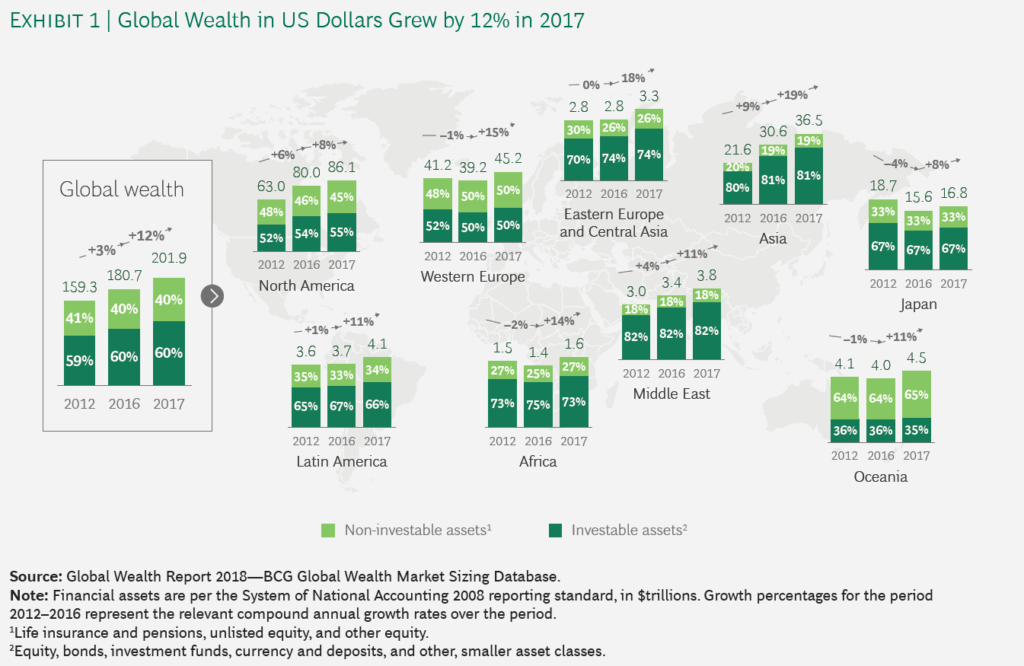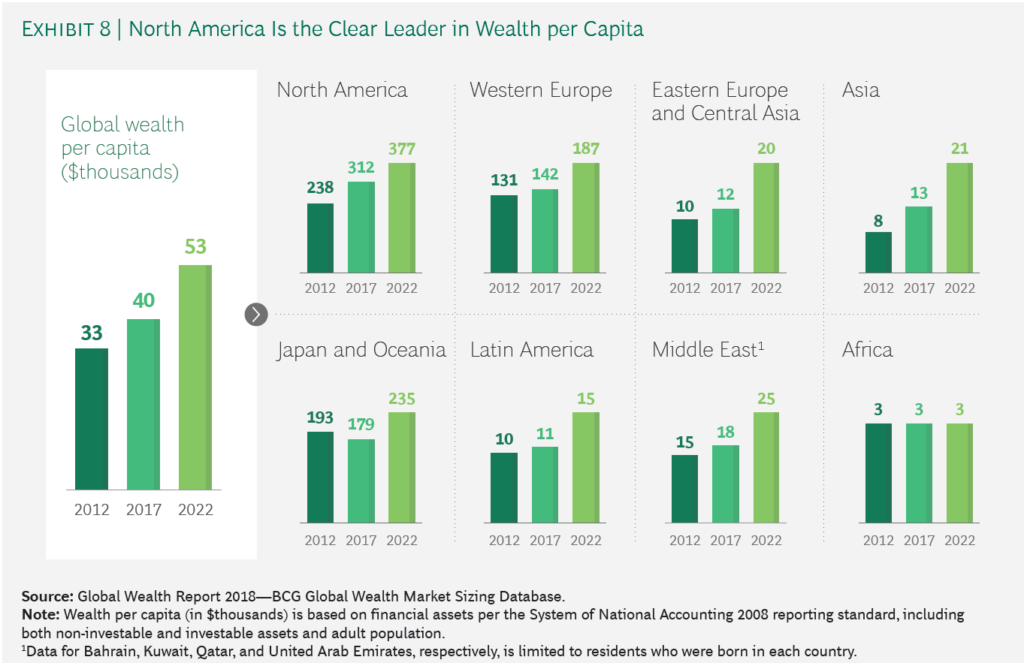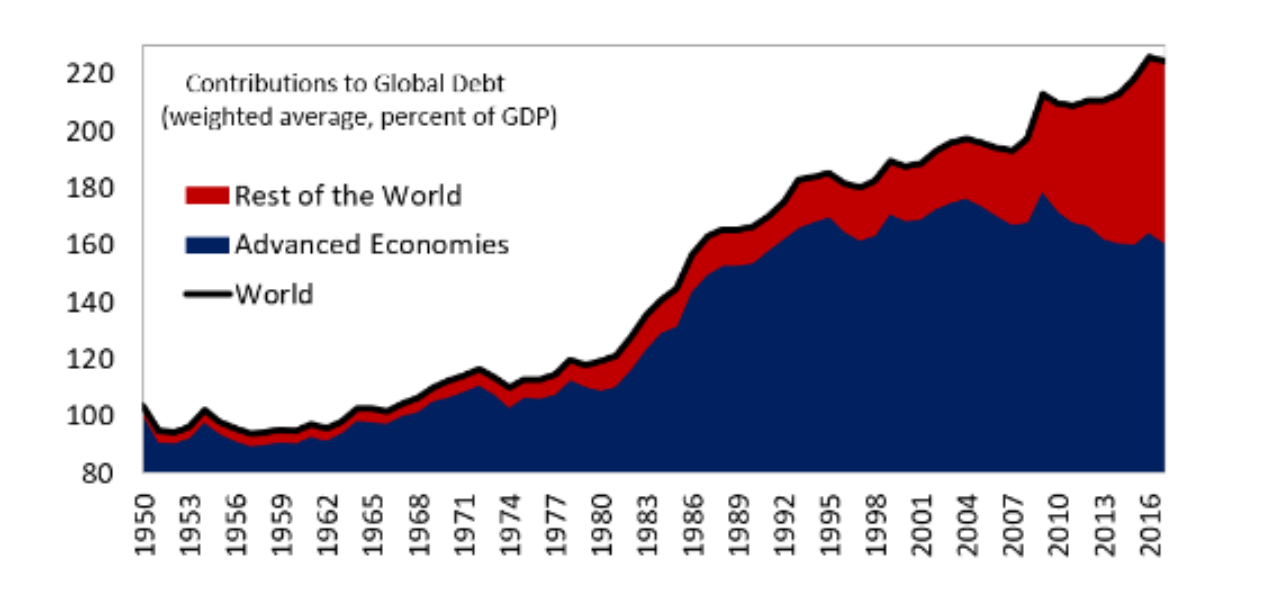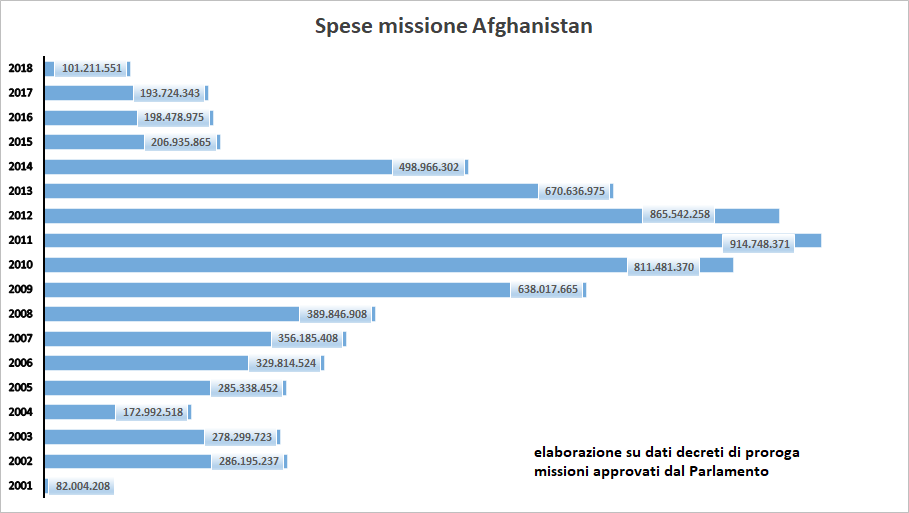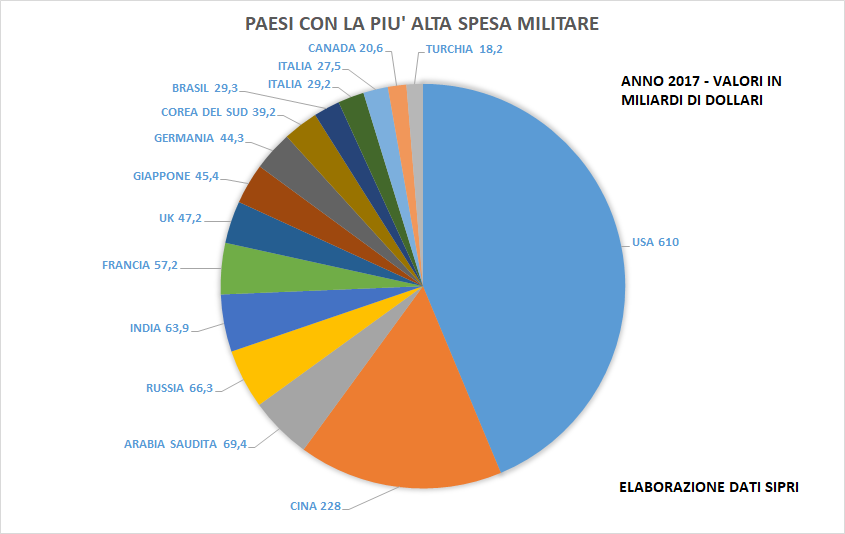di Loredana Bondi
1/SEGUE – Posso dire che ancor prima degli anni Sessanta del secolo scorso, molti Comuni hanno intercettato i bisogni dei cittadini, le loro esigenze, la sete di diritti di cittadinanza, istituendo un sistema di scuole dell’infanzia e, successivamente, di servizi educativi per i bambini in età prescolare, traghettando così i servizi rivolti all’educazione di tutti i bambini dalla sponda assistenziale a quella educativa. Ciò è potuto avvenire anche col sostegno di una Regione come la nostra, che ha contribuito alla continua qualificazione dei servizi e delle scuole dell’infanzia che ancor oggi rappresentano ‘La strada maestra’, indicata anche dalla Commissione europea, per creare comunità più solidali, giuste ed eque e, in particolare, per prevenire abbandoni scolastici futuri e collaborare ad abbattere la povertà. Ciò è accaduto anche a Ferrara: una strada seguita fin dal primo dopoguerra nella direzione della responsabilizzazione condivisa in materia dei principi fondamentali dell’educazione. La storia della scuola comunale dell’infanzia di Ferrara ‘E’ una storia che viene da lontano’ e vuole ricordare quale sia il valore sociale e culturale di scelte che hanno profondamente inciso sulla vita della città.
Per offrire alcuni cenni sull’origine della scuola dell’infanzia a Ferrara si può dire che le fonti da cui poter attingere per conoscere come questa scuola si sia sviluppata in città sono molto interessanti e servono a capire quanto, nell’arco degli ultimi due secoli, sia davvero profondamente mutata non solo la scuola, ma la condizione umana, l’attenzione e la considerazione dell’infanzia nel contesto sociale e culturale. A Ferrara si trovano documentazioni del primo Ottocento che oggi definiremmo davvero allarmanti e che riportano testimonianza della condizione di miseria della gran parte delle masse popolari costrette, pena la contrazione di pericolose malattie come il tifo o il vaiolo, alla pratica detta della ‘esposizione’ che consisteva nell’abbandono dei propri figli al brefotrofio, istituto che li allevava al proprio interno o che li affidava al baliatico esterno. L’abbandono dei bambini era un vero dramma civile e l’alternativa erano le sale di custodia. A quel tempo le classi abbienti intervennero prevalentemente a livello di beneficenza, piuttosto che giustizia sociale, perché vedevano nell’abbandono dei piccoli una grave compromissione del contesto sociale. Così si procedette a ricoverare i fanciulli nei famosi Asili della carità fino a gran parte del Novecento.
Ma per arrivare al nostro tempo, nll’immediato secondo dopoguerra, si assiste a una vera e propria lotta sociale e politica per avere i servizi per l’infanzia. E’ importante ricordare che nell’immediato dopoguerra l’Amministrazione comunale decise di provvedere alla ricostruzione del fabbricato dell’ex convento dei Cappuccini di Corso Porta Po, con l’intento di destinarlo ancora ad Asilo, impegnando allo scopo una somma consistente del bilancio comunale e, nel contempo, con l’obiettivo di gestirne l’attività direttamente. Il Comune dovette affrontare anche un grosso conflitto con l’Associazione degli Asili di Carità, che rivendicava il diritto al possesso dello stabile, ma il Consiglio comunale in data 18 marzo 1948 approvò il nuovo Regolamento per la gestione diretta della scuola, anche se l’Autorità tutoria non approvò mai il Regolamento comunale, a causa della diatriba sorta fra le due Istituzioni. La spinta propulsiva fu quella di poter avviare un servizio educativo secondo nuovi criteri pedagogici e la possibilità di fruire di consistenti aiuti economici messi a disposizione dal Dono svizzero e dal Soccorso operaio svizzero, emanazioni dei sindacati socialdemocratici elvetici che nell’immediato dopoguerra sostennero diverse Amministrazioni con finanziamenti finalizzati all’avvio di strutture educativo-assistenziali per l’infanzia. Vi fu la ricostruzione e l’organizzazione del nuovo asilo comunale per l’infanzia, sia dal punto di vista strutturale sia educativo-pedagogico.
Maria Luisa Passerini, in uno studio dedicato a questi temi, precisa che fu proprio attraverso l’opera di Fausto Poltronieri e Silvano Balboni (antifascisti esuli in Svizzera) che si arrivò a organizzare la prima scuola d’infanzia laica, sulla scorta dell’esperienza di Rimini, dove l’educatrice zurighese Margherita Zoebeli, fruendo dei fondi elargiti dalle medesime realtà elvetiche, aveva fondato nel 1946 il Ceis-Centro di Educazione Italo-Svizzero. Margherita Zoebeli sosteneva che la pedagogia e la responsabilizzazione politica stavano alla base del suo lavoro, che si incentrava sulla partecipazione e condivisione di un nuovo modo non solo di educare, ma di vivere.
Fu allora, nel giugno del 1947, che si aprirono le iscrizioni alla Casa del Bambino. Utilizzando le risorse svizzere e i contributi dello Stato, il Comune riuscì a riattivare una parte dello stabile di Corso Porta Po e, nell’agosto del 1947, fu aperto l’asilo come istituzione comunale, amministrata con propri organi e con la vigilanza di una apposita commissione nominata dal Consiglio comunale.
Le autorità scolastiche e politiche ferraresi ed estere che visitarono l’istituto e lo videro in funzione concordarono sul fatto che era una delle migliori esperienze del genere, meritevole senz’altro di essere additata a modello per altri comuni.
E’ proprio in questo periodo, sul finire del 1948, che Luisa Gallotti in Balboni viene eletta assessora alla Pubblica Istruzione di Ferrara con delega alla Pubblica Istruzione e Arte. Diverrà poi, nel 1950, prima donna Sindaco in Italia. La sindaca si batterà per avere la scuola materna comunale.
Nel 1949, con il coinvolgimento dell’Udi, vennero aperti due centri estivi e Luisa Balboni si adoperò per ripristinare le strutture scolastiche gravemente danneggiate dalla guerra e per la costruzione di nuovi edifici, così come per il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche, offrendo ai bambini la refezione scolastica e il servizio estivo.Luisa Gallotti Balboni prese in esame anche la necessità di assistenza medica dei bambini per seguirne la crescita nelle fasi più importanti dell’età evolutiva. Furono realizzati sei ambulatori scolastici che periodicamente registravano le condizioni di sviluppo dei bambini. Sul piano degli interventi a favore dell’infanzia la sua opera fu davvero lungimirante, perché a Ferrara non esistevano scuole per l’infanzia se non le poche private, gestite, sia pure con buona volontà, con gravi carenze strutturali e didattiche dalle suore di alcune congregazioni religiose. Il miglioramento della condizione dell’infanzia a Ferrara fu un preciso obiettivo anche dell’Udi. Nell’immediato dopoguerra, infatti, fu tra le associazioni cui le autorità dell’Italia liberata, le commissioni di controllo alleate e successivamente le strutture governative e le Amministrazioni locali fino al 1947, avevano riconosciuto un ruolo fondamentale nella gestione dell’assistenza soprattutto rivolta all’infanzia. La scuola materna, ovvero il ‘giardino d’infanzia’ come amavano chiamarla le donne dell’Udi, era ritenuta il settore dell’organizzazione scolastica in cui direttamente si collegavano due funzioni essenziali dell’epoca moderna: l’educazione e l’assistenza sociale. Proprio l’Udi, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando le donne ferraresi si recavano nelle risaie del vercellese per lavorare come mondine stagionali, con i pochi fondi comunali, riuscì a organizzare i campi estivi per i loro figli che restavano a casa.
Dall’agosto del 1947 fino al novembre 1961, la Casa del Bambino restò l’unica scuola materna in città gestita dal Comune, con una capienza ricettiva da 150 a 280 bambini. L’ubicazione centrale della scuola limitava fortemente l’accoglienza dei bambini che risiedevano nel forese, per cui tra gli anni Cinquanta e Sessanta, le richieste delle famiglie e delle organizzazioni sociali furono pressanti, affinché il Comune estendesse il servizio anche nelle zone limitrofe alla città. Alla fine del 1961 comincerà a funzionare la prima scuola materna del forese, quella di Bova di Marrara a una sezione, seguita da Fondoreno. Il primo plesso scolastico costruito dal Comune come scuola materna fu la scuola intitolata a Ada Marchesini Gobetti nel quartiere di via Bologna, seguita dalla materna Dina Bertoni Jovine nel Quartiere Barco. Fu solo fra gli anni Settanta-Ottanta che si diede il via alla destinazione di scuola materna a nuovi locali delle scuole elementari, soprattutto nel forese, e a nuove costruzioni, accogliendo complessivamente 1.138 bambini nell’anno scolastico 1971/72 e 2.248 nell’anno 1976/77. A livello politico c’era una seria disponibilità a rispondere alle esigenze di una società che chiedeva risposte in termini di quantità e di qualità nuovi servizi educativi. La scuola materna comunale fu un’esperienza di vera cittadinanza attiva anche grazie all’investimento nella formazione in servizio del personale e alla nascita del coordinamento pedagogico.
Proprio attorno agli anni Sessanta anche a Ferrara si sostenne la necessità di una nuova legge sulla scuola materna pubblica, di “una scuola statale”, ma anche dei Comuni, delle Province, delle Regioni, una legge che fissasse gli ordinamenti e desse ai Comuni i necessari finanziamenti per istituire una rete generalizzata di scuola d’infanzia gratuita e aperta a tutti i bambini. Occorre ricordare il valore delle testimonianze e dell’impegno per una scuola dell’infanzia per tutti i bambini di Immacolata Basteri, assessore alla pubblica istruzione, di Rossana Lugli dell’Udi, di Maria Luisa Passerini, direttrice delle scuole d’infanzia comunali di Ferrara.
La Basteri sosteneva che l’obiettivo era una scuola finanziata dallo Stato e gestita dai Comuni, basata sulla concezione di vera democrazia, indissociabile dalla problematicità della scuola. Una scuola intesa come diritto del cittadino e dovere dello Stato, giacché collocata nel momento più importante della vita del fanciullo, dove il primo momento di scolarizzazione era inscindibile dall’intero percorso della scuola, perché necessario a fornire un’educazione psicolinguistica, quale strumento prezioso per la conquista della conoscenza, dell’uso del linguaggio e della scoperta della socialità. Tracciando le linee del servizio offerto dal Comune di Ferrara, denunciò la pressoché totale assenza dell’impegno dello Stato in materia di istituzione della scuola d’infanzia.
Rossana Lugli dell’Udi denunciò la presenza a livello provinciale di vaste aree assolutamente scoperte in termini di scuola materna, mentre laddove esisteva, veniva identificata con l’asilo parrocchiale e, nel suo insieme, la condizione socio educativa appariva gravemente deprivata. Ribadì la richiesta di Ferrara del riconoscimento della scuola comunale dell’infanzia come “scuola pubblica” giacché l’impegno del Comune era molto qualificato (dalle 12 sezioni di scuola materna esistenti nel 1962 era previsto il passaggio a 49 sezioni, offrendo così il posto nella scuola dell’infanzia a circa 2.000 bambini). Maria Luisa Passerini, in un convegno nazionale tenutosi a Modena nel 1973, tracciò dettagliatamente la situazione della scuola materna ferrarese: a Ferrara la scuola materna offriva circa 2.310 posti e, calcolando che la domanda alla materna copriva circa l’80%, se ne ricavava che sulla popolazione infantile in età, restavano fuori ancora circa 1.300 bambini. Richiamò il diritto di tutti i bambini ad accedere alla scuola d’infanzia e sostenne che la presenza della scuola d’infanzia comunale, oltre al significato incisivo che viene ad assumere per la sua consistenza, acquista anche contenuti qualitativamente nuovi. Era convinta che i bambini, attraverso il percorso educativo della scuola dell’infanzia, sarebbero stati “il veicolo di chiarificazione delle realtà sociali, ambientali, economiche e questa realtà organizzativa si diffonderà negli adulti, che ne prenderanno coscienza e la porranno come problema che dovrà ottenere positive soluzioni”. Di qui la necessità di presenza nell’organo di gestione sociale oltre al personale della scuola, anche delle rappresentanze dei consigli di quartiere, dei sindacati, degli organismi rappresentativi. Sostenne che una scuola dell’infanzia per tutti deve avere anche un altro obiettivo: apertura e accoglimento dei bambini handicappati sensoriali e psichici per consentire loro il diritto a socializzazione e scolarizzazione e non già l’emarginazione sociale come di fatto avveniva.
L’inizio del cammino verso la piena qualità della scuola dell’infanzia avviene negli anni fra gli anni Ottanta e Novanta, anni di una feconda ‘complicità educativa’, quando si assiste alla vera espansione di tutta la scuola dell’infanzia, perché anticipando le disposizioni nazionali, il Comune di Ferrara sostiene la validità del sistema scolastico integrato, definendo fin dal 1995 anche precise convenzioni con le scuole materne private presenti sul territorio. Negli anni 2000 il Comune arriva poi a fare un’importante scelta politico-gestionale: l’istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie, costituita al proprio interno da Servizio Infanzia (Nido e Scuola d’infanzia), Servizio Diritto allo Studio e politiche per l’integrazione e Servizio Politiche familiari e genitorialità. Una scelta che ha inteso coniugare l’efficienza con l’efficacia per la qualità del sistema educativo. Tutti i servizi rivolti all’infanzia in relazione fra loro per un unico progetto educativo. Una scuola dell’infanzia che si fa promotrice di cultura con le tante esperienze che contano per la qualità dei servizi a cominciare dalla formazione permanente tra progettualità, creatività e documentazione.
Nasce il Centro di documentazione pedagogica dell’Istituzione del Comune di Ferrara, ‘Raccontinfanzia’, che si caratterizza come punto di riferimento a livello di documentazione per il contesto socio educativo territoriale. Tantissimi i progetti, le ricerche, gli studi, gli incontri e le mostre, i percorsi formativi condivisi con le scuole d’infanzia e servizi educativi integrativi a livello cittadino e provinciale. Decisamente importanti i rapporti a livello regionale gli scambi pedagogici, i molti percorsi di formazione oltre agli interessanti rapporti internazionali. Tanti i percorsi formativi, da quelli di pratica educativa, psico- pedagogica, a quelli in ambito artistico, ai percorsi realizzati dal Centro servizi e consulenze dell’Unità operativa integrazione sui temi della disabilità e disagio e altri ancora realizzati dal Gruppo condotto dalla responsabile dell’Unità operativa stranieri sui temi dell’integrazione di bambini e famiglie di origine straniera.
Leggi QUI la prima parte
2. CONTINUA