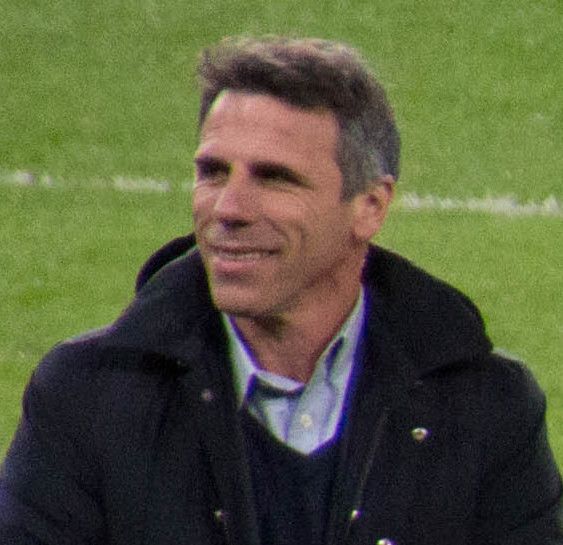Scrive Gregory Bateson: “Dice il proverbio che quelli che abitano in una casa di vetro, soprattutto se vi abitano con altri, dovrebbero pensarci bene prima di tirarsi dei sassi; e penso che sia opportuno ricordare a tutti gli occidentali che leggeranno questo saggio che essi vivono in una casa di vetro… In altre parole, noi tutti abbiamo in comune un groviglio di presupposizioni, molte delle quali hanno origini antiche. A mio parere, i nostri guai affondano le radici in questo groviglio di presupposizioni, molte delle quali sono insensate. Invece di puntare il dito contro questa o quella parte del nostro sistema globale , dovremmo esaminare le basi e la natura del sistema .”.
Vorrei provare, in merito al tipo di testimonianza che potrebbero offrire oggi i cattolici nella vita politica, proprio ad addentrarmi in quel «groviglio di presupposizioni, molte delle quali sono insensate», «molte delle quali hanno origini antiche», che induce quotidianamente a “tirarci dei sassi”, incolpandoci gli uni gli altri dei «nostri guai», senza accorgerci che il mondo della politica in cui viviamo tutti insieme è una fragilissima «casa di vetro» e che oggi necessita e più che mai invoca a gran voce un significativo progetto di liberazione. .
Da un punto di vista storico, fino al 1993 la Democrazia Cristiana ha rappresentato il partito di riferimento principale per i cattolici italiani.
Due elementi ascrivibili agli ultimi decenni del XX secolo poi hanno impedito oltre quella data alla Dc di continuare a detenere questo ruolo egemone all’interno dell’elettorato cattolico.
Da un lato la caduta del muro di Berlino nel 1989 e la disintegrazione dell’Impero sovietico, hanno fatto venire meno il potentissimo collante ideologico anti comunista. Dall’altro le inchieste milanesi di Mani Pulite dell’inizio anni Novanta hanno avuto un ritorno devastante sull’opinione pubblica, all’interno della quale si è arrivati all’ identificazione di una immagine di partito formato da soli corrotti e corruttori.
Il 18 gennaio 1994 segna la data dell’atto di costituzione di un nuovo partito, il PPI, con segretario Martinazzoli. Abbiamo quindi assistito da lì in avanti ad una sorta di ‘diaspora cattolica‘, con la creazione sia a destra che a sinistra, di tutta una serie di fondazioni e successivo scioglimento, di nuovi gruppi ,partiti, movimenti di ispirazione cattolica la cui ricostruzione però esula dagli intenti di questo scritto.
L’impegno dei cattolici in politica oggi
Dal Non éxpedit (in italiano: “non conviene“), disposizione della Santa Sede con la quale nel 1868 si dichiarò inaccettabile che i cattolici italiani partecipassero alle elezioni politiche del Regno d’Italia e, per estensione, alla vita politica nazionale italiana, il cammino fatto dalla Chiesa in merito all’impegno dei credenti nelle cose del mondo si è evoluto in modo sostanziale.
Non potendo qui riportare tutte le tappe di tale percorso desidero richiamarne il punto di arrivo conclusivo, estrapolandolo però da un documento che, pur non occupandosi in modo diretto di tale questione, riassume magistralmente i caratteri principali su cui oggi la Chiesa legge il suo rapporto con il mondo e conseguentemente la relazione dei credenti con la politica. Si tratta del Discorso di Papa Francesco alla Curia Romana tenuto in occasione degli auguri natalizi del 21 dicembre 2019 .
Il punto di partenza di tale documento è il riconoscimento che “quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali”. Si sottolinea quindi che “l’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento”.
A tal fine viene suggerita una modalità decisamente innovativa rispetto alla tradizione:
”Noi dobbiamo avviare processi e non occupare spazi: Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio li cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non bisogna privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa. Da ciò siamo sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi”.
Nel documento si prende atto della fine di una epoca, l’epoca in cui esisteva il mondo cristiano da una parte e un mondo da evangelizzare dall’altra: “Adesso questa situazione non esiste più… Nelle grandi città abbiamo bisogno di altre mappe, di altri paradigmi, che ci aiutino a riposizionare i nostri modi di pensare e i nostri atteggiamenti: Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata.“.
E infine il richiamo all’ultima intervista del Cardinal Martini, fatta a pochi giorni dalla morte, non lascia alcun dubbio interpretativo sul senso della riflessione fatta nel documento e sulla direzione da prendersi:
«La Chiesa è rimasta indietro di duecento anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la fiducia, il coraggio. […] Solo l’amore vince la stanchezza»”.
Sono affermazioni queste di una portata ‘politica’, nel senso dell’etimo greco del termine, straordinaria, in continuità senza dubbio con la direzione tracciata a suo tempo dal Concilio Vaticano Secondo, ma direi ancora più potenti oggi, poiché parlano direttamente all’uomo del terzo millennio e ad una società diversa da quella a cui si rivolgevano i padri conciliari.
La direzione dell’impegno della chiesa e del credente è chiaramente leggibile in questo documento, ma desidererei renderla ancora più evocativa affiancando una immagine metaforica tratta dal Mito della caverna narrato nel settimo libro de La Repubblica di Platone.
In estrema sintesi il Mito della caverna descrive la condizione di uomini incatenati in un antro sotterraneo e costretti a guardare solo davanti a sé delle ombre, riflesso di immagini di oggetti che si muovono alle loro spalle. Platone ipotizza che uno di loro riesca a liberarsi dalle catene e quindi a vedere le ombre per quel che sono, a risalire poi all’apertura e poter ammirare lo spettacolo scintillante delle cose reali. Ovviamente lo schiavo vorrebbe rimanere sempre là, a godere di quella grande bellezza, ma invece decide di tornare dentro la caverna per liberare i compagni, correndo il rischio di non essere creduto.
Platone intende far riferimento indubbiamente al ritorno del filosofo – politico, il quale se seguisse il suo solo desiderio, resterebbe a contemplare il vero, e invece superando il suo desiderio, scende per cercare di salvare anche gli altri: il vero politico, secondo Platone, non ama il comando ed il potere, ma usa comando e potere come servizio per attuare il bene.
Non esiste liberazione se non c’è liberazione anche dell’altro.
Saper ascoltare…
Volendo riassumere in un parola sola tutte le modalità dell’impegno politico del credente, utilizzerei il significato originario di quel “saper ascoltare “ spiegato dal professor Umberto Curi nel suo saggio La porta stretta: “Il verbo ascoltare deriva dal greco akounein e nella Bibbia viene utilizzato non soltanto per significare prestare attenzione, ma soprattutto per invitare ad aprire il cuore e mettere in pratica ciò che si è ascoltato.”
Questo ascoltare profondamente è tipico dell’uomo di fede. e non potrà mai essere separato da quella dei bisogni del prossimo.
Se l’impegno politico del credente vuole essere lievito, se vuole essere non un elemento di divisione ma di unione, se vuole essere una ulteriore possibilità per l’altro, allora questo impegno deve essere coraggioso, credibile e creativo.
Ed ecco che una partecipazione coraggiosa, credibile e creativa al progetto di liberazione per il nostro tempo deve essere in grado di rimettere in discussione per lo meno tre antinomie classiche inerenti all’impegno politico del cristiano:
la contrapposizione individuo-comunità, l’opposizione corpo-spirito, il rapporto Chiesa istituzione-popolo.
Per quello che riguarda la prima,quella tra individuo/comunità ,bisogna subito ricordare che è stato il cristianesimo ad introdurre nella cultura occidentale il primato dell’individuo, sconosciuto infatti sia alla tradizione giudaica dove l’alleanza era tra Dio e il suo popolo, sia alla cultura greca dove alla polis, alla sua salvezza e alle sue leggi, era da subordinare l’interesse individuale. E’ il cristianesimo ad introdurre la salvezza individuale dell’anima: da Agostino in poi la scissione tra individuo e società sarà un suo elemento caratterizzante . E’ questo principio che ha consentito alla Chiesa per secoli di subordinare la politica alla propria visione del mondo. Ma se ascoltiamo il mondo secolarizzato, oggi il rapporto, paradossalmente. si è invertito: il principio del primato dell’individuo introdotto dal cristianesimo, è diventato nel nostro tempo il principio che i cittadini di uno stato laico invocano per esercitare diritti di scelta individuale inalienabile in tema di fecondazione, di fine vita, di unioni civili…fondando così il primato della politica sull’ingerenza ecclesiastica
Il rapporto quindi individuo – comunità deve essere ripensato, poiché oggi non è più sostenibile una salvezza individuale che prescinda da quella collettiva, come ci ha fatto toccare con mano questa ultima emergenza sanitaria. Se esiste il tribunale della coscienza individuale a cui sempre potersi appellare, questa deve tenere conto di una coscienza collettiva a cui rispondere ad esempio in tema di responsabilità ambientale, fiscale, sanitaria e culturale.
Se Antigone, l’eroina della tragedia di Sofocle, da un lato viene presa a modello della difesa di un diritto naturale, di una legge sacra non scritta superiore alle leggi dello Stato, dall’altro ci dobbiamo domandare se è condivisibile la sua scelta di togliersi la vita in nome di quelle idee, ponendo così un ostacolo insormontabile alla possibile apertura di un confronto a causa del suo gesto diventata impossibile.
Solo l’ascolto profondo e reciproco del ‘mondo’ e della ‘fede’ può portare a creare soluzioni inedite dove per entrambi il fine ultimo deve essere comunque il Bene dell’uomo.
Il confronto sulla seconda antinomia, corpo/spirito , può partire dall’ acquisizione del principio per cui in uno Stato laico le decisioni sul corpo, quelle che riguardano il vivere e il morire, appartengono ai singoli cittadini. “La regola è quella del consenso, dunque della volontà liberamente manifestata da ciascuno”, come ha scritto Stefano Rodotà in un articolo su Repubblica del 2006.
Al fine però di non permettere la degenerazione di tale principio di autonomia della volontà, in una gestione dell’esistenza dominata da imperativi del consumo e dal narcisismo, serve oggi più che mai dimostrare che le decisioni autonome sul corpo non comportano necessariamente l’appiattimento su una concezione della vita di tipo meramente materialistico, ma che esiste una sua dimensione spirituale non oscurantistica, dove rinuncia, empatia, perdono, sopportazione, dolore possono essere accolte e condivise con dignità.
Infine per introdurre la terza antinomia Chiesa /popolo può essere utile tornare al recente episodio dell’allontanamento di Enzo Bianchi dalla comunità di Bose.
Questa dolorosa vicenda ha messo in luce tutta la difficoltà che ha ancora oggi la Chiesa nel gestire in modo efficace le relazioni conflittuali. Per un’autorità ecclesiale che si impone con criteri di tipo gerarchico piramidale non opponibili e che allo stesso tempo auspica rapporti interpersonali improntati al principio dell’amore evangelico e del servizio, il rischio di mandare messaggi contraddittori, di doppio legame, è altissimo.
Qui la riflessione nelle organizzazioni ecclesiali è carente. Dovrebbe essere fatta finalmente una analisi seria sui meccanismi di esercizio del potere sia a livello di istituzione ecclesiastica, ma anche a livello di rapporti interpersonali, dove invece ci troviamo di fronte ad un vuoto conoscitivo sostituito, a seconda dei casi, da raccomandazioni alla preghiera, dall’azione dello Spirito, dall’obbedienza se non dal silenzio, soluzioni che non possono evitare incomprensioni nei fedeli e profonde lacerazioni nelle comunità.
“Non siamo migliori”
Se l’impegno politico all’interno di un progetto condiviso di liberazione viene esercitato, a vantaggio dell’intera comunità per la destrutturazione di tutti i meccanismi e le posizioni di potere, allora perde di senso la difesa del proprio particulare, dell’identità specifica cattolica da salvaguardare per esempio nella scelta dei candidati politici, o nelle scelte etiche e culturali…anche perché “non siamo migliori”.
“Non siamo migliori” è l’adagio coniato da Enzo Bianchi fin dai primi anni di vita comunitaria, per sottolineare bene, nel nostro agire, i limiti della nostra umanità; e significativamente è anche il titolo dell’ultima comunicazione della comunità di Bose del 19 giugno scorso, dopo l’applicazione del decreto di allontanamento dello stesso Bianchi.
Illuminante rimane infine sulle modalità di tale impegno politico uno scritto del’43 di don Primo Mazzolari nel passaggio in cui afferma:
“Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri…ci impegniamo senza pretendere che altri si impegni con noi o per suo conto, come noi o in altro modo…ci impegniamo senza giudicare chi non si impegna… Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro…non ci interessa il successo, né di noi stessi né delle nostre idee…ci interessa perderci per qualche cosa che rimarrà anche dopo che noi saremo passati”.
Cover: foto di Sergio Cebotari