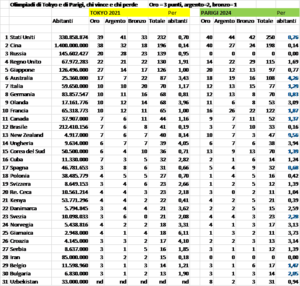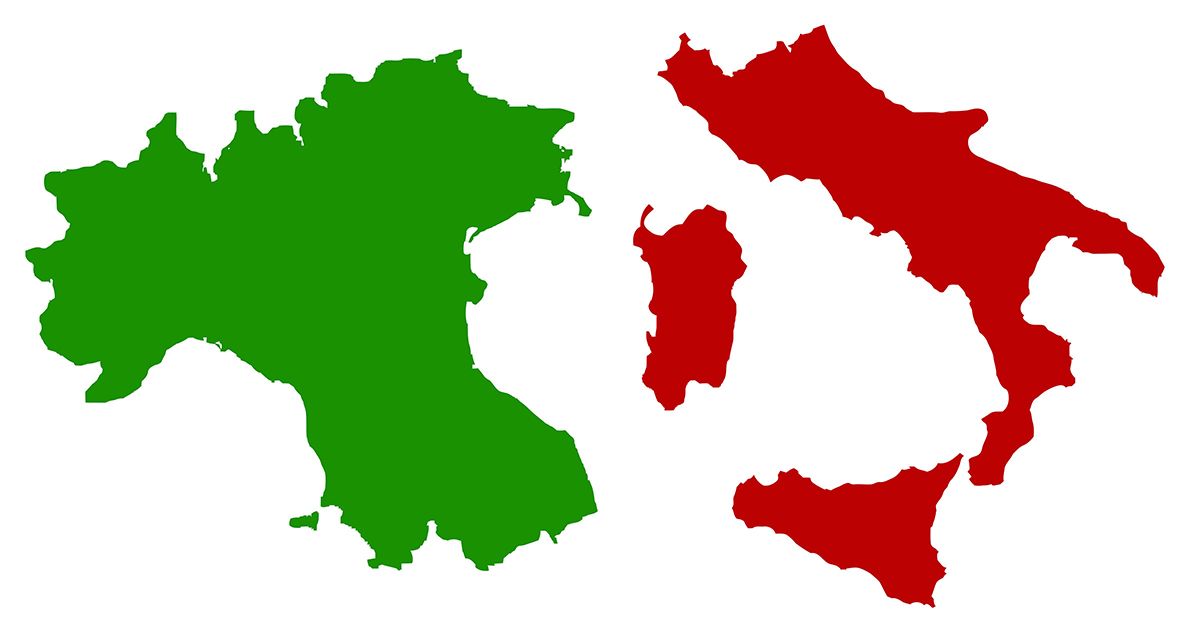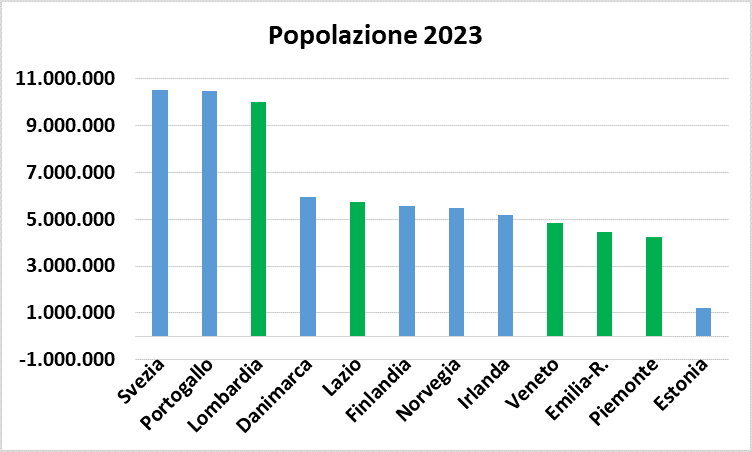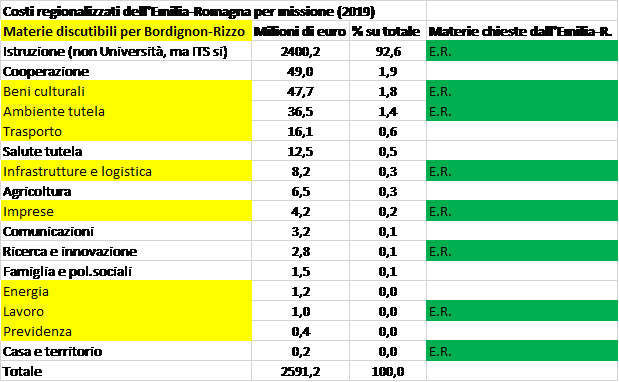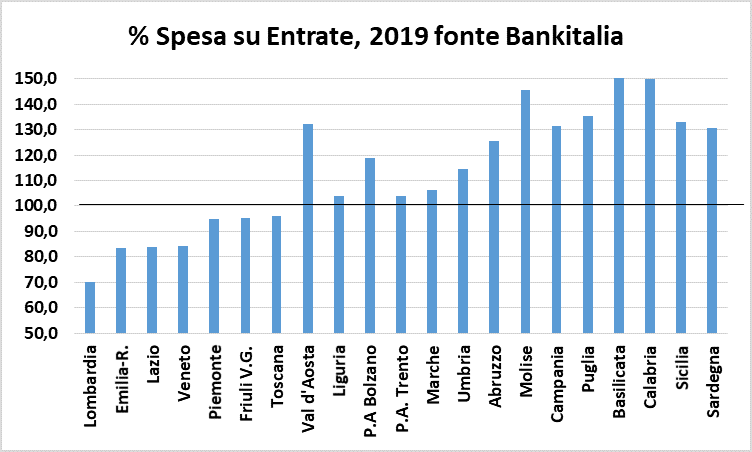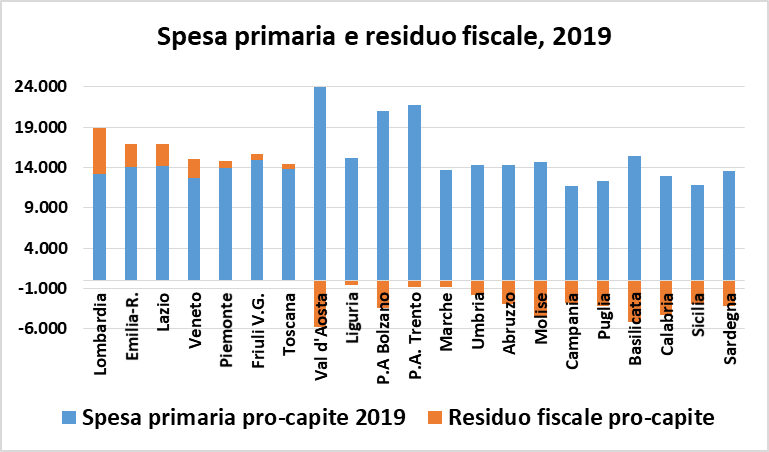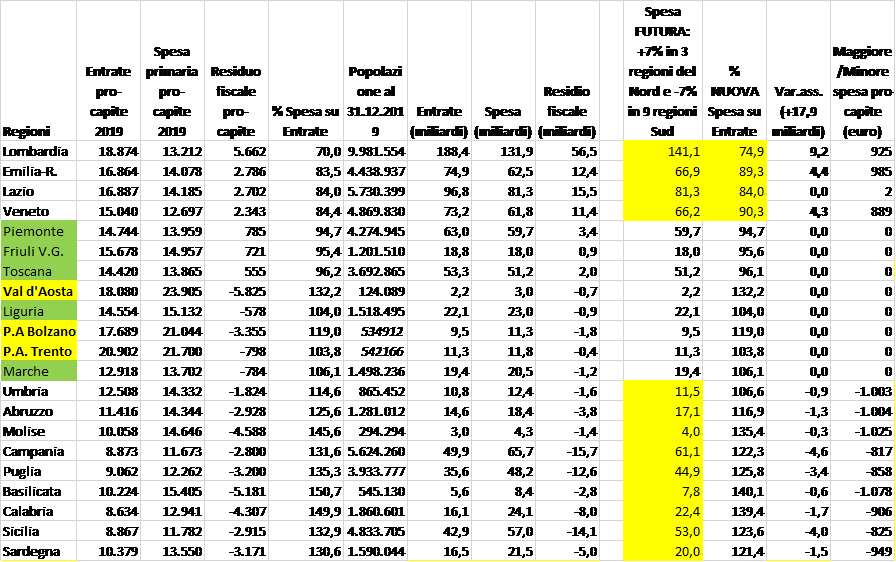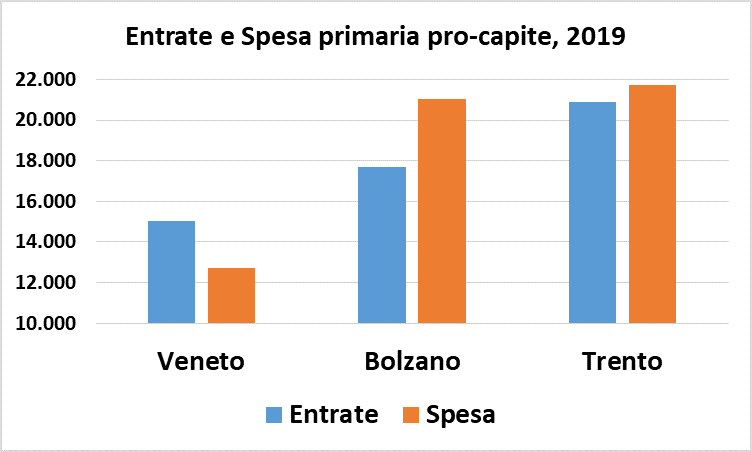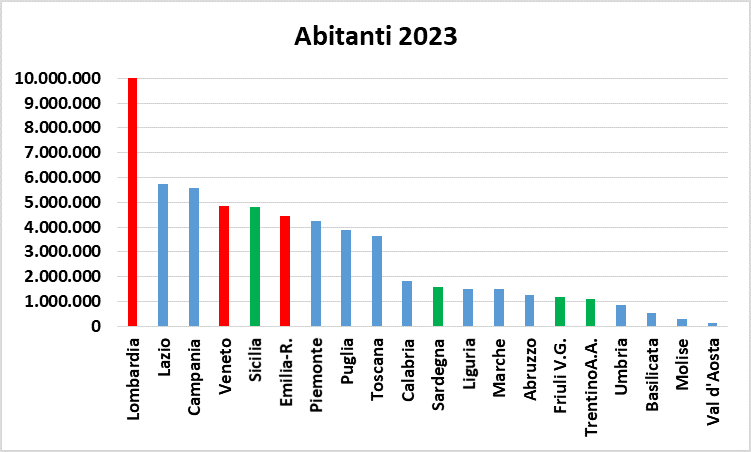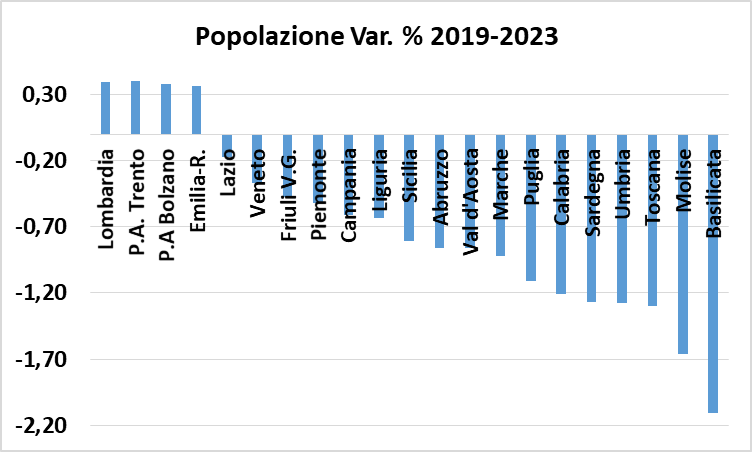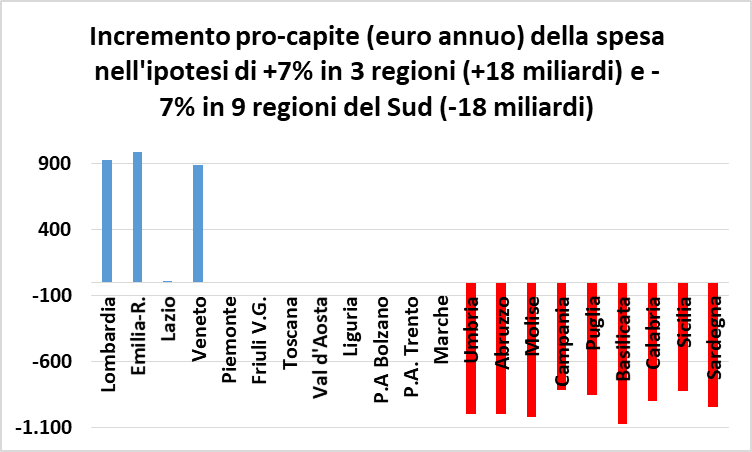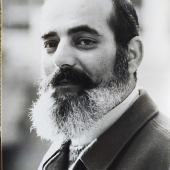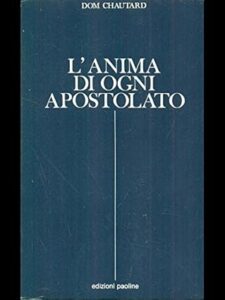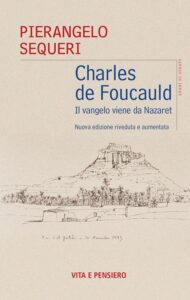Presto di mattina. L’amicizia apostolato primordiale
Gli amici di sempre
In questi giorni la liturgia ci ha ricordato gli amici di sempre di Gesù, quelli più nascosti, silenziosi, riposanti, vivandieri. Quelli posti – verrebbe da dire – dietro le quinte del Regno dei cieli, anche se sommamente presenti perché sempre pronti a ospitarlo nei momenti decisivi, difficili della vita di Gesù.
Sono quelli che assumono lo stesso stile di Maria di Nazareth, la Madre, silenziosa e pur presente, a differenza degli altri amici che riempiono di continuo la scena quotidiana della vita di Gesù, sempre in primo piano ad ogni pagina del vangelo, tanto da risultare invadenti: i dodici apostoli.
Il riferimento è, come s’intuisce, agli amici di Betania, i cui nomi sono noti: Marta, Maria e Lazzaro. Gli stessi che nel racconto della morte di Lazzaro l’evangelista Giovanni indica come «amati» da Gesù (Gv 11,5). E usando il verbo “agapào” anziché − come ci si aspetterebbe − “philèo” (i.e.: amore di amicizia), Giovanni vuole sottolineare l’amore della più grande intensità, quello che induce persino a dare la vita per i propri amici (Gv 15, 13).
Questi tre, chiamati per nome da Gesù più volte, sono chiamati fuori dai loro ritiri e chiusure: la casa, l’affanno del fare, il lutto, il sepolcro. Ciascuno a suo modo, ci testimoniano i tratti essenziali dell’Amico e confidente: Marta, attraverso le pratiche dell’ospitalità, vive l’amicizia come servizio, dedizione all’altro.
Maria esprime la propria amicizia attraverso l’ospitalità dell’ascolto e della custodia della parola di Gesù, mentre Lazzaro fa della sua amicizia un affidamento (il suo nome significa colui di cui Dio si prende cura; Dio ha aiutato il povero) e perciò vive in confidente attesa dell’arrivo dell’Amico, anche quando è in ritardo sulla morte e sembra non esserci più niente da fare, ormai stretto e avvinto dalle fasciature funerarie.
L’amicizia fa abitare gli uni negli altri in un movimento di amore. È un andare e venire, un perdersi per ritrovarsi. Non è un caso che il verbo dimorare e rimanere torna spesso nel vocabolario di Giovanni proprio per esprimere lo stare dinamico di Gesù nel Padre suo e quello dei discepoli con Lui al modo della vite e dei tralci. E Marco annota: «Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli – perché stessero con lui e per mandarli a predicare», (3,14).
Non sorprende allora che Aelredo di Rievaulx (1110-1167), un monaco cistercense che scrisse un testo sull’amicizia spirituale, abbia intrepretato le parole di Giovanni “Dio è amore” (1Gv 4,16) con “Dio è amicizia e colui che rimane nell’amicizia rimane in Dio e Dio in lui”.
Inviati dall’Amico: l’apostolato silenzioso dell’amicizia
Apostolato è una parola non più molto usata, rispetto alla quale si preferiscono oggigiorno termini come evangelizzazione e azione pastorale. Connotato storicamente con diversi significati, l’apostolato divenne una forma di ministero strutturato gerarchicamente nella diversificazione dei compiti tra clero e laicato per la diffusione della fede cristiana nel mondo. Apostolo significava infatti originariamente colui che è inviato da un altro, e apostoli erano per l’appunto gli inviati a vivere il vangelo tra la gente.
Mutando la coscienza ecclesiale circa la missione della chiesa in rapporto al mondo contemporaneo, il Concilio cominciò a ripensare l’apostolato in termini diaspora. La presenza dei cristiani nel mondo oggi è paragonabile a una goccia nel mare direbbe Michel de Certeau, una voce tra tante.
E Karl Rahner sottolineava il cambio di paradigma missionario, in forza del quale ogni cristiano è inviato, in ragione del vangelo, alla gente. Per questo la sua presenza nel mondo è posta sotto il segno di una dispersione, «diaspora» appunto.
In questo tempo che segue la modernità, l’oggetto della fede è stato come sottratto, svuotato dal suo rivestimento, disperso con il conseguente frammentarsi ed entrare in crisi del corpo ecclesiale e delle sue “autorità”, istituzionali, sacramentali, liturgiche. I cristiani così sono tenuti «a vivere in mezzo ad una cultura, ad uno Stato, ad una politica, ad un’economia, ad una scienza, ad un’arte per nulla affatto ispirata al solo cristianesimo, questo costituisce certamente una sfida all’apostolato» (K. Rahner, Missione e Grazia, Roma 1964, 42).
Da dove ripartire?
Un assist ci può venire dai tre amici di sempre, inviati da Gesù a testimoniare nelle pratiche quotidiane l’apostolato silenzioso dell’amicizia. Sta nella pratica dell’amicizia come legame di amore con l’altro, che è ascolto, cura, fiducia che sa attendere tempi e momenti dell’altro, la condizione stessa della credibilità del vangelo, direi l’anima irrinunciabile ad ogni incontro del vangelo con la gente.
È, d’altronde, lo stile stesso dell’amicizia di Gesù che libera e fa passare dalla condizione di servi a quella di amici, da estranei a confidenti dell’intimità del Padre suo: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv. 15,15).
L’idea amica, vivere sotto lo sguardo dell’Amico
L’anima di ogni apostolato: è questo il titolo di un famoso libro, un classico della spiritualità, dell’abate trappista Jean-Baptiste Chautard (1958- 1935) scritto nel 1930 mai così attuale, che circolava quando ero in seminario. Un invito ad andare alle radici interiori dell’apostolato, visto come un fenomeno di esuberanza spirituale e personale, come un atto di amore traboccante, amicizia spirituale che si effonde in testimonianza e azione tra la gente.
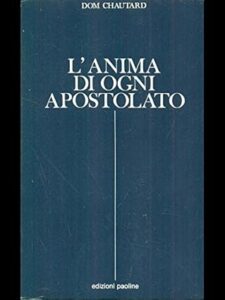 Come l’amico, così l’apostolo vive sotto lo sguardo dell’Amico: «che è diventato il principio e lo scopo di tutta la loro attività; la fede ne fa scoprire la presenza e l’amore in tutti i luoghi e in tutti i tempi. La persona viva e presente di Cristo è diventata l’idea-forza, l’idea-amica, l’elemento dinamico della loro vita.
Come l’amico, così l’apostolo vive sotto lo sguardo dell’Amico: «che è diventato il principio e lo scopo di tutta la loro attività; la fede ne fa scoprire la presenza e l’amore in tutti i luoghi e in tutti i tempi. La persona viva e presente di Cristo è diventata l’idea-forza, l’idea-amica, l’elemento dinamico della loro vita.
L’idea-amica è ben diversa dall’idea-fissa, che è un’ossessione da cui non si riesce a liberarsi. L’idea-amica è stabile, perché ci si ritorna continuamente per un bisogno del cuore. È un’idea-forza, perché è il frutto d’una volontà libera e cosciente e perché spinge a grandi realizzazioni.
Il cuore dà all’intelligenza una capacità d’intuizione irraggiungibile dalla sola ragione. L’idea-amica è un’attenzione semplice, perseverante, gioiosamente voluta e continua, verso la persona di Cristo, le sue parole, la sua azione. Invece di affaticare, dà coraggio e moltiplica le energie. È uno sguardo del cuore amorosamente fisso su Gesù», (Dom Chautard, L’anima di ogni apostolato, Cinisello Balsamo [Mi] 1987, 55-56).
Cisterne non canali
Senza contemplazione non vi è amicizia vera e duratura, così come senza cisterne dalle acque profonde e chiare i canali – anche quelli delle comunicazioni in chat – restano all’asciugato, inariditi, screpolati. Scrive Dom Chauthard ricordando san Bernardo: “Purtroppo, oggi abbiamo tanti canali nella Chiesa, ma poche cisterne. Coloro che contengono per noi l’acqua del cielo sono sospinti dalla smania di darla prima di riceverla. Sono molto più disposti a parlare che ad ascoltare; sono ansiosi di insegnare ciò che non hanno imparato, e bruciano dalla voglia di guidare gli altri, quando non sono capaci di dirigere se stessi” (Serm. in Cant., 18,3 ).
Lo stesso san Bernardo dava questo consiglio al papa Eugenio III: “Non è saggio chi non lo è innanzi tutto per sé stesso. Chi è saggio per sé è veramente saggio, e berrà per primo l’acqua del suo pozzo. La tua meditazione cominci da te e, meglio, essa finisca in te; e dovunque spazia, richiamala perché porti frutti di salvezza…
L’apostolato attivo non deve essere altro che lo straripamento d’una vita d’unione con Dio. La predicazione, l’insegnamento della dottrina, l’organizzazione delle attività educative, caritative e sociali deve sgorgare dalla fonte della contemplazione. Prendi esempio dal Padre supremo di tutti, che invia il suo Verbo e lo conserva in sé stesso. Il tuo verbo è la tua meditazione, che non si deve assentare quando esce. Fai in modo che proceda senza uscire; che parta senza andarsene», (ivi. 65-66).
Così l’immobilità e la sterilità di esperienze e comportamenti ecclesiali anche attuali dànno da pensare perché tendono ad inaridire ed irrigidire persino le formule dogmatiche e dottrinali sorte invece per annunciare e animare la Vita della vita.
Pensava così anche don Milani
«Quelli che si danno pensiero di mettere nei loro discorsi ogni pie’ sospinto le verità della fede sono anime che reggono la fede disperatamente attaccata alla mente, e lo reggono con le unghie e coi denti, per paura di perderla, perché sono interiormente rosi dal terrore che non sia proprio poi tutto vero ciò che insegnano. Ogni nuova idea, ogni nuovo governo, ogni nuovo libro, ogni nuovo partito li mette in allarme, fanno pensare alla psicosi del crollo che si è diffusa dopo il crollo di Barletta. Gente sempre col puntello in mano accanto al palazzo, che sono incaricati di custodire e della cui solidità dubitano.
Non potrei vivere nella chiesa neanche un minuto se dovessi viverci in questo atteggiamento difensivo e disperato, io ci vivo e ci parlo in assoluta libertà di parola, di pensiero, di metodo, di ogni cosa. Se dicessi che credo in Dio direi troppo poco, perché gli voglio bene, e capirai che voler bene a uno è qualcosa di più che credere nella sua esistenza!!! E così di tutto il resto della dottrina». (Lettera del 10 novembre 1959, a Giorgio Pecorini).
L’amicizia: apostolato primordiale
In questo tempo di transizione epocale non bisognerà forse ripartire con un altro stile di comunicazione del vangelo, quello scaturente dall’amicizia? Non è questa la forma dell’apostolato primordiale, di segno gesuano: “vi ho chiamati amici”? Il vangelo non viene forse dall’Amico?
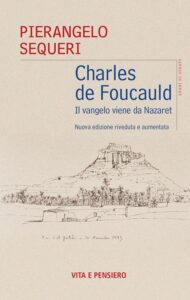 Figura di valore di questo apostolato primordiale, quello di un’amicizia generativa di fraternità – l’amore fraterno non è forse il cuore stesso del vangelo? – figura di valore è stato Fratel Charles de Foucauld (1858-1916). Scrive Pierangelo Sequeri di lui: «De Foucauld mi appare infatti come uno dei profeti dell’esilio meno chiassosi e più incisivi che siano stati destinati da Dio alla nostra contemporaneità ecclesiale La sua fu – letteralmente – voce nel deserto, che preparava con prodigioso anticipo la condizione che è nell’accadere delle cose, qui e ora» (P. Sequeri, Charles de Foucauld. Il vangelo viene da Nazaret, Vita e pensiero, Milano 2022, 11).
Figura di valore di questo apostolato primordiale, quello di un’amicizia generativa di fraternità – l’amore fraterno non è forse il cuore stesso del vangelo? – figura di valore è stato Fratel Charles de Foucauld (1858-1916). Scrive Pierangelo Sequeri di lui: «De Foucauld mi appare infatti come uno dei profeti dell’esilio meno chiassosi e più incisivi che siano stati destinati da Dio alla nostra contemporaneità ecclesiale La sua fu – letteralmente – voce nel deserto, che preparava con prodigioso anticipo la condizione che è nell’accadere delle cose, qui e ora» (P. Sequeri, Charles de Foucauld. Il vangelo viene da Nazaret, Vita e pensiero, Milano 2022, 11).
Così la prima forma evangelizzatrice la troviamo nella stessa prossimità di Gesù alla nostra umanità è fatto di noi, il legame di amicizia con lui è già figura primordiale dell’“apostolica vivendi forma”.
Mandato dal vangelo a diventare amico di un popolo abbandonato, perché è così che si «diventa del paese», che si diventa «così avvicinabile» da tutti, e «così piccolo» in mezzo a tutti, frère Charles scriverà il 13 agosto 1905: E tu, tu sei a Tamanrasset come il povero». (Opere spirituali. Antologia, Fabbri editori, Milano 1998, 29-30).
Alla cugina Maria scrive: «Non tormentatevi nel vedermi solo, senz’amici, senz’aiuti spirituali; non soffro affatto di questa solitudine, la trovo dolcissima; ho il Santo Sacramento, il migliore degli amici, a cui parlare giorno e notte, ho la Santa Vergine e san Giuseppe, ho tutti i santi; sono felice e non mi manca niente» (ivi 286).
L’espressione apostolato primordiale è di René Voillaume (1905-2003) un prete francese attratto in un primo tempo dai missionari Padri Bianchi operanti in Algeria. Dopo la lettura della biografia di padre de Foucauld, scritta da Hervé Bazin, si sentì chiamato a seguine le sue tracce e lo stesso stile apostolico, tanto che nel 1933 fonda insieme con alcuni discepoli la prima comunità dei Piccoli Fratelli di Gesù, ispirata agli scritti e alla vita di frère Charles.
Amicizia: “admirabile commercium”
Così egli riassume la spiritualità dell’eremita del Sahara: «“Presenza a Dio, presenza agli uomini”. Vi è in lui un senso profondo della preghiera, una ricerca appassionata del Cristo: tutta la sua vita si riduce ad uno sguardo fisso sul suo “Bene amato Fratello e Signore Gesù”, ad un commercio di amicizia con Lui…
 Questa presenza non ha nulla che s’imponga, ma è una amicizia che si offre; non esclude nessuno, poiché egli è il “Piccolo Fratello universale”; essa è particolarmente tenera per i più piccoli, per i più poveri, i più abbandonati. In questo contatto con gli uomini, Padre di Foucauld trova un alimento per la sua vita di unione a Dio; non ha egli forse il dovere di credere, di sperare, di amare per tutti coloro ch’egli porta nella sua preghiera, e la cui grande miseria è di essere privi di fede, di speranza e di carità? Una tale spiritualità quanto è adatta all’apostolo» (R. Voillaume, Come loro, Paoline, Roma 1953, 7-8).
Questa presenza non ha nulla che s’imponga, ma è una amicizia che si offre; non esclude nessuno, poiché egli è il “Piccolo Fratello universale”; essa è particolarmente tenera per i più piccoli, per i più poveri, i più abbandonati. In questo contatto con gli uomini, Padre di Foucauld trova un alimento per la sua vita di unione a Dio; non ha egli forse il dovere di credere, di sperare, di amare per tutti coloro ch’egli porta nella sua preghiera, e la cui grande miseria è di essere privi di fede, di speranza e di carità? Una tale spiritualità quanto è adatta all’apostolo» (R. Voillaume, Come loro, Paoline, Roma 1953, 7-8).
Per far comprendere che quella di fratel Charles era una forma di apostolato, anche se così diversa da quelle conosciute in quel momento storico della chiesa, René Voillaume scrisse un piccolo libretto, L’apostolato dell’amicizia e la vita di preghiera in padre de Foucauld (Edizioni Corsia dei Servi, Milano 1958), in cui chiariva come la via dell’amicizia fraterna dei Piccoli fratelli e sorelle di Gesù tra la gente, il carisma stesso del loro ispiratore, esprimesse l’apostolato primordiale, la fonte di ogni apostolato.
Charles de Foucauld «va a vivere in mezzo agli uomini e tuttavia non vuole usare i mezzi ordinari di evangelizzazione e di apostolato. Se è vero che il primo comandamento di Gesù è quello dell’amore fraterno, non si avrà il diritto di dire che ogni azione, ogni parola, ogni modo di essere o di vivere che contribuisca a diffondere nel mondo l’amore fraterno, che contribuisca a insegnarlo e a farlo praticare è un vero apostolato, soprattutto se una tale predicazione dell’amore fraterno è fatta attorno all’eucarestia in nome di Gesù e per lui solo?», (ivi, 13).
Aprire gli occhi su ciò che sta in principio: “Verbum caro factum est” (Gv 1, 1; 14)
Allora come oggi nel nostro tempo constatiamo ancora di più fenomeni laceranti dell’umanità. Le divisioni e le ostilità tra i popoli sono in aumento e sono dovute – come già sottolineava Voillaume – non solo alla lotta tra le classi, ma anche ai nazionalismi: «che raramente sono stati così vivi, vi sono i pregiudizi razziali che sembrano esacerbarsi e vi è la rivolta che serpeggia nella maggior parte dei paesi coloniali. Bisogna aprire gli occhi e consentire a guardare le cose in faccia».
Così «non ci si può contentare di assegnare come primo scopo all’apostolato l’amministrazione dei sacramenti dimenticando che bisogna prima dare la vita dello spirito, la fede. La, vita secondo il Vangelo è l’atto di un uomo libero, ed è difficile insegnare agli uomini ad amarsi, a rinunciare a se stessi, è difficile insegnare agli uomini a pensare cristianamente. Non conviene dunque affermare che impiantare la carità in nome del Cristo nel cuore degli uomini è un apostolato primordiale? Importa forse vedere fino a che punto deve arrivare questo amore di cui Gesù ha fatto l’essenza del suo messaggio» (ivi, 14; 15).
Che cosa mi attendo dalla chiesa?
Che metta in atto ancora una volta un rinnovamento dell’amicizia nella forma dell’amore più grande; che ripresenti al vivo Colui che da ricco si fece povero per noi perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà (Cf. 2Cor 8,9).
Scopo della carità – ricorda ancora Voillaume – non è quello di dare delle cose, ma manifestare e infondere amicizia: «Forse abbiamo dato il nostro tempo e la nostra vita, ma senza pensare abbastanza a dare noi stessi in una vera e umile amicizia» (ivi, 17-18).
«Oggi sembra soprattutto che si attenda dalla Chiesa un rinnovamento dell’amicizia che deve esistere tra tutti gli uomini. Ora il bisogno più importante a cui dobbiamo rispondere attualmente non è forse di contribuire, a sopprimere le divisioni tra gli uomini e di lottare contro tutti gli odi? Su questo punto siamo capaci di rispondere all’attesa del secolo? Se l’umanità che non crede più in Dio, se l’uomo razionale e ateo è più avanti su altri punti, non lo è forse, temo, anche in questo campo?
…Bisogna essere scesi nel cuore del povero, nel cuore delle razze dette inferiori per capire tutto il doloroso complesso di cui soffrono. Vi è più facile intravvedere ora perché Padre de Foucauld ha voluto mettere i suoi Piccoli Fratelli in condizioni di vita che facilitassero la realizzazione di una tale amicizia.
…Io penso che sia apostolato lo spogliarsi e il restare volontariamente in una tale condizione di povertà da poter dimostrare con i fatti che è possibile un’amicizia vera, profonda, in parità con i più poveri» (ivi, 22- 23).
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.