Coblas di via Colomba
3. Tre stanze in via Colomba
Tempo di lettura: 4 minuti
Coblas di via Colomba. 3. Tre stanze in via Colomba
In questa casa, vedi, in queste stanze. Tre, due più una terza aggiunta poi, con una porta in un muro tramezzo. In queste stanze che vedi ora. Le imposte di legno, gli inquilini degli anni e delle decadi. Ora che è pieno di auto, di motori, che ogni piazza è un parcheggio e pure qui, in piazzetta Colomba, in piazzetta Muzzina; ora che non c’è più la piccola prostituzione nei vicoli, verso via della Concia, ora che i camion dei traslochi, ora che i bus, ora che cavalli azzurri e ippogrifi e stese di dehors, ora che techno fino a notte, ora che sembra tutto in svendita, ora guarda, al Capo delle Volte, la vastità del cosmo dentro porta.
Questa casa in cui visse Penelope, con un baule di taccuini e mappe; e poi la figlia di Giuseppe, Sara, il suo compagno Omar e Sirio, il loro figlio. In questa casa passò anche Leone, di passaggio tra Bologna e Venezia – non però quella volta in gennaio, quando alle Fondamente Nove guardò i cipressi, l’isola di San Michele, il futuro sottile come alghe.
In queste stanze diventate tre, la rastrelliera con le bici dove era l’orto, a metà aprile si fermò la Gabri: stette una settimana e con suo marito visitò Ferrara, Mesola e Pomposa. Guarita dal covid prima ondata, due mesi in ospedale – la vicina di letto nel frastuono, con la testa nel casco, nel marasma – Gabri che recitava il Rosario in latino, un’idea che le venne per la fede, per la voce, per la forza del cuore e le antenate, un’idea che forse anzi certo la curò e forse giovò anche alla vicina, ma certo che le giovò, la guardava senza sentirla, la testa dentro il casco e la guardava.
In questa casa stiamo un po’ al riparo, all’ombra. A pochi passi c’era, ci fu per anni, la rivendita di bassa macelleria. E poco più lontano l’ingrosso dei detersivi, un labirinto di cartoni con scritte grandi dove noi, molti di noi, imparammo a leggere. E lì nella piazzetta si fermò Elena, con addosso un tailleur bruciato e ghiaccio, e Ida molti anni dopo: ma assieme guardarono il cantone, la piazzetta di là. Quasi un campiello veneziano, qualcosa che il ricordo non contiene.
E al numero ventidue viveva Marta, che aveva nove anni quando i suoi le gettarono nel fuoco il sillabario – che lavorasse subito e da subito – ma poi diventò maestra e socialista.
Allí, león, allí furia del cielo,
te dejaré pacer en mis mejillas;
allí, caballo azul de mi locura,
pulso de nebulosa y minutero
Autunno del 1929: Federico García Lorca è a Manhattan, alla Columbia University. Furioso verso il capitalismo, grandi industrie e iniquità e sfruttamento, come in un grido di orrore si butta a scrivere, scrive come un pazzo, scrive Poeta en Nueva York. Penelope ha ancora un quadernetto, da allora, e anche una giacca appartenuta a Marta.
Da qui al Castello, ai Diamanti, alla Giovecca, da qui a ovunque pochi passi.
Al Borgo dei Leoni, al vecchio ghetto, da qui poca distanza.
Ed eccola, Penelope, sarta e tessitrice. Vicina a García Lorca a Nuova York, supplente a scuola al Delta del Po. Penelope in cartoleria, in via Contrari, e in treno nei feriali tra Ferrara e Bologna.
Eccola che cammina verso la stazione alle sei del mattino, zaino leggero, da porta san Giovanni mezz’ora di buon passo, il vuoto verde di piazza Ariostea poi i Diamanti, passi e ancora passi, poeta in porta Po – pochi minuti in più se vai per la Giovecca e quando avvisti le torri, il grattacielo, ecco sei già in stazione.
Penelope che sta a Porta san Giovanni, che lavora a Bologna a Porta Lame, e il treno i viali i portici le scivolano addosso. Il male lo conosce, e la fatica, e uno scatto di gioia indistruttibile. Ha un taccuino e una giacca nell’armadio, una giacca con fodera a quadretti, la cucì la zia Maggio tanti anni fa.
Siamo qui, siamo tante. Da secoli e millenni siamo qui.
E a dispetto dell’epica, della leggenda dello stratagemma, delle storie sulla paziente attesa, Penelope ha da fare e non aspetta.
Non Odisseo. Non Ulisse, nessuno. Non un uomo di nome Nessuno.
Tessere viene prima.
La tela è nata molto tempo prima.
La tela e la stoffa, andare e tornare, moto apparente moto pendolare, ordito e trama, Porta Lame stazione Porta Po, camminare e fermarsi, tessere e ritornare. Orto e cartoleria, chiacchierare leggere raccontare. Macerie, mercerie.
Nel dolore e nel caos la schiena dritta, sorelle conosciute e figli altrui, figlie nostre, e il chiacchierone dal multiforme ingegno che vada o torni dove pare a lui. Molto prima di Ulisse, la tela. Fare rizomi e tessere, filare, darsi del voi, cantare a tempo e cantare a respiro. Saturare, tendere il tempo, andare. Divenire tela, divenire rabbia. Divenire gioia.
Per leggere i racconti di Silvia Tebaldi su Periscopio clicca sul nome dell’autrice












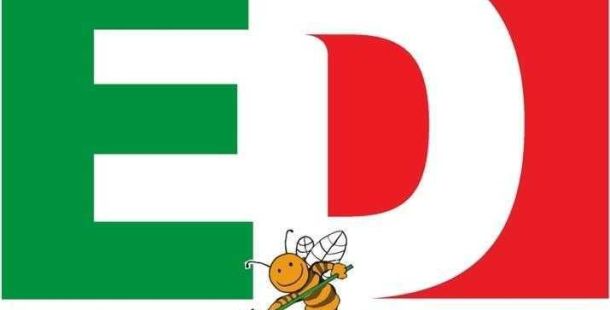
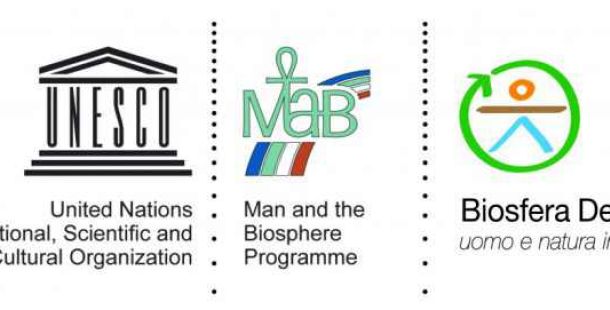




che bellezza, Silvia
grazie cara Barbara