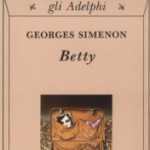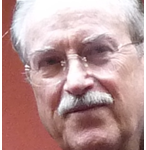L’EVENTO
Olga Peretyatko
a Bologna: una voce
per Rossini
Ennesimo viaggio, ennesimo articolo di giornale. Su una rivista patinata italiana scopro un evento importante e interessante a Bologna, con un altrettanto interessante artista.
Forse, vivendo a Mosca, sono particolarmente attenta agli scambi culturali italo-russi, ma per chi fosse nei paraggi, potrebbe essere davvero uno spettacolo unico, da non perdere. Tanto più che è gratuito (e interattivo) e che al Conservatorio di Mosca, dove canterà il prossimo 7 dicembre, non si trovano biglietti.

Si tratta del soprano Olga Peretyatko, artista russa trentaquattrenne, innamorata del bel canto e di Rossini, in particolare, e italiana d’adozione, per il suo matrimonio con il maestro Michele Mariotti, direttore dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con il quale vive e lavora, in totale simbiosi. E si tratta dello spettacolo che si terrà al Teatro Manzoni di Bologna, il 15 novembre alle 18, intitolato “Una voce per Rossini”.
Figlia di un cantante lirico, Olga è nata e cresciuta sul palcoscenico, nella romantica, leggiadra e artistica San Pietroburgo, iniziando la sua carriera musicale all’età di 15 anni, nel coro giovanile del celebre teatro Mariinsky. Ha proseguito i suoi studi presso la Hanns Eisler-Hochschule für Musik di Berlino e vinto numerosi premi internazionali. A partire dal 2007, si è esibita al Deutsche Oper Berlin, al Théâtre des Champs-Elysées a Parigi, a La Fenice di Venezia, al festival dell’Opera di Rossini di Pesaro, al Festival La Folle Journée di Nantes.

Ha guadagnato l’attenzione internazionale grazie a l’”Usignolo”, la prima opera teatrale scritta da Igor Stravinskij, nell’acclamata produzione di Robert Le Page alla prima del Festival di Aix-en-Provence nel 2010, e alla sue successive performance a Toronto, New York, Lione e Amsterdam. Ha ricoperto il ruolo di Adina ne “L’elisir d’amore” a Lille, di Lucia di Lammermoor al Teatro Massimo di Palermo, di Gilda nel Rigoletto a La Fenice di Venezia. Nel 2011, Olga Peretyatko ha debuttato come Giulietta (“I Capuleti e i Montecchi”) a Lione e Parigi, nel 2014, alla Scala di Milano (nel ruolo di Marfa, in “Una sposa per lo Zar”), e al Metropolitan di New York (nel ruolo di Elvira, ne “I Puritani”), nel 2015, sarà Violetta nella “Traviata” all’Opera di Losanna. Il soprano ha un contratto con una nota casa discografica e il suo primo cd singolo “La Bellezza del Canto” con arie di Rossini, Verdi, Donizetti, Massenet e Puccini, del 2011, è stato accolto da grande successo di pubblico e critica. Lo stesso per il suo secondo album, “Arabesque”, dell’estate 2013. Oggi è nota e applaudita.
In un’intervista, il soprano ha dichiarato: “devo molto all’Italia, e in particolare a Rossini, perché tutto è iniziato a Pesaro, nell’estate 2006, quando Alberto Zedda mi scelse per interpretare la Contessa di Folleville nel Viaggio a Reims realizzato dalla sua Accademia rossiniana. E già in quell’occasione suonava l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Con questa serata, voglio ringraziare anche loro, che mi sono stati vicini fin dall’inizio della mia carriera, oltre a Bologna, che poi è diventata la mia città”.
“Una voce per Rossini”, Olga Peretyatko a Bologna in uno show multimediale, orchestra del Teatro comunale di Bologna, direttore da Alberto Zedda.
Dalla funambolica aria della Contessa di Folleville, dal Viaggio a Reims alla scena del carcere, dal Tancredi, passando per la grandiosa pagina “Bel raggio lusinghier”, durante la quale Semiramide attende l’arrivo dell’amato. C’è l’eterna e multiforme musica di uno dei più amati compositori italiani al centro dello spettacolo multimediale “Una voce per Rossini”, in programma sabato 15 novembre alle 18 al Teatro Manzoni di Bologna, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Protagonista il soprano russo Olga Peretyatko, insieme all’Orchestra del Teatro Comunale cittadino diretta da Alberto Zedda. [vedi]