Presto di mattina /
Città aperta
Tempo di lettura: 12 minuti
Presto di mattina. Città aperta
“Anche le città hanno i loro sogni”
«Anche le città hanno i loro sogni», scrive Adam Zagajewski (1945_), per frangere il silenzio della memoria e dell’oblio (Guarire dal silenzio, Mondadori, Milano 2020, 29). Città sommerse e salvate, perdute e ritrovate sono le sue, stando ai luoghi narrativi coniati da Italo Calvino nelle Città invisibili.
 Ma fra tutti i sogni quello più ricorrente di una città è di diventare una città aperta, sogno che attende anche noi per farsi vero: «La città è aperta,/ aperti sono il vento e l’errare da un polo all’altro,/ senza potersi fermare o essendo troppo fermi,/ o simulando soltanto – malgré soi – il movimento,/ in una immobile inarrestabilità;/ tutto ciò che è accaduto/ sta aspettando te» (ivi, 132).
Ma fra tutti i sogni quello più ricorrente di una città è di diventare una città aperta, sogno che attende anche noi per farsi vero: «La città è aperta,/ aperti sono il vento e l’errare da un polo all’altro,/ senza potersi fermare o essendo troppo fermi,/ o simulando soltanto – malgré soi – il movimento,/ in una immobile inarrestabilità;/ tutto ciò che è accaduto/ sta aspettando te» (ivi, 132).
Città aperta è pure quella che, al pari della poetica di Zagajewski, sarà capace di declinare la realtà storica con il senso profondo della condizione umana che abita in essa. Così per il nostro autore città aperta è quella che incontra e riscopre i volti, perché sono i volti che edificano una città: i volti di coloro che arrivano, di quelli che partono o restano. Per questo una città aperta è pure città contemplativa che domanda: “mostrami il tuo volto, il tuo volto io cerco” (Sal 26, 8-9) ed è città profetica, una profezia di intimità: “la tua parola nel mio cuore”, (Sal 119, 11).
Di sera sulla piazza del mercato splendevano i volti
di persone che non conoscevo. Guardavo avidamente
i volti umani: ognuno era diverso,
ognuno diceva qualcosa, persuadeva,
rideva, soffriva.
Pensai che a costruire la città non sono le case,
non le piazze, i boulevard, i parchi, le ampie strade,
ma i volti avvampanti come lampade,
come i bruciatori dei saldatori, che di notte
nelle nuvole delle scintille riparano il ferro
(ivi, 83).
Ma pure vi è una città chiusa, quella del sottosuolo. Essa «è una sala d’attesa dove ogni giorno/ muori della malattia da ratto/ di chi chiude gli occhi per non vedere il male» (ivi, 270).
Poesia, sbiadita foglia che si colora al crepuscolo
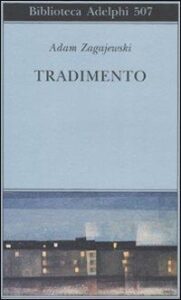 «Mi passò per la testa che la poesia non poteva essere proprietà di una nazione, perché altrimenti lo Stato se ne potrebbe impadronire. La poesia non è di nessuno. “Si fa rosa al crepuscolo la tua sbiadita foglia”, mentre qui vicino a me si odono elucubrazioni inquisitorie sul compito della letteratura in un periodo di transizione. Ridevo e sapevo che, così facendo, seppellivo ogni mia possibile carriera; da quel momento sarei stato quello che aveva violato la solennità delle riunioni di partito» (Tradimento, Adelphi, Milano 2007, 119).
«Mi passò per la testa che la poesia non poteva essere proprietà di una nazione, perché altrimenti lo Stato se ne potrebbe impadronire. La poesia non è di nessuno. “Si fa rosa al crepuscolo la tua sbiadita foglia”, mentre qui vicino a me si odono elucubrazioni inquisitorie sul compito della letteratura in un periodo di transizione. Ridevo e sapevo che, così facendo, seppellivo ogni mia possibile carriera; da quel momento sarei stato quello che aveva violato la solennità delle riunioni di partito» (Tradimento, Adelphi, Milano 2007, 119).
Ha scritto di Zagajewski il poeta Czeslaw Milosz: «La sua è una tessitura in cui fiori, alberi e uomini convivono in un’unica scena. Ma questo mondo ricreato dall’arte non è un luogo di fuga, al contrario è in relazione con la cruda realtà di questo secolo».
Derek Walcott, il poeta dell’isola di santa Lucia nelle Antille, ha definito la poesia di Zagajewski “voce sommessa sullo sfondo delle immense devastazioni di un secolo osceno, più intima di quella di Auden, non meno cosmopolita di quelle di Milosz, Celan, Brodskij».
Adam Zagajewski nasce a Leopoli nel 1945, città che con la sua famiglia dovette abbandonare, espulsa dai sovietici che se ne erano impadroniti nel 1944. Visse a Gliwice e Slesia, territorio tedesco annesso alla Repubblica Popolare di Polonia. Per “guarire il silenzio” ha provato ad essere voce del “mondo storpiato”, ingegnandosi a cantare l’asimmetria, la mancanza di corrispondenza tra passato e il qui ed ora.
Egli ritrova così Leopoli, la sua «piccola patria», in ogni luogo e città dove si reca. Così egli scrive: «Leopoli è ovunque» e ad essa bisogna ritornare, come a Gerusalemme. «Ogni città/ deve diventare Gerusalemme e ogni essere umano/ un ebreo, e adesso, in fretta e furia,/ fare solo le valigie, sempre, ogni giorno/ e andare fino all’ultimo respiro, andare/ a Leopoli, è infatti pur vero che esiste,/ serena e pura come una pesca./ Leopoli è ovunque», (Guarire il silenzio, 212).
È così sempre straniero, in cerca di una patria, cercando il proprio volto e quello della sua patria nei volti e nelle città altre. Quello che non è più viene reso visibile declinandolo con la concretezza del mondo presente e lo spirito si fonde con le cose della terra. Luoghi e cose avvolte in un silenzio impenetrabile, silenzio a cui le domande essenziali non si rassegnano perché nulla resti senza voce; incessanti incalzano, facendo danzare l’ago del tempo interiore: solo le domande, le parole che restano a prendersi cura del silenzio, lo rendono vivo.
La levigata pelle degli oggetti tesissima,
quanto il tendone di un circo.
Sopraggiunge la sera.
Salve, oscurità.
Addio, luce del giorno.
Siamo come le palpebre, dicono le cose,
tocchiamo sia l’occhio sia l’aria, l’oscurità
e la luce, l’India e l’Europa.
E improvvisamente sono io che prendo a dire: o cose,
sapete cos’è la sofferenza?
Siete mai state affamate, smarrite, sole?
Avete mai pianto? Conoscete l’angoscia?
La vergogna? Avete mai incontrato l’invidia e la gelosia,
i piccoli peccati che non sono abbracciati dal perdono?
Avete mai amato? Siete mai state vicine alla morte,
di notte, quando il vento apre le finestre e penetra
nel cuore fattosi freddo? Avete mai capito, vissuto
la vecchiaia, il tempo, l’effimero? E il lutto?
Cala il silenzio.
Sul muro danza l’ago del barometro
(ivi, 178-179).
E ancora domande, conversando con Friedrich Nietzsche.
Illustrissimo signor Friedrich:
mi sembra di vederla, sì,
sulla terrazza del sanatorio, all’alba,
quando cala la nebbia e il canto fa esplodere
le gole degli uccelli.
…
Voglio domandarle cosa sono le parole e cos’è
la chiarità, perché le parole ardono
finanche dopo cent’anni, benché la terra
sia così pesante, dura.
Se, tuttavia, non c’è Dio e nessuna forza
assembla variegati elementi, allora
cosa sono le parole e da dove scaturisce
la loro luce interiore?
E da dove deriva la gioia? Dove approda il nulla?
Dove dimora il perdono?
Perché i piccoli sogni svaniscono sul far del giorno
mentre quelli grandi crescono?
(ivi, 178).
Continue domande
Quei brevi istanti
Che si verificano così raramente –
Sarebbe questa la vita?
Quei pochi giorni
In cui ritorna la chiarità –
Sarebbe questa la vita?
Quei momenti in cui la musica
Riacquista la propria dignità –
Sarebbe questa la vita?
Quelle rare ore
In cui l’amore trionfa –
Sarebbe questa la vita?
(ivi, 16)
Dalla città alla poesia, ricerca di fulgore
Domanda: «Perché Lei scrive sempre delle città?». La risposta di Zagajewski sta in un verso, una parola greca «Periágoge» (ivi, 121), termine che si trova in Platone nel mito della caverna e dice l’azione di voltarsi, condurre intorno, percorrere, girare la testa, volgere lo sguardo, proprio come è principio di trasformazione l’uscire fuori e andare verso l’altro.
Così la città aperta costituisce lo spazio di questa conversione. Rivolta alla città la poesia stessa libera l’immaginazione perché trova in essa la sua ispirazione: «Tutto rinasce. L’ispirazione si spegne e rinasce. Il desiderio» (ivi, 122).
Non si tratta dunque solo di un’emozione o dell’astrazione di un sentimento momentaneo, ma di un sapere e un conoscere ardente del mondo. L’ispirazione poetica è generativa di un discernimento: «Una cosa è certa il mondo è vivo ed arde» (ivi, 125).
Così Zagajewski, oltre a cantare un mondo storpiato, prova a ricucire la cesura tra la poesia e il mondo, tra l’ispirazione e la storia, tra la città e il poeta. Una poesia, la sua, che canta non solo della fragilità e dell’oscurità del mondo, ma dello stupore e di una mai rassegnata speranza. Di più: «l’ispirazione è molto vicina all’incarnazione della gioia»:
La poesia è gioia sotto la quale si nasconde la disperazione
E sotto la disperazione
Di nuovo c’è la gioia
(ivi, 126).
…
«La poesia chiama alla vita, al coraggio/ al cospetto dell’ombra che si fa più grande» (ivi, 141). Ma proprio nel baratro dell’umano la poesia è alla ricerca del suo fulgore
Nelle strade e nei viali della mia città
col crepitio di un silenzio attivo e vivissimo
sotto le ceneri sta concentrata su un’opera l’oscurità.
La poesia è ricerca del fulgore
(ivi, 136).
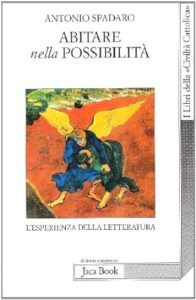 Scrive Antonio Spadaro: «Ecco, dunque, a nostro giudizio, che cosa ha inteso dire Zagajewski nella sua lectio magistralis se la poesia ci innalza al di sopra della rete empirica delle circostanze che forma il nostro destino, lo fa perché spontaneamente colloca il lettore – ora drammaticamente, ora soavemente – sull’orlo dell’abisso della sua origine, del suo inizio, spingendolo verso una conoscenza più profonda e radicale di se stesso e della realtà.
Scrive Antonio Spadaro: «Ecco, dunque, a nostro giudizio, che cosa ha inteso dire Zagajewski nella sua lectio magistralis se la poesia ci innalza al di sopra della rete empirica delle circostanze che forma il nostro destino, lo fa perché spontaneamente colloca il lettore – ora drammaticamente, ora soavemente – sull’orlo dell’abisso della sua origine, del suo inizio, spingendolo verso una conoscenza più profonda e radicale di se stesso e della realtà.
L’ispirazione, in maniera più o meno oscura, conduce il poeta e l’artista su quell’orlo abissale al mistero della sua scaturigine. La stessa teologia non è affatto sorda a questa condizione. Esperienza dell’origine, teologicamente intesa, è l’esperienza della creazione, della quale l’ispirazione, in qualche modo, partecipa …
Il Novecento, globalmente inteso, ha scelto, fondamentalmente, l’abisso inteso come baratro. L’arte, come il pensiero, ha privilegiato il nichilismo, la condizione tragica dell’uomo come “essere per la morte”, e l’angoscia come condizione affettiva fondamentale. Altri sono i toni di Adam Zagajewski» (Abitare nella possibilità. L’esperienza della letteratura, Jaca Book, Milano 194-195; 196).
La poetica di Zagajewski, nonostante l’incompiutezza, l’inconsistenza e tragicità della condizione umana, in bilico sul baratro, si innalza nell’abisso del suo “essere per la vita”; vi scorge a tratti il lento svilupparsi dell’essere umano e l’affiorare del volto d’altri, come quando poco alla volta cresce la costruzione di una nuova città e le relazioni con le persone:
Solo l’amore e il tempo, se fanno pace,
ci permettono di vedere l’altro essere umano
nella sua misteriosa, complicata essenza,
che lenta si sviluppa sicura, come una nuova città
su una pianura o in mezzo a verdi colli
(Guarire dal silenzio, 110-111).
E dalla poesia alla città: “aspettando pazienti la verde fiamma delle foglie”
Zagajewski lo ha fatto ricordando con una sua poesia una delle opere più rappresentative del neorealismo cinematografico: Roma città aperta di Roberto Rossellini. Con il termine città aperta si intende quell’accordo stretto tra belligeranti in una città, volto a rinunciare alla lotta armata e ai combattimenti per evitarne la distruzione.
Ma per Roma non fu così: l’accordo non venne riconosciuto dagli alleati che bombardarono l’Urbe ben 51 volte dall’agosto del 1943 al giugno 1944. Se l’occupazione tedesca risparmiò il patrimonio storico e architettonico della città, fu però devastante per la popolazione con deportazioni di militari italiani e degli ebrei, con la prigione di via Tasso e le Fosse Ardeatine.
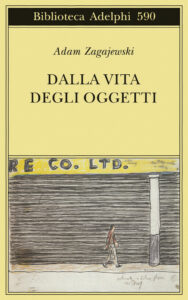 Giorno di marzo, quando gli alberi sono ancora spogli;
Giorno di marzo, quando gli alberi sono ancora spogli;
i platani aspettano
pazienti la verde fiamma delle foglie.
La polvere copre i templi; cinabro e ocra, arancio e
bordeaux,
ampie macchie di cannella.
Perché abbiamo smesso di parlare?
A Palazzo Barberini il bellissimo Narciso fissa il proprio
volto,
inanimato.
Città bronzea, che ripete sempre: mi dispiace.
Città bronzea, cui approdano stanche divinità greche,
come impiegati dalla provincia.
Oggi vorrei vedere i tuoi occhi senza collera.
Città bronzea, che cresce sui colli.
…
Lungo il Tevere corrono bambini dalle buffe mantelle
scolastiche
di inizio secolo;
accanto una cinepresa e riflettori. Corrono per il film,
non per se stessi.
Davide si vergogna per l’assassinio di Golia.
Perdonami il mio silenzio. Perdonami il tuo silenzio.
Città piena di statue; solo le fontane cantano…
(Dalla vita degli oggetti, Adelphi, Milano 2012, 194-195).
Ferrara città aperta
Vai attraverso questa città nel momento buio
quando la tristezza si nasconde nei portoni ombrosi
e i bambini giocano con palloni
che trascorrono come aquiloni
sugli inquinati pozzi dei cortili
e sottovoce, canta incerto l’ultimo merlo.
Pensa alla tua vita, che ancora dura
sebbene tanto a lungo sia già durata.
Hai saputo esprimere perlomeno una piccola parte
della totalità, domando.
Se hai visto lo squallore, hai saputo
dargli un nome, domando.
Se hai incontrato qualcuno che davvero viveva
autenticamente, hai saputo riconoscerlo?
(Guarire il silenzio, 93-94).
Anch’io passo così dalla poesia alla città, riportando alcuni testi del vescovo Gian Carlo Perego della lettera pastorale di quest’anno: Insieme sulla strada di Emmaus, che come sappiamo è una strada percorsa da due discepoli delusi e tristi, mentre abbandonano la città santa di Gerusalemme.
Ma ad accompagnarli sopraggiunge un Forestiero che farà loro ardere nuovamente il cuore e a cui diranno per annullare ogni separazione e distanza: “Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. E quell’incontro aprirà loro gli occhi, e subito li farà ritornare alla città pieni di gioia, quando era ancora buio, per scacciare con la buona notizia la tristezza dei fratelli rimasti chiusi a Gerusalemme.
Cittadinanza
«In una città mobile conta molto l’estensione e non la limitazione della cittadinanza, cioè della responsabilità sociale e politica. La necessità di educare alla cittadinanza viene da “una forte tendenza individualistica” che permea la società, che limita l’azione e la dimensione sociale come semplicemente funzionale a degli interessi personali. È la perdita del “bene comune”, dell’“insieme”, come fine dell’agire sociale, ma anche la perdita dell’“interesse”, della “passione sociale”, come molla dell’azione sociale. Tutto questo indebolisce le relazioni, indebolisce la città»(27- 28).
Ospitale
«La storia cristiana ha sempre pensato la città come luogo e forma di tutela, con una preferenza per i poveri (orfano, vedova, straniero, malato…). L’Ospitium, l’Ospitale, la foresteria, la casa, la scuola, l’officina, l’ambiente/giardino sono i luoghi centrali attorno ai quali cresce la città e crescono gli interessi comuni. Riprendere e riproporre un’idea di città, di cosa sta al centro della città, di fronte alla crescita di tentativi di periferizzazione della città, è molto importante oggi» (29).
Le attese della povera gente
«Occorre costruire in città una nuova relazione diffusa e intelligente, con un’attenzione preferenziale ai più deboli, con un orecchio alle “attese della povera gente”: di chi arriva e rimane ai margini della città, di chi è espulso dalla città, di chi è solo tra le case, di chi abbandona la scuola, di chi ha paura – sia in senso fisico che psichico –, di chi non ha famiglia, di chi perde il lavoro, lo coniuga con i tempi di attesa, di chi lavora irregolarmente ed è schiavo di nuovi meccanismi di caporalato o d’impresa o d’agenzia.
Non è sufficiente identificare, conoscere. Occorre incontrare e accompagnare per costruire una relazione costruttiva e risolutiva, in termini di promozione, libertà, protezione. Solamente l’incontro aiuta a costruire relazioni che vincono la paura, aprono al confronto, invitano al dialogo. Il nostro variegato mondo del volontariato è un ‘segno’ da valorizzare e far crescere» (30-31).
Città aperta
«Una città così chiede la partecipazione e la responsabilità di tutti, una nuova coscienza civile per vincere insieme quelli che La Pira e il card. Martini consideravano i mali della città: la violenza, la solitudine, la corruzione. Papa Francesco ci ricorda che questi mali possono essere superati solo attraverso “reti comunitarie” per il cambiamento (cfr. Laudato si’, 219) che generano fraternità.
Dobbiamo come cristiani e comunità cristiane che vivono nella città moltiplicare le occasioni di dono, di volontariato, di gratuità, in collaborazione con altre persone e istituzioni anche se non condividono la nostra fede: “uomini di buona volontà”, con cui condividere il cammino di pace e di non violenza, la tutela e la cura del creato, la tutela dei più deboli» (36).
Guarda anche me
Guardava me un Cristo olivastro
dai piccoli quadri del trecento;
non ne capivo lo sguardo,
ma volevo aprirmi a lui.
Il Cristo bruno, raccolto,
tutto concentrato, inquadrato
nelle cornici d’oro di Bisanzio,
guardava me, mentre io
ero assorbito da altro
(Guarire il silenzio, 80)
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.










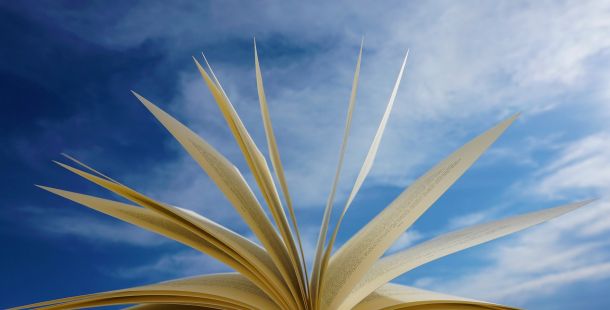







Grande Don Andrea
Il miglior Parroco di Ferrara… lo dice anche il suo amico Vescovo a Roma