Presto di mattina /
Di che cosa è fatta la Pasqua?
Tempo di lettura: 9 minuti
Presto di mattina. Di che cosa è fatta la Pasqua?
Pasqua, “statio novissima et jucunda”
Dopo aver percorso tutte le stazioni della via crucis, ad indicarne la svolta, la condizione decisiva, quella che ribalta le sorti, ecco raggiunto il passante di valico oltre la statio crucis: ossia la statio novissima et jucunda. Non senza ragione don Primo Mazzolari designa così la Pasqua, come lo stare già nel luogo delle cose ultime suggerisce l’etimologia latina, “novissima” appunto, anticipo e ripresentazione del tempo ultimo e definitivo compimento; la destinazione finale del dimorare peregrinante dell’uomo, di pasqua in pasqua, per giungere lieti ad «una riva gioconda,/ profondamente vivi» (Carlo Betocchi).
Così anche questa Pasqua è insieme memoriale attuativo e prognostico di quella futura; un volto gioioso che si rivela vivendo l’impegno con Cristo anche oggi verso un altrove che conosceremo strada facendo perché «ogni cosa che muore, come ogni cosa che incomincia a vivere nella morte, è un aspetto della Pasqua», (P. Mazzolari, La Pasqua, La Locusta, Vicenza 1965, 51).
Pasqua: un atto di pietà
Scrive ancora Mazzolari: «La Pasqua si ripete. Il nostro sacramento pasquale è ancora una volta un atto di pietà, come se il Signore avesse bisogno di piccole pietà» (ivi, 52). Come a dire allora che quella «Pasqua che cancellasse dalla terra il povero della beatitudine, non sarebbe la statio jucunda» (Mazzolari, Via crucis del povero, Dehoniane, Bologna 1983, 127; 137)
Così “l’inferma pietà” del poeta è guarita da quella “infinita” della Pasqua e le lacrime di una donna innamorata nel sereno mattino sono deterse da una “pietà non tradita”. A tutti “la carità del vero”, la verità come amore, grazia che vigila con necessità “implacabile” i confini, l’intrico tra bene e male, giusto e ingiusto, innocente e reo.
La pietà del vero: «pietà, ma non di sé: specchio/ non del cupido esigere:/ ma fede, o alba del cristiano,/ che crede all’immolarsi, ed alla vittima… C’è verità nel coraggio/ di credere e d’esistere,/ e dentro il fiore della carità» (C. Betocchi, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1996, 58; 535). Così Betocchi si augura di «aver somigliato», nella sua creazione poetica a Thomas Eliot che nella sua poesia, «rifacendosi a Dante, ha restituito alla pietà il trono che le spetta» (ivi, 474).
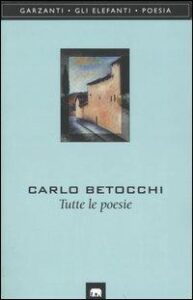 In questo deserto
In questo deserto
attendo l’implacabile
venuta d’un’ acqua viva
perché mi faccia a me certo.
…
E godo la terra
bruna, e l’indistruttibile
certezza delle sue cose
già nel mio cuore si serra:
e intendo che vita
è questa, e profondissima
luce irraggio sotto i cieli
colmi di pietà infinita.
(C. Betocchi, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1996, 58).
– Donna, che piangi donna? …
nella Pasqua serena:
la pietà non tradita
anche di te s’abbevera
e la vita
(ivi, 183).
Pietà
Abbiate pietà di chi non crede
ma assai più di chi crede: poiché
sugli uni e gli altri incombe, trèpida
e feroce, la strana carità del vero;
che non ignora in se stessa appaiati
ad una stessa sorte il bene e il male
dalla sua stessa implacabile necessità (ivi, 462).
Per tutti è la Pasqua
 E ancora una volta «per tutti, anche per i molti che non partecipano al sacramento, il mistero della Pasqua, è una consegna» (La Pasqua, 54).
E ancora una volta «per tutti, anche per i molti che non partecipano al sacramento, il mistero della Pasqua, è una consegna» (La Pasqua, 54).
Mazzolari aveva già ricordato due consegne di Gesù ai suoi presso la statio crucis. Dapprima il suo perdono: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. E poi la Madre e il Discepolo: che è la reciprocità nel prendere con sé, dell’esserci per l’altro; una consegna passata con l’ultimo fiato rimastogli nella forma umilissima di un avverbio di presenzialità: «Ecco tuo figlio!… Ecco tua madre!».
Ma a Pasqua vi è un’altra, una nuova consegna: quella della speranza che è uno sperare per tutti – “io spero in te per noi” (Gabriel Marcel) – una speranza rimessa in cammino e posta sotto i piedi di tutti: «“Egli vi precede”. Dove? Dappertutto: in Galilea e in Samaria: a Gerusalemme e a Roma: nel Cenacolo e sulla strada di Emmaus… ovunque l’uomo pianterà le sue tende, farà la sua giornata di fatica e d’avventura, spezzerà il suo pane, costruirà le sue città, piangendo o cantando, sorridendo o imprecando. “Egli vi precede”. Questa è la consegna della Pasqua. E se, alzandoci dalla tavola eucaristica, avremo l’animo disposto a tenergli dietro ove egli ci precede, “lo vedremo, come egli disse”» (ivi, 52-53).
Profezia e poesia: le terre rare della Pasqua
Se la Pasqua è statio novissima et jucunda, le terre rare della Pasqua sono la profezia e la poesia, non senza la pietà. Entrambe infatti rendono presente nel già il non ancora, sono sementi di speranza ora e frutti, poi, di futura jucunditas.
In questa Pasqua mi sono lasciato guidare, come avrete intuito, da un profeta e da un poeta. Don Primo, il parroco di Bozzolo, ovvero “la tromba dello Spirito”, come lo designò papa Giovanni XXIII durante il loro incontro in Vaticano.
E poi Carlo Betocchi, il poeta dalla «chiarezza mistica», come la definì Pier Paolo Pasolini, alludendo alla sua cifra poetica celatamente profetica. Betocchi era tecnico agrimensore, lavorava con gli operai e il suo rapporto con loro – scrive Pasolini – non si sarebbe lontani dal giusto definirlo un rapporto evangelico: «un rapporto travolto e accecato dall’amore, e anche là dov’è pura simpatia, è tutto pieno e deformato da una sia pur virile tenerezza.
Per dispiegarsi oltre l’impegno sociale in un antico e assoluto impegno umano. Ed è evidente che doveva essere così, se l’impeto stesso della poesia ha abbattuto tra Betocchi e l’operaio lo schermo delle classi sociali: e Betocchi è operaio con gli operai, e non ha quindi regressi da compiere, obblighi morali o sociali da adempiere a priori… le facoltà di Betocchi sono appunto tutte estatiche, e noi dobbiamo seguire il loro processo: disegnare l’operazione poetica di Betocchi è fare il ritratto di una “grazia”» (ivi, 590-591).
Alla Pasqua, come fontana di speranza vivace per il suo verde labbro di pietra, corre il poeta, all’allietante labbro, quello del canto dell’acqua per il suo internarsi, e “inventrarsi”, non senza stupore, nel riaperto spazio del Risorto: giocondità di bambini e di donne al sole. E, nell’oscurità del giorno che tramonta, il rosso del cielo resiste all’avanzare dell’ombra a far compagnia ai tetti in attesa della luce della luna che l’aurora troverà ancora accesa al suo sorgere.
Io arrivai in una piazza
colma di una cosa sovrana,
una bellissima fontana
e intorno un’allegria pazza.
Stava tra verdi aiole;
per viali di ghiaie fini
giocondavano bei bambini
e donne sedute al sole.
Verde il labbro di pietra
e il ridente labbro dell’acqua
fermo sulla riviera stracca,
in puro cielo s’invetra.
Tutto il resto è una bruna
ombra, sotto le loggie invase
dal cielo rosso, l’alte case
sui tetti attendon la luna
(ivi, 51)
«Di che cosa è fatta la Pasqua?»
«Una pietra rovesciata, un sepolcro vuoto, una sindone inutile – è la risposta di Mazzolari –: cioè, di nulla, se non di quelle libertà che l’uomo può rinnegare, se vuole, ma che nessuno gli può togliere, se vuole, perché il “regno di Dio è dentro di noi”. Nella Pasqua del povero, come nella Pasqua di Gesù, c’è l’inafferrabile. Per questo, se uno vuole, la può sempre negare, perché il documento, più che a una certezza materiale, risponde a una rivelazione del cuore attraverso i vuoti dell’esistenza».
Pasqua: una libertà che si affida amando
«– Pietro, mi ami tu? La vera Pasqua incomincia e finisce così. Ma se tu pensi unicamente a una palingenesi sociale, a un capovolgimento delle odierne strutture economiche e politiche, se sogni una nuova terra emergente da un lavacro di sangue, se vuoi “pesare” la Pasqua e commutarla in cibo e bevanda in forza di quella equità che trova nella legge il suo equilibrio e nella buona volontà dell’uomo il suo fondamento, non riuscirai a capire la realtà spirituale della Pasqua del povero. Non dico che il tuo sogno sia sbagliato. Anch’io voglio una giornata più equa per tutti, una terra meno aspra, una convivenza meno barbara, un pane più abbondante, mani che si cercano, cuori che si ascoltano.
Anch’io sospiro verso quella giornata, ma senza le tue inquietudini, senza le tue ansie, senza i tuoi rancori: perché se m’interessa il domani, quest’attimo che vivo, questo mio cuore che deve avviare e sorreggere ogni sforzo verso un buon domani m’interessa ancor di più. Io non voglio rinunciare ad essere buono oggi, per essere domani un satollo. Ma per essere buoni e contenti tutti i giorni del passaggio non c’è che una condizione: sentirsi poveri, inguaribilmente poveri anche nell’abbondanza di tutti i beni materiali» (Via crucis del povero, 134).
Dove non c’è Pasqua
«Il corpo del Cristo risorto porta nella gloria i segni della passione. Entra nel cenacolo a porte chiuse, ma si lascia toccare, e lo si può toccare là dove “povertà” ha segnato il suo colmo di sopportazione. “Porgi qua il dito e vedi le mie mani: e porgi la mano e mettila nel mio costato e non voler essere incredulo, ma credente”.
Questo povero cuore che cerca la vita e se la sente sfuggire, non può rifiutarsi di toccare quell’unico lembo di realtà buona che gli è rimasta vicina e che solo può aiutarlo a trattenere la vita. Dove l’uomo si rifiuta di soffrire, non c’è Pasqua. Dove l’uomo si rifiuta di “toccare” il dolore degli altri, non c’è Pasqua. Dove le mani dell’uomo non sono forate per amore dei fratelli, non c’è Pasqua. Se i piedi non sono forati non possono portare sulle strade della pace pasquale. Da un cuore non trasvertebrato non trabocca l’alleluja Pasquale. Non conosco altro mezzo per vincere la nostra durezza. Non si può far posto alla giustizia che soffrendo e offrendoci» (ivi, 134-135).
L’impegno con Cristo è l’impegno con il povero
«Non impegna: la morte non impegna. La vita impegna: la Pasqua impegna. Solo la Pasqua ha veramente bisogno di fede; la Pasqua del Cristo, come la Pasqua del povero. Sulla strada di Emmaus, come nel cenacolo e sulle rive del lago, le apparizioni sono brevi: un bagliore degli occhi che potrebbe anche essere dimenticato se il cuore non ardesse dentro. «Non ardeva il nostro cuore in noi, mentr’egli ci parlava per la via?». Come custodire l’ardore del cuore in un mondo di glaciale egoismo? Come difendere la piccola fiamma della mia fede dalla fredda bufera della disumanità trionfante?
Ma è proprio per questo, per questo urlo di barbarie che s’avventa contro la nostra Pasqua, che credo nella Pasqua come non vi ho mai creduto prima» (ivi, 137).
«Per Pasqua: auguri a un poeta»
È questo il titolo di una poesia di Carlo Betocchi a Giorgio Caproni, un poeta dalla “speranza rovesciata”, sostenuta flebilmente solo dall’amore per la moglie Rina. E tuttavia, nel nulla di una terra desolata, nel sottosuolo della fede e di un cuore “che non soffre che del non amare, e sempre sta in croce”, egli ci indica, dove si nasconde la Pasqua: «E allora, sai che ti dico io?/ Che proprio dove non c’è nulla/ – nemmeno il dove – c’è Dio» (Daniela Patrignani, Giorgio Caproni (1912-1990), alla ricerca di Dio sulle strade del nulla, in Letture, 472/1990, 886).
Giorgio, quante croci sui monti, quante,
fatte d’un po’ di tutto, di filagne
che inclinate si spaccano, di scarti,
ma croci che respirano nell’aria,
in vetta alle colline, dove i poveri
hanno anch’essi un colore d’azzurro,
la simile cred’io l’ebbe Gesù,
non già di prima scelta, rimediata
tra’ rimasugli d’un antro artigiano,
commessa con cavicchi raccattati,
eppure estrosa, ed alta, ed indomabile
e tentennante com’è la miseria:
ecco la nostra Pasqua onde ti manda
il mio libero cuore quest’auguri
pensando che non è per l’occasione
ma per quella di sempre, che si salva
dalle occasioni, del cuor che non soffre
che del non amare, e sempre sta in croce
con un cartiglio fradicio che in vetta
dice: È un poveraccio, questi che vuole
ciò che il mondo non vuole, solo amore
(Tutte le poesie, 200-201).
Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.














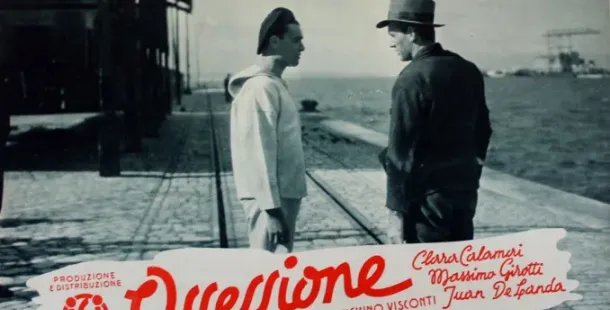



Lascia un commento