Presto di mattina /
Il coraggio della poesia
Tempo di lettura: 7 minuti
Presto di mattina. Il coraggio della poesia
Il coraggio della poesia
Seminare idee è il titolo della Iª edizione del Festival Città di Prato tenutasi dal 6 al 8 giugno nel chiostro della chiesa di San Domenico, che ha avuto per tema il Coraggio. E in questo contesto, il coraggio della poesia è stata la riflessione presentata dal poeta e narratore Giuseppe Conte (Imperia 1945) dal titolo: Poesia al cuore dell’uomo.
Conte ritiene che, tra tutte le forme di coraggio, quella che gli ha insegnato la poesia è il coraggio di vivere nell’“ordine dello spirito”. È lo spirito – egli precisa – che ricrea la materia, ed è l’azione dello spirito la fonte del coraggio, lo stesso «Spirito che ci genera/ come uomini e ci dà il canto».
Non è la volontà di potenza ma di conoscenza, di comprensione ospitale: «Eppure anch’io combatto, e prego e costruisco; anch’io ho fatto/ crescere alberi e fiori sulle pagine/ ho portato il marmo greco tra le foreste di querce e vischio e i torrenti in piena dei Celti». Così il mito diventa per il poeta racconto di ciò che di più intimo nasconde ogni uomo in sé.
Ricordando il testo Elegia di Jorge Luis Borges – Al di là della porta un uomo fatto/ di solitudine, di amore e tempo,/ ha appena pianto a Buenos Aires/ su tutte le cose – egli ci mostra con parole sue il coraggio della poesia: «Riconoscere l’abisso di dolore che regna nel mondo, nella storia, nell’anima di ciascuno di noi, di piangerlo e di risolverlo in canto. Non conosco coraggio più intimo e più vero».
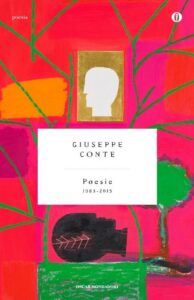 E come una risonanza rispondente al testo litanico di Borges I Giusti, Conte scriverà nella sua raccolta poetica sulle Cose che chiedono lacrime: come sentir cantare uomini costretti a partire per una terra straniera», come per «tutta la pietà che non hai provato verso chi soffre e chi muore” e per l’amore che è dato senza misura» (G. Conte, Poesie 1983-2015, Oscar Mondadori, Milano 2015, 305).
E come una risonanza rispondente al testo litanico di Borges I Giusti, Conte scriverà nella sua raccolta poetica sulle Cose che chiedono lacrime: come sentir cantare uomini costretti a partire per una terra straniera», come per «tutta la pietà che non hai provato verso chi soffre e chi muore” e per l’amore che è dato senza misura» (G. Conte, Poesie 1983-2015, Oscar Mondadori, Milano 2015, 305).
Il coraggio della poesia sta nella sua “resistenza” a ogni forma di barbarie, nel continuare a dar voce alle cose che non hanno voce, svelando quelle occultate di proposito, nel rendere visibile l’invisibile nascosto in esse. Resistenza a tenere vive le presenze del sacro sulla terra, nel tenere vivo ciò che altri vorrebbero morto, il coraggio di sfidare la disumanizzazione del mondo.
Poesia è coraggio delle ripartenze e, come Odisseo, mai dismette il remo che cerca attraversando i mari virtù e conoscenza, a far argine ad ogni brutalità. Oltre ogni conoscenza e frontiera anche; poesia è partenza abramitica verso l’ignoto, verso il mare infinito del cielo che è l’umanità viandante, che si svela a se stessa strada facendo, amando il diverso, lo straniero, chi viene a noi da lontano, ed è un Dio che lo manda, sicché in loro si manifesta il Dio che viene ad ogni uomo.
Così il poeta non finirà di “scrivere sul mare” né “di cantare ciò che c’è in lui di estatico, quello che c’è in lui di abissale… scriverò, mare, sulla tua anima a pezzi, di chi ti snatura e ti spopola e ti riscalda fuori misura” (ivi, 359; 363).
Poesia va’ mutando in canto l’abisso delle lacrime
Della poesia infatti le lacrime sono la materia matrice, abissale, sprofondo di dolore; il canto è lo spirito estatico e amante che dispiega l’abbraccio della luce nel suo oscuro grembo, così che da “ferite germogliano fioriture”.
La materia è la madre nostra comune
siamo le zolle di terra da dove scocca
le sue frecce di primavera il papavero
e da dove cresce il grano
siamo l’erba sottile e i rami
giganti del cedro e le foglie del banano,
la materia è la madre, siamo le gocce
della pioggia che benedice e feconda
l’acqua dei fiumi che si può bere
l’acqua salata dell’onda
e della marea, siamo la pietra rocciosa
che strapiomba tra agavi e cactus
la sabbia del deserto tutta rosa
di nebbia e di miraggi.
La materia è la madre nostra comune
in lei siamo fratelli, siamo i raggi
del pianeta Venere, i ghiacci delle comete
le corolle abissali delle nebulose
costellazioni ancora segrete
e quelle dell’Orsa, del Toro, delle Pleiadi.
Lo Spirito che ci genera
come uomini e ci dà il canto
ama la materia e il suo grembo
come l’amò all’inizio, quando
la penetrò con un moto
vorticoso e veloce
finché fu
luce
(da Ferite e fioriture, [Premio Viareggio 2006], ivi, 287).
Poesia: come spirito d’amore nelle cose, sua incarnazione
È questo il tuo miracolo, Amore,
questa violenta volontà di essere
materia che si agita e si muove
e si piega e si mescola e confonde,
l’energia marina del vento,
l’energia aerea delle onde.
È questo il tuo miracolo, Amore,
lo spirito che entra nelle cose
che popola il vuoto di mimose
come fa sui viali liguri Febbraio
(ivi, 287-288)
«Occorre molto coraggio alla poesia per continuare a levare la sua voce, in una realtà sempre più imbarbarita e orrenda. Eppure lo fa. Sa che molti la negano e la disprezzano, come ha denunciato senza sconti Yves Bonnefoy. Eppure continua.
Sa farsi barriera contro la marea montante della barbarie, e ricordarci tutto ciò che è
pertinente all’essenza dell’umano. Ci ricorda di essere liberi, come il mare che vive in continuo movimento ed è specchio dell’infinito. E però anche di essere fraterni, di sentire come la compassione e la pietà siano le disposizioni dell’anima più necessarie e benefiche che ci legano ai nostri simili.
La poesia ha anche il coraggio di indurci al sorriso. Per violento che sia il mondo, lo spazio per sorridere, per un buon esercizio di humour resiste, e si oppone alla violenza più efficacemente di quanto ci si aspetti. La poesia ci insegna a rispettare e soprattutto ad amare il diverso, lo straniero, chi viene a noi da lontano, ed è un Dio che lo manda, come dice la ragazza Nausicaa alle sue ancelle di fronte a Odisseo nudo e naufrago.
Ci insegna a essere sognatori, a occhi aperti, a lasciare che gli altri ci chiamino acchiappanuvole senza conoscere la bellezza dello spettacolo delle nuvole mosse dal vento tra l’oro del sole e l’azzurro del cielo. E, in più, a essere fedeli ai propri sogni, sempre, qualunque sia il prezzo da pagare. E di essere sempre dalla parte dell’Amore, di puntare sempre all’altezza dell’Amore come Dante nel suo percorso dal buio all’assoluto della Luce.
La poesia insegna il coraggio del viaggio iniziatico, il viaggio dello spirito alla ricerca di se stesso e delle proprie origini. La sua passione è la conoscenza. Andare a vedere l’invisibile. Scoprire il senso e le scaturigini del senso. Affrontare il mistero delle cose circumnavigandolo e poi gettandovisi a capofitto dentro, che è il suo più
alto e difficile compito.
La poesia, alla fine, è l’unica tra le attività umane che ha il coraggio di affrontare nel suo canto il mistero del linguaggio. Che forse è il più vicino al mistero supremo, quello di Dio. Del Verbo» (intervento al Festival).
“Gioia sottopelle”, la consolazione della poesia
«La poesia pratica questa sua energia alchemica, e muovendo sempre da una mancanza, da un disagio dell’essere, da una sofferenza produce universi di bellezza e di gioia. La cultura dominante negli anni della mia formazione, attraversata da mode nichiliste, materialiste, desacralizzanti, aveva irriso l’idea della “consolazione”.
Ma da sempre la poesia consola offrendo cibo all’anima sofferente. Non asciuga le lacrime, le lascia scorrere: ma grazie a lei sono gocce di latte, di vino, di miele. Tutto questo richiede ai poeti il coraggio di essere terribilmente se stessi, senza compromessi, mezze verità, autoassoluzioni: di guardare la realtà, quella esterna e quella interiore, dell’anima, consci della propria fragilità, della propria inutilità ma anche della propria capacità di ribellarsi, di dare scandalo» (ivi).
Il poeta girovago, mendicante, ringrazia cantando e quasi danzando l’umile dio dell’alba, il dio che fa partire. Il dio d’ogni esodo, il cui nome si scoprirà solo strada facendo, percorrendo i deserti di disumanità. Egli è colui che vede l’afflizione, ascolta il grido, libera e fa uscire verso un’altra umanità.
E così egli ringrazia per il dono di quella “sragionevole gioia sottopelle” che lo rialza ogni mattina e il tremore di ogni strazio si muta in danza.
Non vedete, non ho niente.
Girovago, mendicante
niente mi è stato dato
di quello che mi spettava
sono stato ferito, deriso
pugnalato, frainteso
e ucciso dove possono
uccidere le parole.
Fratello mi è ogni vinto,
fratello ogni ribelle.
Ho avuto solo da te,
mia vita, questa acuta
sragionevole gioia sottopelle
certe mattine quando appena sveglio
io degli uomini il più misero
io che conosco ogni strazio
un canto alzo
e quasi danzo
e fremo mentre ringrazio
l’umile dio dell’alba
(ivi, 326).
Tu che mi hai dato così spesso al risveglio
Questa voglia di canto,
tu seme, raggio, rugiada di ogni notte
tu fronda verde – luna di ulivo
ramo di mandorlo a marzo
mosto dentro la botte
resta
…
Tu seme, raggio, rugiada di ogni aurora
(ivi, 284)
Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.















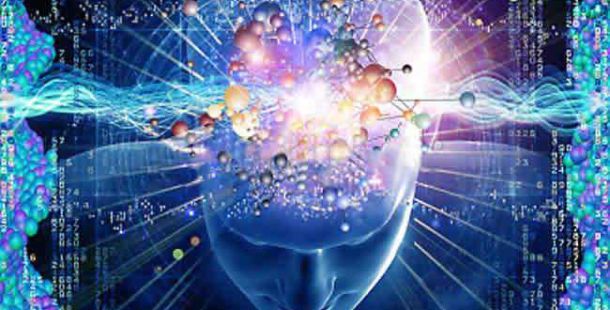
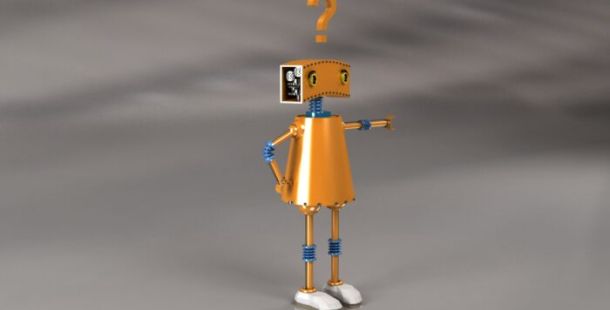

Lascia un commento