Non è Don Milani il colpevole della cattiva scuola
Tempo di lettura: 6 minuti
Dopo le critiche di Luca Ricolfi e Paola Mastrocola (Il danno scolastico, ed. La Nave di Teseo) a Don Milani, che avrebbe contribuito, con l’idea che “la scuola pubblica non può bocciare”, ad una banalizzazione della scuola, arrivano ora quelle di Ernesto Galli della Loggia che cita Adolfo Scotto di Luzio (L’equivoco don Milani, ed. Einaudi), secondo cui il priore di Barbiana è stato usato, nel post ’68, come profeta di quella “scuola democratica” che tanti mali avrebbe prodotto nell’istruzione pubblica.
Il libro di Scotto di Luzio è una documentata analisi di “Lettera a una professoressa” , che don Milani scrisse dopo che uno dei suoi allievi tentò di inserirsi nella scuola pubblica venendo però bocciato.
Scotto ha ragione su un punto: secondo don Milani, la scuola pubblica era organizzata per ratificare la subalternità sociale delle classi popolari attraverso una istruzione “colta”, priva di qualunque utilità pratica e che ai poveri diceva poco o nulla, che proponeva come modello la modernità borghese al posto della tradizione contadina e popolare: l’italiano al posto del dialetto, i grandi pensatori classici al posto dei sarmenti[1].
Del resto la riforma Gentile, ancora vigente a quel tempo, aveva l’obiettivo di formare una classe dirigente che studiasse le cose più lontane possibili dal sapere manuale e contadino.
Per onestà intellettuale, bisognerebbe evitare di tirare don Milani per la giacchetta e riconoscere il suo autentico messaggio, che anche oggi sarebbe eterodosso. Spedito dalla curia in una frazione sperduta, Barbiana, di Vicchio del Mugello, per le sue idee contro la guerra, i cappellani militari e l’obiezione di coscienza, Lorenzo Milani fu un contestatore del potere e, nell’istruzione, uno sperimentatore generoso e audace che si cimentò in quella che oggi sarebbe una piccola scuola privata (home schooling) rivolta a un piccolo drappello di contadini che mai avrebbero studiato (“la scuola è meglio della merda”) se non fosse stato per la sua iniziativa.
Non è vero – come scrive Galli della Loggia su Il Corriere della Sera del 1.6.2023 – che “dei modi di insegnare a lui non interessava davvero nulla”. E’ stata proprio di Don Lorenzo Milani la capacità di integrare lo studio “classico” (che oggi chiameremmo “istruzione”) con le conoscenze di vita e lavoro dei suoi contadini, affermando un concetto oggi largamente accettato dagli esperti, e che cioè si apprende dallo studio, ma anche dal lavoro e dalla vita. Una acquisizione che la nostra scuola pubblica non è stata capace di inverare, nonostante diverse sperimentazioni di successo in tal senso (da Fiorenzo Alfieri, maestro elementare e assessore di Torino dal 1976 al 1980, all’odierno movimento della scuola pubblica all’aperto, alle scuole private Steiner e Montessori).
Per Don Milani il sapere si estendeva anche a quelle conoscenze popolari, contadine, che non erano meno importanti di quelle moderne e borghesi. Il sapere si esprimeva anche nel dialetto e nei sarmenti (i tralci recisi della vite, a cui i contadini cambiano nome nel momento in cui non sono più attaccati alla pianta).
Non è un dettaglio, per lo più sconosciuto ai cittadini borghesi, ma il senso profondo di un mondo contadino (oggi diremmo con un luogo comune la “tradizione”) che l’umanità ha conquistato in duemila anni di storia.
Una saggezza che sa quanto sia importante conoscere la Natura ed avere un rapporto armonico con essa, sa che esiste la vite ed esiste il tralcio. Una saggezza da cui è possibile trarre il concetto di “libertà nella responsabilità” o di “limite”. Quando questo limite viene superato, il tralcio diventa un sarmento.
Si tratta di un tema caro anche a Pier Paolo Pasolini (tradizione versus modernità) che si ripropone oggi in modo acutissimo dopo 30 anni di iper-globalizzazione e di “modernità” come nuova religione occidentale, come se tutto ciò che è tradizione fosse da buttare e ciò che è moderno fosse sempre e comunque da venerare.
Altro che don Milani! E’ nei social, nelle minacce della modernità e in una scuola imbalsamata da cinquant’anni che bisogna cercare le cause dei disturbi da ansia e depressione che sono cresciuti dal 10% al 23% tra gli adolescenti in Occidente, così come gli atti di autolesionismo e i tentati suicidi a causa del bullismo social, dell’ eccesso di competitività nel rapporto coi pari legato all’abuso delle piattaforme e dei recenti lockdown con didattica a distanza.
Così crescono i ritiri scolastici, i casi Hikikomori, che colpiscono i più deboli del branco (o il revenge porn sulle ragazze). Allarmi che ora lanciano anche gli adulti, per gli effetti devastanti a cui sta portando l’accelerazione senza gradualità del digitale, dell’Intelligenza Artificiale deregolata (da chatGpt in poi) che quasi sempre rendono la vita, il lavoro e l’istruzione meno umana.
Il potenziamento della “tekhne” e delle tecnologie, senza un contraltare di regolazione umanistica e morale, distrugge forme di vita e di relazione prodotte in centinaia di anni. Un tema di cui parla diffusamente Umberto Galimberti nel suo libro L’ospite inquietante, I giovani e il nichilismo).
In tal senso non è vero che don Milani (come dice Galli della Loggia) “non ci aiuta per nulla a rispondere alla domanda cruciale dell’istruzione obbligatoria: che cosa fare con quelli che non ce la fanno?”
E’ corretto affermare che don Milani non era per bocciarli, ma non era neppure per la scuola “facilitata”. Cercava vie nuove affinché i suoi contadini potessero apprendere dalla via dell’ istruzione (che diremmo “classica”, passare dalle cento parole dell’operaio e contadino alle mille del padrone), ma anche dalla via della sperimentazione, facendo tesoro di quel lavoro manuale e della vita che i suoi studenti conducevano e operando affinché la scuola non annullasse quella cultura popolare, quelle tradizioni, quella stessa religiosità e spiritualità al posto delle quali introdurre una modernità priva di radici e alienante.
La via da seguire per la scuola pubblica non può essere quella del solo “modernizzare” in senso telematico/informatico.
Si dovrà pur riflettere sul motivo per cui metà dei quindicenni non sappiano interpretare un testo, né scrivere, né fare un’operazione elementare di matematica. Non può essere solo la “scuola facilitata” di cui parla Ricolfi, ma ci deve essere qualcosa di più profondo che ha prodotto questa devastazione.
Da qui la necessità di riprendere sperimentazioni che portino ad un apprendimento più efficace, ispirato da nuove forme di insegnamento.
Solo dopo una stagione di confronto tra esse si potrà avviare una sintesi che porti ad un rinnovamento del modo di insegnare nelle scuole pubbliche, anziché improvvisare senza alcuna sperimentazione soluzioni che, non a caso, da decenni vengono introdotte e poi non lasciano alcuna traccia.
[1] Da ‘Lettera a una professoressa’: “…gli insegnanti smettano di fare le cose difficili che umiliano i poveri, e interroghino i poveri sulle cose che già sanno…a scienze ci parlerete di sarmenti e ci direte il nome dell’albero che fa le ciliegie”. Per Paola Mastrocola e Luca Ricolfi (“Il danno scolastico”) è proprio questa facilitazione che spiazza i poveri, i quali hanno tutto il diritto invece di essere formati sui grandi pensatori del passato, sull’Iliade e l’Eneide. E come non essere d’accordo. Se molte cose scritte in questo libro controcorrente sono (a mio parere) condivisibili, non lo è la critica a don Milani che non c’entra nulla con la “facilitazione” della scuola. Milani fece una critica alla scuola selettiva degli anni ‘60 (morì nel 1967), severa ma anche élitaria e ferocemente selezionatrice delle classi socialmente più emarginate che, bocciate, potevano andare a lavorare. Allora la battaglia sacrosanta era per un modello di scuola meno “astratta”: non si metteva in discussione solo la selezione quasi sadica contro gli ultimi (non c’era tempo pieno, né sostegni), ma soprattutto ci si batteva per una scuola che garantisse a tutti l’accesso al pensiero, ma che motivasse anche gli alunni più poveri, parlando anche del loro mondo.
Per leggere gli articoli di Andrea Gandini su Periscopio, clicca sul suo nome.
Per leggere solo gli articoli della sua rubrica NUMERI, clicca sul nome della rubrica.



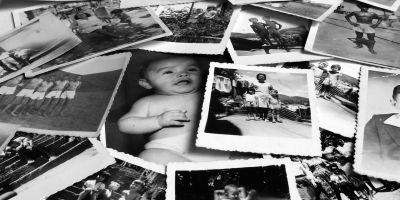







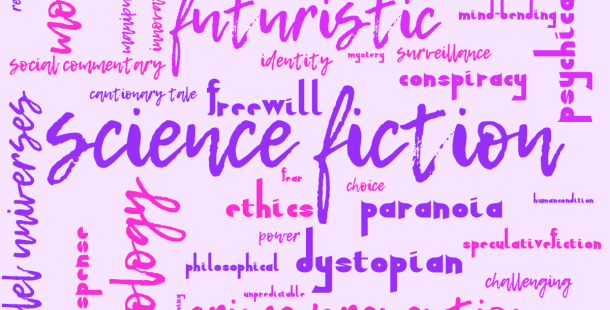





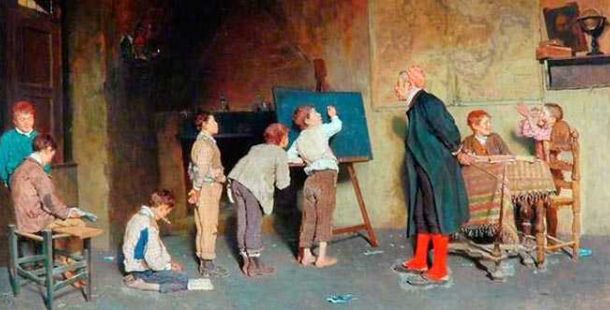

“Soprattutto ci si batteva per una scuola che garantisse a tutti l’accesso al pensiero, ma che motivasse anche gli alunni più poveri, parlando anche del loro mondo”: sono molto d’accordo su questo, ma in totale disaccordo che la scuola di don Milani avesse a che vedere con l’homeschooling e nego pure una liquidazione semplicistica della tecnologia come contraria alla possibilità di rendere la scuola un luogo attivo di apprendimento.
Penso che tutti questi personaggi, che non riesco a chiamare pensatori o intellettuali, siano prigionieri, a pensar bene, di pregiudizi e chiusura mentale dovuta alla loro limitata esperienza del mondo e dell’umano.
Invece, riguardo alla tecnologia, a quel che capisco da letture per me convincenti di chi è ben esperto di adolescenza, essa è il corrispondente di quelle competenze e conoscenze contadine che nell’articolo si citano come patrimonio degli studenti della scuola di Barbiana, quel sapere da cui non si può prescindere e da cui partire perché la scuola sia motivante. Per i giovani d’oggi è la rete. Da qui diventa possibile innestare lo studio di Dante, Omero, chi volete.
Aggiungo anche che tutto questo è possibile fin da ora nella scuola pubblica. Non è un limite della struttura, ma di chi ci lavora, che non vi trova il supporto per ideare e attuare pratiche diverse.