I numeri non… contano più
I numeri non… contano più
In un suo recente articolo sul Financial Times, Stuart Kirk lancia una provocazione che merita attenzione: “I numeri non contano più nulla”. La tesi è semplice quanto inquietante: viviamo in un’epoca in cui i dati, pur essendo ovunque, non orientano più le decisioni, non convincono, non generano reazioni proporzionate.
Il numero, da strumento di verità, è diventato simbolo vuoto, ornamento retorico, merce di scambio emotivo: il caso recente dei dazi americani ne è un esempio lampante.
Kirk elenca alcuni esempi emblematici: il debito pubblico statunitense cresce vertiginosamente, ma i mercati restano impassibili; le stime sui droni distrutti in Ucraina oscillano senza suscitare scandalo; le cifre sulla crisi del fentanyl vengono gonfiate senza conseguenze politiche; la valutazione di OpenAI si moltiplica senza che i ricavi la giustifichino. Il numero, insomma, non produce più realtà, ma la simula.
Questa diagnosi, pur centrata sul mondo finanziario e mediatico, apre a una riflessione più ampia: la crisi del numero è la crisi di un intero paradigma conoscitivo. Il dato, che avrebbe dovuto garantire trasparenza e oggettività, si è trasformato in strumento di opacità, in maschera ideologica. Non è più ciò che illumina, ma ciò che nasconde.
E dunque chi pensano di impressionare? Chi credono di poter continuare a convincere i signori (politici in testa) del cosiddetto infotainment?
Davvero si continua a pensare che siamo tutti condizionati o sedotti dal numero di followers o da quello dei downloads? In poche parole: i numeri contano ancora?
La cifra – anche il famigerato numerone detto gooogol (10100) – non riesce più a far presa come una volta. Non cattura. Non innesca alcuna reazione emotiva. Non incuriosisce.
Non conta più.
I morti a Gaza possono arrivare a 100.000. Chi si scandalizza?
I bambini morti per denutrizione oggi sono stati “appena” 21. Chi valuta (valorizza) o percepisce questo dato come UN fatto?
Che valore effettivo hanno oggi 100.000,21, il gooogol?
Zero.
Siamo vissuti e ci siamo “adattati” a un ambiente in cui il dato è stato (e vorrebbe continuare ad essere) la misura di tutte le cose: ogni aspetto dell’esistenza viene macchinalmente tradotto in numeri, e da questi derivano poi grafici, algoritmi con la promessa (o forse l’illusione) di una conoscenza più oggettiva, più precisa, più efficace. Più “utile”.
Ma oggi si avverte un senso diffuso di smarrimento, di disconnessione, di stanchezza. I dati abbondano e ci abbandonano subito, il significato dei numeri sembra sfuggire.
In questo scenario, due pensatori contemporanei – Byung-Chul Han, filosofo della società digitale, e Tim Ingold, antropologo della percezione e dell’abitare – offrono una critica radicale al dominio del dato numerico.
Pur provenendo da ambiti disciplinari differenti, entrambi mettono in discussione l’idea che la realtà possa essere compresa, governata o vissuta attraverso la sola quantificazione.
Nel pensiero di Byung-Chul Han, il dato, nella sua apparente neutralità, diventa lo strumento privilegiato di una nuova forma di controllo: la psicopolitica. Secondo questa analisi ognuno di noi è auto-sfruttato. Si misura, si monitora, si ottimizza. Il dato diventa il linguaggio della performance: passi, battiti, like, produttività, attenzione.
Han denuncia anche l’ideologia della trasparenza, che pretende di rendere tutto visibile, quantificabile, accessibile. Ma ciò che è completamente trasparente è anche piatto, privo di profondità, incapace di generare fiducia o mistero. La trasparenza, lungi dall’essere un valore democratico, diventa un dispositivo di sorveglianza e di conformismo.
 Nel suo libro Infocrazia, Han mostra come l’eccesso di informazione non emancipi, ma disorienti. Il dato, isolato dal contesto, perde la sua capacità di orientare l’azione. La verità si dissolve nel rumore. La conoscenza si riduce a gestione dell’informazione, e il pensiero critico viene sostituito da reazioni immediate, da “click”.
Nel suo libro Infocrazia, Han mostra come l’eccesso di informazione non emancipi, ma disorienti. Il dato, isolato dal contesto, perde la sua capacità di orientare l’azione. La verità si dissolve nel rumore. La conoscenza si riduce a gestione dell’informazione, e il pensiero critico viene sostituito da reazioni immediate, da “click”.
Riflettendo su questa smaterializzazione del mondo, Han ci apre lo sguardo su quei simulacri digitali, come i dati appunto, che ci allontanano dal reale, dal corpo, dalla relazione. Il dato, in quanto astrazione, non ci coinvolge, non ci trasforma, è semplicemente un sapere senza esperienza.
E per Han il dominio del dato è il volto contemporaneo del potere: un potere che seduce invece di reprimere, che misura invece di comprendere, che isola invece di connettere. Contro questo dominio, Han invoca un ritorno alla lentezza, alla contemplazione, al corpo, come luoghi di resistenza e di verità.
Tim Ingold, antropologo britannico, ha dedicato gran parte della sua ricerca a mettere in discussione le modalità con cui le scienze sociali e naturali rappresentano il mondo. La sua critica al data-centrismo nasce da una profonda attenzione al modo in cui gli esseri umani vivono, percepiscono e apprendono nel mondo.
Ingold rifiuta l’idea che la conoscenza consista nell’estrazione di informazioni da un oggetto esterno. Al contrario, propone una “dwelling perspective”, una prospettiva dell’abitare, in cui conoscere significa essere coinvolti, immersi, trasformati dalla relazione con ciò che si studia. In questa visione, il sapere non è una mappa, ma un sentiero; non è una rappresentazione, ma un’esperienza.
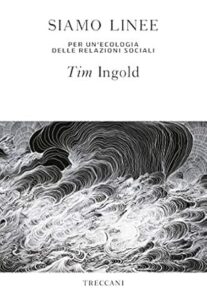 Uno dei concetti chiave del suo pensiero è quello di linea: la vita non è fatta di punti (come i dati), ma di trame, percorsi, intrecci (meshworks). Le linee sono i segni del movimento, dell’interazione, della crescita. I dati, al contrario, sono statici, isolati, privi di tempo. In questo senso, il data-centrismo è una forma di reificazione, che congela il fluire della vita in istanti misurabili.
Uno dei concetti chiave del suo pensiero è quello di linea: la vita non è fatta di punti (come i dati), ma di trame, percorsi, intrecci (meshworks). Le linee sono i segni del movimento, dell’interazione, della crescita. I dati, al contrario, sono statici, isolati, privi di tempo. In questo senso, il data-centrismo è una forma di reificazione, che congela il fluire della vita in istanti misurabili.
Questa visione ha profonde implicazioni per la scienza, l’educazione, la politica. Ingold ci invita a riscoprire la corporeità, la manualità, la lentezza, contro l’astrazione e la velocità del dato. La conoscenza incarnata è una conoscenza che si fa nel fare, che si costruisce nel gesto, che si trasmette nel contatto.
In sintesi, Ingold ci propone una via alternativa alla conoscenza come dominio: una conoscenza situata, relazionale, processuale, che non cerca di possedere il mondo, ma di abitare il suo mistero.
Pur provenendo da tradizioni e discipline differenti, sia Han che Ingold convergono su questo punto essenziale: la conoscenza non può essere separata dal corpo, dal tempo, dalla relazione.
Insieme, Han e Ingold ci offrono una doppia lente per leggere il presente: una che smaschera le illusioni del data-centrismo, l’altra che ci invita a riscoprire la conoscenza come esperienza incarnata, relazionale, trasformativa.
In un mondo che misura tutto ma non sente più nulla, queste analisi sono un invito a resistere con la lentezza, con la cura, con la parola. A rifiutare la riduzione della vita a dato, e a riscoprire la conoscenza come forma di attenzione, di responsabilità, di trasformazione reciproca.
Perché solo una conoscenza che tocca può ancora salvarci dal dominio del dato e dal gelo di una… intelligenza e una coscienza artificiali.
Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/
Per leggere gli articoli, i racconti e le poesie di Giuseppe Ferrara su Periscopio clicca sul nome dell’autore


















Riflessione molto interessante anche in chiave educativa. Una pedagogia dovrebbe essere capace di tenere dentro riflessioni come quelle che vengono proposte nell’articolo, grazie Giordano