Vite di carta /
Sulle colline attorno a Gerusalemme.
Tempo di lettura: 5 minuti
Vite di carta. Sulle colline attorno a Gerusalemme.
“Sulle colline attorno a Gerusalemme e in Cisgiordania, una serie infinita di insediamenti – con i loro leccati giardini verdi e i tetti rossi che si metastatizzavano nelle vallate come un eritema della terra – stridevano crudelmente con le fatiscenti case arabe sottostanti, dove facevano defluire le proprie acque di scarico e spesso scaricavano la spazzatura”.
L’occhio che guarda il paesaggio appartiene ad Amal Abulheja, tornata in Palestina dopo trent’anni di esilio per ritrovare il campo profughi di Jenin dove è cresciuta. È il 2002 e l'”eritema della terra” è una malattia ormai cronicizzata, nei quasi sessant’anni trascorsi dal conflitto del 1948, in cui i soldati israeliani cacciarono la famiglia di Amal dalle sue terre presso il villaggio di ‘Ain Hod, terre di ulivi, mandorle, fichi, agrumi e ortaggi.
 Amal esce dal romanzo di Susan Abulhawa, Ogni mattina a Jenin, libro che ho letto senza potermene staccare e con lo sgomento addosso. L’ho letto nei giorni che hanno preceduto la Giornata della Memoria, mentre ascoltavo svariati telegiornali con gli aggiornamenti da Gaza e da Israele.
Amal esce dal romanzo di Susan Abulhawa, Ogni mattina a Jenin, libro che ho letto senza potermene staccare e con lo sgomento addosso. L’ho letto nei giorni che hanno preceduto la Giornata della Memoria, mentre ascoltavo svariati telegiornali con gli aggiornamenti da Gaza e da Israele.
Il 27 gennaio ho visitato, qui al mio paese, in una delle sue tappe, la mostra fotografica itinerante Stelle senza un cielo. Bambini nella Shoah, curata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme e sostenuta dalla Assemblea legislativa E.R. e dal MEIS di Ferrara.
Ho incamerato dati e commenti da articoli di giornale, ho visto foto di volti e di paesaggi, ho condiviso la condanna a ogni forma di terrorismo, sentito alla tv le voci di alcuni ostaggi ancora nelle mani di Hamas, le dichiarazioni di Netanyahu, le accuse di Israele all’UNRWA, la sentenza inefficace del Tribunale dell’Aia e le parole di Papa Francesco sui bambini vittime della guerra e sul mercato delle armi.
A restituirmi una particolare consapevolezza sul conflitto in atto dallo scorso 7 ottobre, tuttavia, è stato il romanzo di questa giornalista e scrittrice di origini palestinesi la cui vicenda si proietta dentro il libro in alcune vicissitudini della protagonista.
La storia della famiglia Abulheja, costretta nel 1948 a lasciare la casa di ‘Ain Hod per Jenin, è raccontata infatti da Amal, la nipote del patriarca Yehya. La storia della Palestina negli ultimi sessant’anni si intreccia alle vicende di quattro generazioni di questa famiglia, da quella dei nonni di Amal a Sara, la sua unica figlia nata nel 1982 in America e venuta con lei a ritrovare la Palestina nella conclusione del romanzo.
Gli Abulheja assistono alla perdita della terra da parte del loro popolo e alla conquista che ne fanno gli israeliani: subiscono prima l’esilio e la vita sospesa nei campi profughi della Cisgiordania e in Libano, poi la guerra nelle sue fasi più sanguinose e la drammatica perdita degli affetti più cari.
Dopo la morte del padre, il combattente Yussef disperso in seguito alla guerra dei sei giorni del 1967, e della madre Dalia, Amal deve lasciare Jenin e fare l’esperienza dell’orfanotrofio a Gerusalemme, finché nel 1973 ottiene una borsa di studio negli USA e si trasferisce a Filadelfia. Dei primi anni all’università dice: “Mi trasformai in un inclassificabile ibrido arabo-occidentale, sconosciuto e senza radici…Vissi nel presente, tenendo nascosto il passato“.
Mai come questa volta il filtro della narrativa è servito a farmi concepire il punto di vista di un popolo, quello palestinese, quello che oggi, a sessant’anni dalla cacciata dalle proprie terre, continua a rivendicare la sovranità sui territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza, con Gerusalemme Est come capitale.
Al punto in cui si ferma la narrazione di Susan Abulhawa, il 2002, nella Striscia di Gaza si sono verificate almeno altre nove operazioni militari dell’esercito israeliano. Così come Papa Francesco ha affermato di recente alla trasmissione Che tempo che fa, occorre lavorare per la pace nonostante i dati scoraggianti sul floridissimo mercato delle armi che accompagna e tiene viva la guerra. Nonostante l’odio e la sete di vendetta, da una parte e dall’altra.
Pare impossibile oggi districare torti e ragioni nella guerra tra i due popoli. L’eritema della terra, che nel libro Amal vede sotto i suoi occhi, sta lì a mostrare che nemmeno le terre di una parte e dell’altra si possono più districare. La soluzione da tempo invocata dalla comunità internazionale, quella che riserva “due territori per due popoli”, sembra non poter più funzionare.
Cosa rimane? Non resta che entrare ancora una volta nel libro, dove Amal racconta la vicenda straordinaria dei suoi due fratelli costretti a diventare nemici: il primo, Isma’il, rapito da neonato e diventato un soldato israeliano, il secondo, Yussef, che si consacra alla causa palestinese.
Non resta che andare alla fine della storia, quando nel 2001 Amal riceve la visita di questo suo fratello sconosciuto che ha 53 anni e porta il nome David e insieme tentano di riconoscersi e di recuperare le radici comuni, oltre i conflitti e l’odio.
Nel 2002 Amal torna a Jenin con la figlia Sara e con lei frequenta anche i figli di David. La terra di Palestina è cambiata, Jenin è cresciuta in altezza con “baracche costruite sopra a baracche” per dare posto a quarantacinquemila abitanti in due chilometri quadrati e mezzo. Eppure è la radice di vita per Amal e lo diventa presto per Sara, che diviene la depositaria delle storie della famiglia e della causa palestinese.
Espulsa e rimandata negli Stati Uniti, Sara riesce a portare con sé il cugino Jacob, figlio di David, e l’amico Mansur. A Filadelfia, nella vecchia casa in stile vittoriano restaurata dalle mani di Amal, vivono “un’americana, un israeliano e un palestinese”.
Senza passato Amal non ha saputo stare e, lei dice, non possono stare i palestinesi. Guai a essere creature senza memoria: vale per tutti i popoli. Riconoscere i torti commessi, secondo Susan Abulhawa, può costituire il primo passo verso la pace e la conciliazione.
Nota bibliografica:
- Susan Abulhawa, Ogni mattina a Jenin, Feltrinelli, 2011
Per leggere gli altri articoli di Vite di carta la rubrica quindicinale di Roberta Barbieri clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autrice










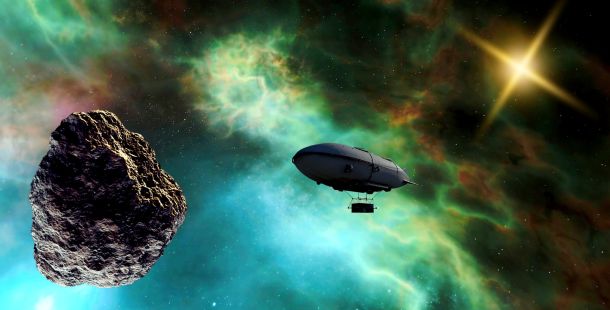







Lascia un commento