Vite di carta /
La terra sbagliata dello scrittore albanese Gazmend Kapllani
Tempo di lettura: 4 minuti
Vite di carta. La terra sbagliata dello scrittore albanese Gazmend Kapllani.
Di ogni libro che si legge bisognerebbe poter parlare con qualcuno. Oggi vorrei che Maria, mia compagna nel recente viaggio dentro il Festivaletteratura 2023 a Mantova, potesse essere qui e discutere con me del libro che Gazmend Kapllani ha presentato nella bella cornice di Santa Barbara giovedì 7 settembre.
E vorrei scrivere a Simonetta Bitasi che ha gestito l’incontro con Kapllani e con l’autrice italo-bosniaca Elvira Mujčić, per dirle che mi è servita la chiave di lettura da lei suggerita, anche se nel corso della lettura ho dovuto ridefinirne i confini semantici.
 Mi è stato utile cominciare La terra sbagliata aspettandomi un romanzo politico: è vero che la politica e la storia dell’Albania escono in primo piano a un certo punto del racconto, dopo un inizio dedicato alla vicenda personale di Karl, che da emigrato torna a casa per il funerale del padre dopo molti anni di lontananza, e della sua famiglia che invece è rimasta tenacemente legata al sortilegio della città natale, Ters (in albanese con due accezioni di significato, “sortilegio” e più in negativo “malocchio”).
Mi è stato utile cominciare La terra sbagliata aspettandomi un romanzo politico: è vero che la politica e la storia dell’Albania escono in primo piano a un certo punto del racconto, dopo un inizio dedicato alla vicenda personale di Karl, che da emigrato torna a casa per il funerale del padre dopo molti anni di lontananza, e della sua famiglia che invece è rimasta tenacemente legata al sortilegio della città natale, Ters (in albanese con due accezioni di significato, “sortilegio” e più in negativo “malocchio”).
Il romanzo racconta la massiccia emigrazione albanese seguita alla caduta del regime comunista negli anni Novanta, quando gli studenti di Tirana in segno di protesta occuparono le università e uccisero la dittatura facendo a pezzi la statua di Enver Hoxha.
Tra questi ragazzi c’è Karl. Si trova Karl anche tra i tanti che in seguito partirono dall’Albania per materializzare i loro sogni di libertà, andando in Europa, America, Australia, ovunque potessero, o nella vicina Grecia come accade al nostro protagonista.
Il romanzo mette a fuoco molto bene anche la visione del mondo della sua famiglia rimasta a Ters, del padre e del fratello, la cui voce emerge alla fine di buona parte dei capitoli. In caratteri corsivi si leggono le parole di Frederik , la sua dissonanza rispetto alle scelte di Karl, la cui vita è andata avanti in altri paesi (dopo la Grecia, l’America), con altre donne a fianco, con il bagaglio delle lingue straniere imparate che si è accresciuto facendo lievitare in lui una identità aperta e sempre problematica.
Nella stessa pagina in cui Karl decide di fuggire dalla schiavitù a cui la dittatura ha ridotto gli albanesi e rinfaccia al padre la sua ortodossia comunista, il fratello prende la parola per ricordargli gli insegnamenti paterni sulla importanza delle radici, della famiglia e della nazione. Due modi contrapposti di rapportarsi al proprio paese, alla origine di sé e al futuro.
A questo punto ho dovuto ripensare al significato di romanzo “politico” e includervi una accezione di più vasta portata e una che porta lo zoom narrativo su una scala decisamente più ridotta, di carattere personale e intimo. La prima va riferita all’orizzonte più ampio e generale, quello del sistema mondo in cui la migrazione di individui e popoli è da sempre un carattere costitutivo, frutto e causa di squilibri e ri-categorizzazioni degli assetti geopolitici.
“L’essere umano vive in un complesso equilibrio tra noto e ignoto, tra necessità di un radicamento e voglia di partire, di cambiare la propria situazione, di ribellarsi a un passato che non lo definisce più. Persino il più tradizionalista degli uomini, se guardasse al proprio albero genealogico, alla costituzione del proprio DNA, scoprirebbe di essere il frutto di una qualche migrazione”: mi soccorrono le parole che trovo nella postfazione scritta dai due traduttori del romanzo, Ermal Rrena, emigrato da Tirana proprio come Karl nel 1991, e la milanese Rossella Monaco.
I quali aggiungono: “Accade che emigrare è un lavoro: presuppone visione, speranza, impegno, fatica, obblighi, in vista di una vita migliore… Ma emigrare è anche un diritto, specie – aggiungo io – quando coloro che partono fuggono da un paese che disattende i caratteri della polis e si fa terra di diritti calpestati e di guerre.
Nella parabola di vita di Karl questa prima accezione che potrei definire ecumenica si intreccia con l’altra, più intima e personale del figlio in lotta col proprio padre. “Nello scontro generazionale… si ritrova tutta la forza politica delle decisioni umane. Il figlio non comprende lo sforzo di costruzione del padre e il punto di vista del fratello che ha finito per incarnare quello del genitore. Il padre e il fratello non comprendono la sua volontà di definirsi attraverso l’incontro con l’altro“.
Allontanandosi dalla terra sbagliata ha trovato coordinate esistenziali più autentiche, come la donna che ha amato dalla giovinezza, perduta e poi miracolosamente ritrovata, e come il mestiere dello scrittore.
Quando torna per due settimane a Ters per il funerale del padre rivela a se stesso che nulla è davvero cambiato: le sue scelte confermate, la contrapposizione con la fissità della vita del fratello confermata e resa ancora più netta. Al nazionalismo di Frederik che concepisce le proprie radici soltanto in senso geografico e culturale, Karl risponde con altre radici, dal significato più ampio, esistenziale.
Se Maria fosse qui condividerei con lei un’ultima frase molto bella in cui Rrena e Monaco parlano della difficoltà del tradurre e di ogni lingua come scrigno fluido e pulsante di una visione del mondo. La frase è questa: “nella traduzione convivono… l’incontro e lo scontro, l’impossibilità di dire la stessa identica cosa in lingue diverse, la volontà di avvicinarsi ai significati, alla musica, ai ritmi, alle immagini che fanno di un popolo quel che è. Di aprirsi invece di imporsi. Di lasciar andare invece di afferrare”.
Nota bibliografica:
- Gazmend Kapllani, La terra sbagliata, Del Vecchio Editore, 2022 (traduzione di Ermal Rrena e Rossella Monaco)
Per leggere gli altri articoli di Vite di carta la rubrica quindicinale di Roberta Barbieri clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autrice











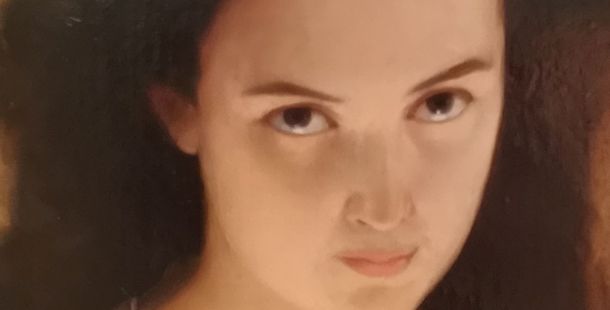






molto bello e interessante stimolante