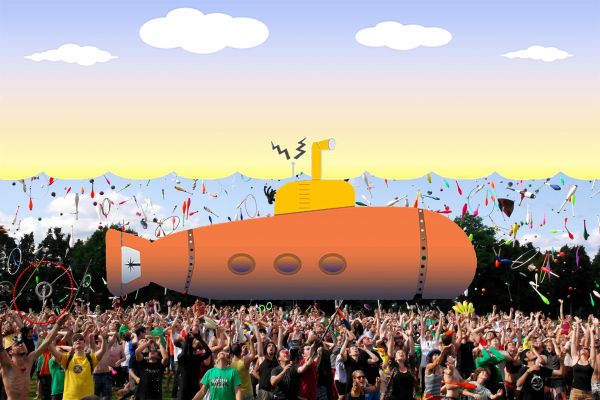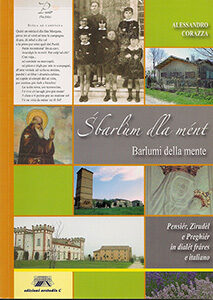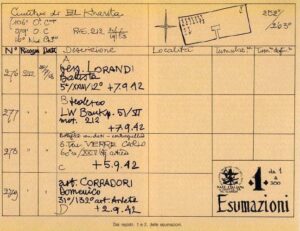La “Transizione” ecologica non basta:
dobbiamo trasformare e reinventare un mondo ecologico
Sentire parlare dei progetti per la transizione ecologica mi lascia perplessa tanto quanto parlare della decrescita felice di Latouche e di Mercalli che sono, secondo me, due facce di un unico modello di organizzazione sociale che non pone al centro l’essere umano né come valore né come motivo dello sviluppo in quanto basate comunque sul mercato.
Sia la transizione ecologica sia la decrescita felice rimandano solo l’esaurimento delle risorse, non portano a una trasformazione di un modo di concepire la vita di un essere umano che si assume il compito di prendersi cura dell’ambiente e la responsabilità di renderlo un luogo dove la vita, pur nella sua complessità e difficoltà, prende gusto e bellezza.
Il concetto di ecologia non significa limitarsi ad un cambiamento superficiale o immediato, ma vuol dire acquisire la dimensione della complessità nella quale ogni elemento della realtà concorre allo sviluppo qualitativo di ogni altra parte.
Di conseguenza, acquisire la dimensione ecologica vuol dire riconoscere gli esseri umani come soggetti che vivono la vita come tempo per realizzare i propri sogni, e l’ambiente come spazio piacevole da condividere con coloro con i quali si trovano a vivere. Quindi, ogni attività umana dovrebbe essere finalizzata all’obiettivo di individuare e supportare la globalità delle strutture passando per la scuola, la ricerca, la conoscenza. E non limitandosi alla soddisfazione dei bisogni primari che risolvono la sopravvivenza ma non il futuro.
È assolutamente necessario ridurre lo spreco cambiando il modello di sviluppo in direzione del miglioramento della qualità della vita. Oggi, con le nuove tecnologie a disposizione, si potrebbero progettare fabbriche che garantiscano una produzione di oggetti in maniera flessibile e pianificabile, soprattutto se i prodotti sono di buona qualità e di durata almeno trentennale, perché il riciclo dei materiali non basta. Perché questo avvenga sarebbe necessario studiare una politica industriale creativa e davvero rivoluzionaria che prenda in considerazione l’uso delle risorse nel rispetto della terra, senza perdere di vista la salvaguardia del lavoro, che rimane un diritto inalienabile per tutti.
Cambiare i motori a scoppio con motori elettrici non è una trasformazione ecologica, ma solo uno specchio per le allodole, perché ciò che non si produce di scarto per il funzionamento della macchina, si produrrà nello smaltimento delle batterie o per la produzione dell’energia elettrica. Si continuerà comunque a produrre milioni di macchine che avranno bisogno di innumerevoli risorse per tutto il loro ciclo di vita.
Dovremmo usare la nostra fantasia per creare ciò che serve all’essere umano per vivere una vita qualitativamente degna e non, piuttosto, consumare per produrre per mantenere attive le industrie.
Oggi siamo ridotti a essere un ingranaggio di un sistema che noi stessi abbiamo creato, nel quale il lavoro umano deve costare il meno possibile, perché lo scopo non è la qualità della vita ma il ritorno finanziario. Inoltre, il nostro adeguamento al consumo rende impossibile qualsiasi condivisione se non una realtà disumanizzata e abitudinaria.
Questi due anni di pandemia hanno messo in evidenza quanto poco sappiamo del corpo umano, della natura, di noi stessi e di quanto ci circonda. Se vogliamo cambiare veramente dobbiamo innanzitutto metterci in un atteggiamento di ascolto, di conoscenza, di ricerca, tenendo sempre presente le cose che in questi due anni ci sono mancate: la relazione con gli altri e con l’ambiente e la dimensione della libertà. Questi elementi faticosamente conquistati nel corso della storia, li abbiamo dispersi e vanificati come valori superflui negli ultimi trent’anni, mettendo al loro posto il consumo veloce delle emozioni e delle cose, come un necessario motore di una produzione che non trasforma niente in bellezza, ma che produce solo scarti e spazzatura.
Quando, agli inizi del primo lockdwon, abbiamo spalancato le finestre sulle strade deserte, ci siamo ricordati di quanto fosse bello stare insieme, stringersi le mani, prendere un caffè scambiando due chiacchere. Tutti abbiamo sperato che il dopo covid sarebbe stato diverso, abbiamo condiviso il piacere di vedere la natura tornare ad abitare in mezzo a noi. Abbiamo constatato che la natura è pronta a sostenere un nostro cambiamento di rotta se decidiamo di prendere la strada del rispetto, dell’utilizzo delle risorse e non dello spreco. Ma, finita l’emergenza, ce ne siamo prontamente dimenticati, travolti dalla necessità di tornare alla vita di prima, come se questa fosse stata di nostro gradimento e soddisfazione.
Per fare un passo avanti, e in questi mesi di chiusura ce ne siamo resi conto, dobbiamo trasformare l’intero il sistema educativo, formativo e informativo nell’intento di acquisire consapevolezza che il valore è l’essere umano e il suo ambiente nelle sue relazioni, mentre adesso è tutto fondato sulla competizione, sull’individuare l’errore, sul considerare l’altro come nemico.
L ‘accelerazione della ricerca sui vaccini di questo ultimo anno o poco più e la loro produzione in tempi inediti ha dimostrato che la condivisione della conoscenza, insieme all’obiettivo condiviso può accelerare il raggiungimento dei risultati. Perché non assumiamo questo modello, diffondendo la necessità di rendere attiva la Carta dei Diritti Umani che in pochissime realtà sono democraticamente esercitati? Sarebbe tempo di investire perché questi non rimangano solo enunciazioni su carta, ma siano pratica universale e corrente di tutte le società umane. In questo modo cadrebbero diffidenze e resistenze tra i diversi stati. Perché questo non avviene? Forse perché le mafie, il mercato delle armi e della droga ne patirebbero?
Dovremmo investire il massimo delle risorse per la ricerca di base, perché la società deve cambiare e per questo cambiamento è necessario investire in cultura, in strutture che possano supportare questo cambiamento di priorità di rapporti sia nell’organizzazione delle relazioni sociali sia del lavoro che diventerebbe finalmente ciò che dovrebbe essere: non solo sostentamento e necessità ma l’espressione della creatività di ciascuno nella costruzione di una realtà sempre più accogliente e sempre meno monotona.
La storia dimostra che se noi costruiamo accoglienza e bellezza, questo rimane per molte generazioni e migliora con il passare del tempo perché innesca un meccanismo di creatività positiva in chi ne gode. Dobbiamo dare un linguaggio a questa consapevolezza affinché si riconoscano queste azioni come valore, e perché ciò avvenga dobbiamo investire tutto ciò che possiamo nel creare occasioni formative e di scambio.
Dunque, c’è molto da trasformare e reinventare per costruire un mondo ecologico perché questo vuol dire proprio armonia fra le parti e gusto dell’incontro con l’altro. Il problema del futuro non sarà quindi la mancanza di lavoro, sarà piuttosto la difficoltà di rispondere a tanti interrogativi, di metterci alla prova nella nostra capacità di accoglienza dell’altro tanto da riuscire ad integrarci per risolvere le problematiche che via via ci si presenteranno.
Quando il mondo politico troverà il coraggio di riprendersi il suo spazio legittimo di lungimirante progettualità per una società migliore, più giusta e più democratica? Quando le università torneranno a essere i luoghi di una ricerca che investe sulla curiosità e sull’entusiasmo per la trasformazione del mondo? Diamo valore a queste doti che i giovani, se riconosciuti e supportati, hanno naturalmente.