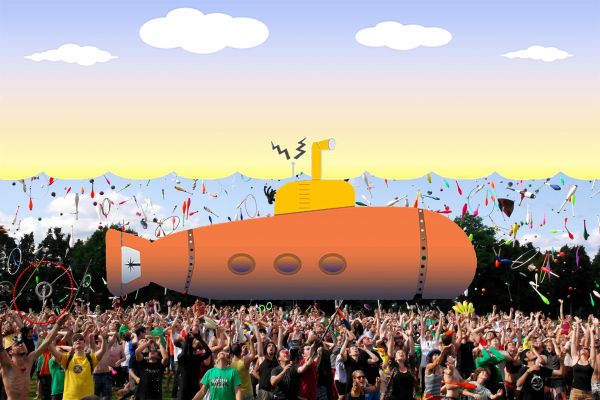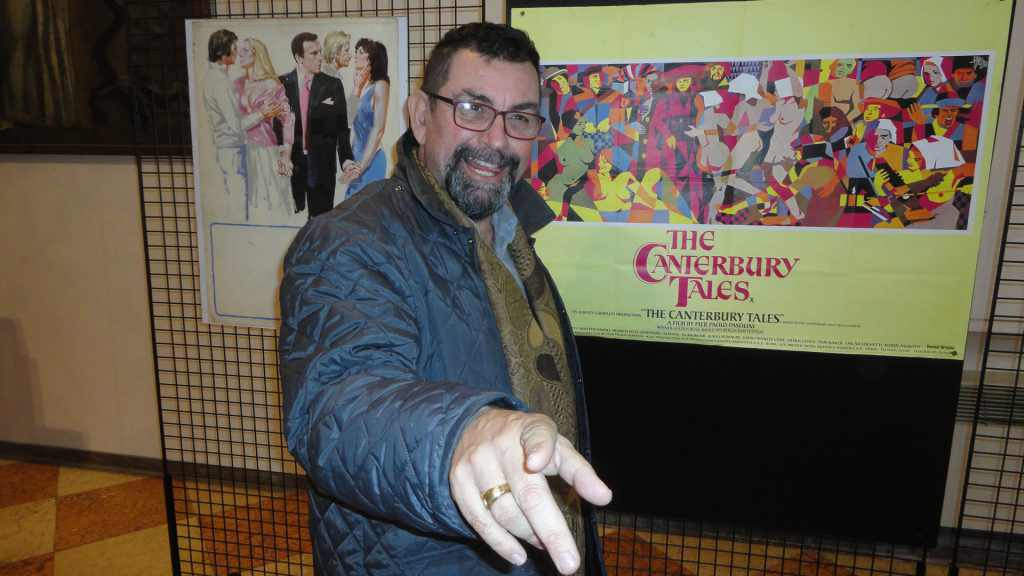Di seguito l’intervista al prof. Sergio Cesaratto dell’Università degli Studi di Siena e autore del libro “Sei lezioni di economia – Conoscenze necessarie per capire la crisi (e come uscirne)”, Imprimatur, 2016.
L’austerità è causata dal debito pubblico o dai deficit esteri? E questi interagiscono con l’occupazione? Le politiche monetarie e la moneta, le politiche keynesiane e il neoliberismo, il capitalismo, il socialismo e i politici che leggono poco, il ruolo della Germania nel mondo oltre che in Europa e gli Stati Uniti, il professor Cesaratto ha accettato una lunga chiacchierata su questi temi.
In fondo all’articolo l’intervista è scaricabile in pdf.
Professore, a chi si rivolge il suo libro?
A tutti. Naturalmente a chi voglia fare un minimo di fatica. Non solo agli economisti di professione ma anche ai cittadini che in questi anni si sono resi conto che bisognava capire meglio quello che stava accadendo. Il libro si rivolge naturalmente anche agli studenti che scoprono un mondo nuovo, si rendono conto che esiste anche una analisi economica alternativa, poi ci sono i giornalisti, quindi un po’ a tutti direi. Chi si riesce a penetrare di meno sono i politici, un po’ forse perché non leggono, anche se debbo dire che D’Attorre, Fassina, Ferrero o altri magari lo fanno ma lì, nel mondo della politica, è più difficile, non sono abituati a leggere probabilmente.
Lei mi ha nominato tutti politici dell’area di sinistra.
Guardi io non ho tanta fiducia nei politici della sinistra ma ancor meno nei politici della destra per tantissimi motivi, insomma. Non ho fiducia nella maggior parte della sinistra. Totalmente disastrosa, insegue dei principi astratti, si sta allontanando sempre di più dalla gente normale. È elitaria, cosmopolita, fondamentalmente neoliberista.
In Italia non abbiamo nemmeno però la Le Pen che viene da una tradizione francese che vede al centro lo stato, l’intervento pubblico. In Italia abbiamo Salvini che insieme ai suoi economisti di riferimento sono molto liberisti e penso che lui, come anche la Meloni, sia interessato a rimettersi con Berlusconi e ritornare al Governo. Non ho nessuna fiducia politica né nelle loro idee ne in quello che presumibilmente farebbero se fossero eletti al Governo.
Ho pochissima fiducia anche nella cosiddetta sinistra però, come dire, quello è il mio mondo. In ogni caso sono disposto a parlare con tutti.
Torniamo al libro per parlare del sovrappiù, quella parte di produzione che eccede il consumo o i bisogni immediati. Ricardo lo enuncia come contrasto tra capitalisti terrieri e industriali, poi viene ripreso da Marx per diventare motivo del contendere tra lavoratori e capitalisti, perché secondo Marx questi ultimi se ne appropriano togliendolo ai lavoratori che lo hanno creato. Si arriva a Keynes dopo la crisi del ’29 e si passa alla domanda aggregata come concetto macroeconomico di termometro del benessere collettivo, della distribuzione del reddito. Perché se c’è una buona domanda aggregata, cioè se la gente spende, acquista, vuol dire che ne ha la possibilità, che il sovrappiù è stato distribuito a tutti e viene utilizzato spendendo, comprando più beni. Se la spesa si contrae e con essa la domanda aggregata, allora è un sintomo che qualcosa non va nell’economia e nella distribuzione del reddito.
Assolutamente sì.
Monti però in un’intervista alla CNN dichiarò che il suo governo stava distruggendo la domanda aggregata, quindi di fatto cosa voleva fare, aumentare le disuguaglianze?
Beh sicuramente è strutturale all’economia di mercato che, da un lato, chi ha il controllo dell’economia, semplificando i capitalisti, è interessato a che il sistema sia diseguale, quindi salari bassi e profitti alti. Naturalmente, non è che siano sciocchi e in certe fasi sono anche disponibili a ricorrere a Keynes e anche Monti conosce Keynes, ovviamente, e sa anche come stanno le cose.
Sono ricorsi a Keynes per due o tre decenni dopo la 2^ Guerra Mondiale. In quel periodo c’era la sfida sovietica e quindi il capitalismo doveva funzionare, ed essere anche eticamente presentabile, si estese la giustizia sociale, si stimolò la domanda. Quando la sfida sovietica è venuta meno il capitalismo è tornato alla faccia cattiva.
Gli Stati Uniti, ma anche la Cina, hanno adottato politiche Keynesiane per uscire dalla crisi, certo non dal punto di vista della distribuzione del reddito ma comunque hanno fatto spesa pubblica, infrastrutture e quant’altro.
Purtroppo in Europa abbiamo la Germania che è legata tenacemente ad un modello che non sostiene la propria domanda interna ma si basa sull’espansione della domanda negli altri paesi, a maggior ragione se questi sostenendo la propria la domanda interna creano lavoro e occupazione lasciando crescere i salari. In tal modo la Germania guadagna competitività. La Germania è il vero scandalo europeo, il vero impedimento ad una vera unificazione. Senza, forse, l’Europa si sarebbe unificata magari a guida Francese. I francesi certo non sono dei santi, e lo testimonia il loro operato in Libia, però forse con francesi e inglesi ci si ragiona un po’ di più mentre con i tedeschi ragionare è impossibile.
Un’Europa a guida tedesca non sembra un buon affare. Nel capitolo IV del suo libro Lei dice che Mitterand dovette abbandonare l’idea di fare una politica estera accomodante e cooperativa perché i tedeschi non rinunciavano a un mercantilismo spinto. Come ci si difende dagli esportatori di professione, e senza unione monetaria pensa sarebbe più facile?
Certo. La flessibilità del cambio è una forma di difesa. Mettersi con i tedeschi è pericoloso, Federico Caffè (un grande abruzzese!) diceva “mai con i tedeschi”. Anche la Banca d’Italia prima del disastro della guida Ciampi, e con Visco ancora peggio, era contro l’euro. La Germania era un problema anche prima dell’euro, negli anni ’50 perseguiva lo stesso modello appoggiandosi ai cambi fissi concordati nel 1944 a Bretton Woods. Lasciava fare il keynesismo agli altri e lei si lasciava guidare dalle esportazioni.
Subito dopo la guerra di Corea si creò un boom di domanda. Sfruttando le sue capacità tecnologiche, perché anche se l’industria all’epoca era distrutta aveva i suoi ingegneri, il surplus commerciale tedesco raggiunse subito un volume che negli anni ’50 un autore definì grottesco. Quindi la storia è vecchia, la Germania è il problema dell’economia mondiale e non è un paese cooperativo. E non è nemmeno un paese imperiale nel senso buono, quelle di cui ha bisogno il mondo, come gli Stati uniti nel secondo dopoguerra e come lo era l’Impero Romano. Un impero deve dare garanzia di pace e sicurezza e fare da “demand of last resort”, avere quindi un mercato interno che sostenga l’economia mondiale.
Gli Stati Uniti lo hanno fatto e lo fanno, hanno la moneta di riserva per eccellenza e quindi tutti accettano di essere pagati in dollari. Tutti acquisiscono dollari ma vendono nel mercato americano, l’impero deve fare così, la Germania è una pessima potenza imperiale. E’ un impero nel senso più deteriore, non dà una leadership ma opprime.
Quindi il problema della Germania è che vuole solo vendere e non comprare. Lascia fare il keynesismo agli altri perché non è interessato alla propria domanda interna, vuole vendere i suoi prodotti all’estero e se gli altri paesi si sviluppano possono comprargliene di più e questo gli sta bene, ma non si preoccupa nemmeno di deprimerli come fa nel mercato dell’eurozona. Quindi approfitta del presente ma non crea le condizioni per il futuro dimostrando oltretutto di non avere visione e un Paese senza visione non può esercitare una leadership credibile.
Gli Stati uniti possono comprare i prodotti esteri potendo pagare con i dollari, e questo va benissimo. Certo bisogna dire che il capitalismo è una forma economica del tutto irrazionale. La forma economica razionale sarebbe il socialismo che a sua volta ha dimostrato una serie di problemi, è fallito per altre ragioni. È vero che il capitalismo, nella sua irrazionalità, qualcosa ti dà in cambio, è basato sull’egoismo e l’egoismo qualcosa ti porta, fa leva su una parte dell’indole umana non particolarmente encomiabile, cioè l’egoismo individuale. Il socialismo paradossalmente fallisce perché l’egoismo purtroppo viene fuori anche lì, magari c’è la piena occupazione, ma la gente, sicura del “posto”, non vuole lavorare. Un grande problema il socialismo, se dovessi scrivere un altro libro, un altro capitolo lo dedicherei ai problemi del socialismo.
Il problema è che oggi non c’è un’alternativa al capitalismo di conseguenza capire le difficoltà del socialismo è molto importante. Non si capisce perché le vicende umane, il nostro stesso benessere, devono essere guidate da un meccanismo esterno alla nostra volontà e alla nostra ragione, che fanno leva sull’egoismo. Qualcosa di meglio, in fondo, si potrebbe trovare.
Euro sì euro no, mi sembra ci sia indecisione nello stesso mondo accademico. Anche chi come lei non è un fautore della moneta unica non mi sembra proponga una risposta chiara.
Ammetto di sfuggire un po’ a questo problema. L’euro potrebbe cadere se Draghi interrompesse il sostegno ai titoli pubblici attraverso il Quantitative Easing, gli interessi sui titoli italiano risalirebbero a livelli insostenibili e allora dovremmo decidere se uscire o accettare la troika, una deriva Greca quindi, se non peggio. Li sarà la gente a decidere se accettare la troika e finire in una maniera terribile o a quel punto l’alternativa sarebbe affrontare le difficoltà di una rottura con l’euro.
Non lo so se l’euro è destinato a rompersi o meno, comunque vedevo stamattina un articolo su un giornale importante (17 febbraio n.d.r.) che raccontava che le famiglie greche sono oramai al collasso, affidano i figli a istituti di carità.
Qualche economista pensa che una svalutazione dovuta ad un’uscita dalla moneta unica e conseguente ritorno ad una moneta nazionale potrebbe far crollare i salari. Lei cosa ne pensa?
Direi che questi stanno crollando anche adesso e crollano fondamentalmente per due ragioni: la prima è che i salari reali sono diminuiti e in secondo luogo perché c’è disoccupazione. Io non guardo al salario ma guardo al reddito complessivo di una famiglia, se prima lavoravano padre, madre e il figlio maggiorenne, adesso lavora solo la madre (magari ad orario ridotto), quindi il reddito delle famiglie nel suo insieme è crollato. Allora come diceva giustamente Bagnai sul Financial Times, e credo che riprenda il mio pensiero, può darsi pure che la svalutazione, almeno all’inizio, incida negativamente sui salari reali, però se favorisce l’occupazione i redditi delle famiglie aumentano, cioè aumenta il complesso dei salari reali delle famiglie (cioè la capacità di acquisto n.d.r.). Quando riprende l’occupazione, l’ammontare dei redditi che va alle famiglie aumenta.
Se l’economia riprende ad espandersi finalmente riprende, la produttività che adesso langue per mancanza di domanda che a sua volta fa marciare le imprese a ritmi ridotti. Riprende la produttività e poi riprenderanno anche i salari reali.
Quindi non è una svalutazione che provoca una diminuzione dei salari ma la volontà (o la necessità) di volersi sviluppare attraverso le esportazioni, cioè compressione salariale per essere competitivi.
Se vuoi acquistare competitività verso l’esterno devi contemplare anche una diminuzione salariale, può darsi, almeno nel breve periodo, però se riprende l’occupazione riprendono i redditi delle famiglie. Magari il padre lavora, la madre guadagna un po’ di meno di prima, ma lavora a tempo pieno e il figlio magari part time ma lavora, insomma riprende tutto. E non è che questo è un modello “export led”, vuol dire solo che riprendere la competitività esterna ti consente di espandere poi la domanda interna utilizzando la politica fiscale senza incorrere appunto nel vincolo estero. Stai esportando di più quindi puoi anche permetterti di importare di più e abbassare le tasse.
Volendo sintetizzare il suo ragionamento direi così: all’inizio comprimo i salari per essere più competitivo e poter esportare di più. Accumulo soldi per poter spendere e comprare all’estero e quando la bilancia dei pagamenti sarà in equilibrio potrò utilizzare la leva fiscale, cioè potrò abbassare le tasse, per lasciare più soldi ai cittadini da spendere e aumentare così la domanda interna.
No, più che alla diminuzione dell’imposizione fiscale penso a una espansione della spesa pubblica (che ha anche la forma di salario indiretto ovvero di servizi sociali). Circa i salari reali, questi devono assolutamente crescere nel lungo periodo per sostenere la domanda.
Lei parla anche del Quantitative Easing, operazione della BCE attraverso la quale vengono comprati i titoli di stato dei paesi dell’eurozona e quindi anche i BTP italiani. Questa operazione dovrebbe servire a diminuire i debiti degli stati attraverso quello che in contabilità si chiama consolidamento. A marzo sono stati acquistati un totale ormai di 233 miliardi di titoli, verranno quindi consolidati e cioè stracciati e scalati dai 2.228 miliardi di debito pubblico contabilizzato?
Sì, in via di principio è così. Anche se non venissero comprati più titoli di debito pubblico non è che la Banca d’Italia si mette a rivendere quelli comprati. E questo è un consolidamento. C’è anche da dire poi che è vero che si pagano degli interessi su questi titoli ma una parte ritornano indietro al Tesoro.
Sì ma il debito pubblico reale dovrebbe essere più basso di quello indicato, al di là degli interessi pagati o incassati per opera del cosiddetto signoraggio. Una volta ricomprato il debito, i titoli che lo attestavano dovrebbero essere eliminati.
Certo, se la banca centrale appartiene allo Stato, emette liquidità, si ricompra i titoli e quindi li può stracciare. Se ha ricomprato 233 miliardi di titoli questi non fanno più parte del debito pubblico. In realtà la BCE potrebbe ricomprarsi tutto il debito, certo è chiaro che si crea liquidità e non è che questo è senza problemi.
Come dire, si può fare ma va fatto con criterio. Altrimenti la liquidità creata creerebbe inflazione?
Chi possedeva i titoli non è che spenderebbe la liquidità ricevuta, perché chi aveva i titoli li acquistati per investire dei risparmi, impiegando dunque dei quattrini che non aveva intenzione di spendere. Nel momento che li riavesse indietro, evidentemente continuerà a non volerli spendere. Quindi l’idea che si inonda il mercato di liquidità, che la gente spende e si crea inflazione non è fondata. Le persone che non avevano intenzione di spendere dei fondi prima, non li spenderanno dopo.
Certo questo potrebbe portare squilibri a vario titolo. Ci sono rischi sia con il QE americano che con quello europeo perché questa liquidità spesso finisce nei mercati dei paesi emergenti, fondi pensione, fondi comuni, mercati in cui i rendimenti sono più alti. Questo potrebbe portare ad una svalutazione di dollaro ed euro e ad una rivalutazione delle valute di quei paesi che si ritroverebbero monete forti che danneggiano la loro competitività. In più questa abbondanza di liquidità in questi mercati può creare bolle speculative, un esempio classico sono le bolle edilizie. Quindi paradossalmente il nostro Q.E. può essere un problema per i paesi emergenti mentre per noi rappresenta parte della soluzione.
Funzionerebbe meglio per il sistema e a livello macroeconomico se la liquidità immessa col QE fosse utilizzata per acquistare titoli deteriorati o di aziende a rischio fallimento?
Di quali aziende, con quali criteri selettivi… in effetti il QE è stato esteso alle grandi corporation, però qui entriamo un po’ nel libero arbitrio. Di fatto è già stato esteso. Comunque la Banca Centrale potrebbe benissimo intervenire per sistemare le banche a rischio fallimento, comprare i titoli tossici insomma.
Direi che non mi sembra poco. Adottare una soluzione del genere, che quindi mi sembra di capire sia possibile, risolverebbe i problemi di tanti risparmiatori e darebbe più fiducia al sistema bancario. Il QE dimostra, comunque, che è possibile stampare moneta senza necessariamente creare inflazione e rispettando determinati criteri. Che è possibile monetizzare il debito degli stati e che quindi in questo modo il debito pubblico potrebbe essere sotto controllo.
Da un punto di vista keynesiano lo Stato prima spende e poi raccoglie le tasse o i risparmi dei cittadini (se le imposte fossero sufficienti). Però prima lo Stato spende, crea moneta, e da un punto di vista keynesiano deve essere così. Poi quando riscuote le imposte, ritira questa moneta, quindi non è che questa moneta aumenta ogni anno di più proprio perché con l’imposizione fiscale la ritira. Questo è assolutamente vero in generale però qual è il punto, e questo anche per rispondere alle idee della MMT, qual è il limite della spesa pubblica finanziata dalla Banca Centrale attraverso la stampa della moneta? Il vincolo estero!
Vale a dire che, a meno di essere gli Stati Uniti, va benissimo spendere anche facendosi finanziare dalla banca centrale per sostenere la domanda e l’occupazione, ma se cresce troppo la domanda interna questo conduce ad importazioni troppo forti dall’estero e questo comporta indebitamento. La MMT ritiene che si possano pagare le importazioni in lire e questa è un’assoluta falsità, che illude qualche migliaio di persone che seguono la MMT.
Certo possiamo fatturare in lire ma dobbiamo garantire che la lira sia convertibile in moneta di riserva, dollari o monete forti, quindi questo è il limite a cui bisogna stare molto attenti, che non vuol dire che per crescere non ci si possa indebitare con l’estero, però deve farlo entro limiti molto forti.
Quindi è vera una parte dell’affermazione, lo Stato può benissimo spendere finanziandosi presso la banca centrale ma attenzione, un limite c’è insomma.
Si però immagino che questo limite sia più forte nel momento in cui si parli di uno stato debole, con poca capacità produttiva.
Beh storicamente l’Italia, ma anche la Francia hanno incontrato dei limiti.
Non mi sembra che abbiamo avuto storicamente grandi problemi con la bilancia dei pagamenti, direi che siamo sempre stati in grado di affrontare anche le situazioni più drammatiche come le due crisi petrolifere degli anni ‘70.
Possono permettersi di finanziarsi in questo modo Stati Uniti, i paesi di origine anglosassone, forse meno la Gran Bretagna, più il Canada, la Nuova Zelanda, l’Australia perché sono paesi affidabili, hanno un sacco di risorse naturali. La loro moneta è abbastanza accettata anche se sono in disavanzo estero e questo non è sostenibile per tutto il resto dei paesi del mondo. Punto. La MMT può raccontare quello che gli pare e piace, io ho messo sul blog una sorta di settima lezione del libro su questo argomento perché Wray, Mosler e altri scrivono spesso tutto e il contrario di tutto, e con chi usa questo metodo poi è difficile anche discutere.
Io mi sento a disagio con alcuni degli “economisti” che impazzano sul web, spesso improvvisatori e autodidatti. Ci vogliono studi solidi e maestri.
Lascio aperto il discorso esportazioni e capacità dell’Italia di tenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti, magari merita un approfondimento. Chi è il più improvvisatore?
Non facciamo nomi
Va bene. Mi chiedo e le chiedo: se è possibile monetizzare il debito, se una banca centrale può comprare titoli degli stati e quindi il suo debito, allora perché non lo fa? Immagino perché tenendo alta la paura del debito pubblico nelle persone, si rendono lecite tutte le politiche di austerity, alta tassazione, calo dei servizi e via dicendo.
L’austerità ha come strumento l’abbattimento del debito pubblico, ma il vero obiettivo dell’austerità è il debito estero. In questo modo i paesi riducono le loro importazioni, quindi una parte del loro disavanzo commerciale, e segnatamente le partite correnti, e cominciano a restituire o comunque non aumentano ulteriormente il loro debito estero. È questo che si vuole tenere sotto controllo.
In un certo senso è anche ragionevole, ma dipende dal contesto. È da ricordare che il debito italiano è piccolo, il debito estero della spagna è molto più grande. Il nostro debito netto è il 25% del PIL, la Spagna il 90%. La Spagna ha un debito privato elevato e un debito estero elevato. In linea di principio è messa peggio dell’Italia. Però siccome la Spagna ha fatto riforme del lavoro più feroci di quelle italiane la Commissione Europea è più accomodante. E questo le permette di fare politiche in disavanzo senza incorrere in procedure per levato deficit, come invece succede a noi.
Professore, ha senso la frase “non ci sono soldi”?
Come dicevamo sopra, se avessimo una banca centrale i soldi ci sarebbero per definizione, con i limiti del vincolo dell’indebitamento estero. Non possiamo pensare di espandere la domanda interna e cominciare a importare dall’estero e indebitarci. I soldi li creiamo noi ma se cominciamo ad importare troppo poi non possiamo pagare utilizzando questi stessi soldi, abbiamo bisogno che ci prestino altre valute, che ci prestino dollari, valute di riserva. Possiamo anche fatturare in lire, certo, ma la gente si confonde, il seguace della MMT dice: noi possiamo fatturare in lire. Certo! Basta però che assicuri la convertibilità della lira. Che chi è pagato in lire possa rivolgersi a quello che una volta si chiamava ufficio italiano dei cambi, una branca della banca d’Italia, che possa cambiare i tuoi soldi in dollari. Ci può essere un po’ di flessibilità ma un po’ di dollari li devi avere.
La MMT considera troppo poco l’importanza delle banche commerciali nella creazione del denaro/credito?
Questo non saprei, ma protendo più per il no. Anzi siamo d’accordo con il fatto che la creazione di credito da parte delle banche vada tenuta sotto controllo se no si creano queste bolle che descrive Minsky che è il loro economista di riferimento e spiega le bolle edilizie o finanziarie che poi si trasformano in crisi conseguenti. Siamo d’accordo che queste attività, la creazione della moneta bancaria, il credito, vadano tenute sotto controllo.
La disoccupazione si combatte meglio con una moneta e uno stato sovrano?
Naturalmente.
Pdf dell’intervista:
intervista-cesaratto