Manganelli e l’uomo di paglia
Tempo di lettura: 6 minuti
Manganelli e l’uomo di paglia
Una triade di tre attori forma il dispositivo narrativo della finzione manganelliana intitolata Dall’inferno: l’io narrante, voce anonima che racconta il moderno viaggio per la salvezza dell’anima nello scontro e negli urti di una condizione dominata dall’inconscio, un cerretano e una «bambola dal sorriso seghettato».
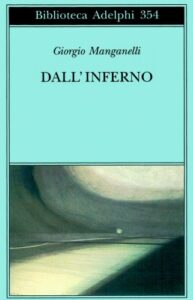 La dinamica tra di loro determina lo svolgersi degli accadimenti e l’andamento narrativo del testo. Un patto suggella la trasformazione della situazione iniziale: la condizione di accidia del soggetto, succube di «un’anima seviziante che vuol esser partorita», tramite un sogno cede il posto ad una dinamica conflittuale di pulsioni, in cui il cerretano compare come «un uomo finto, un manichino, un che di paglia, ritto appoggiato a cosa che non vedo», mentre l’anima tormentosa diventa una bambola, «una femminetta artificiata inclusa nelle viscere».
La dinamica tra di loro determina lo svolgersi degli accadimenti e l’andamento narrativo del testo. Un patto suggella la trasformazione della situazione iniziale: la condizione di accidia del soggetto, succube di «un’anima seviziante che vuol esser partorita», tramite un sogno cede il posto ad una dinamica conflittuale di pulsioni, in cui il cerretano compare come «un uomo finto, un manichino, un che di paglia, ritto appoggiato a cosa che non vedo», mentre l’anima tormentosa diventa una bambola, «una femminetta artificiata inclusa nelle viscere».
‘Cerretano’ è parola presente nelle liste lessicali di Daniello Bartoli pubblicate nel 1982.[1] Figura nel campo lessicale del buffone, è un ciarlatano ma anche un ciurmatore, che ha a che fare con la gentaglia e il canagliume, come si addice a chi deve tener a bada le manifestazioni smodate e triviali dell’inconscio.
Quanto alla bambola interiore, è «piccola e non bella, di stoffa, mi pare, ma dura e compatta, è una femmina, e sebbene sia immobile, indovino che questa bambola ha una sua capacità di muoversi, forse grazie a interiori meccanismi, molle e ingranaggi»; il cerretano gliel’ha introdotta nel corpo del «me stesso di paglia».[2]
La raffigurazione della tematica richiama aspetti dei drammi espressionisti, specie di Oskar Kokoschka e del suo Sphinx und Strohman (Sfinge e Uomo di paglia) del 1907, ripreso in seguito in Hiob (Giobbe) nel 1917.
Sfinge e Uomo di paglia è una commedia per automi, che mette in scena l’incapacità dell’uomo di reagire di fronte alla fascinazione femminile e punta sul problema assillante degli equilibri psichici, avvalendosi del topos della vampirizzazione. Pare che Kokoschka si sia ispirato a Olympia, la bambola meccanica dei racconti di E.T.A. Hoffmann, meglio nota attraverso l’operetta di Offenbach.
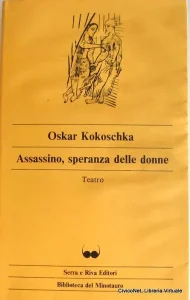 Che Manganelli abbia conosciuto questo dramma-commedia è ipotesi più che plausibile.[3] Una traduzione italiana fa parte del bel volume sul teatro di Kokoschka, uscito nel 1981 e splendidamente presentato con Note critico-bibliografiche ai testi da Lia Secci.[4]
Che Manganelli abbia conosciuto questo dramma-commedia è ipotesi più che plausibile.[3] Una traduzione italiana fa parte del bel volume sul teatro di Kokoschka, uscito nel 1981 e splendidamente presentato con Note critico-bibliografiche ai testi da Lia Secci.[4]
Il dramma è stato allestito una sola volta nel 1909 al cabaret letterario Fledermaus di Vienna, poi è stato ripreso nel 1917 da Marcel Janco alla galleria DADA di Zurigo nella nuova versione di Kokoschka e due mesi dopo rappresentato all’Albert-Theater di Dresda insieme a Der brennende Dornbusche (Il roveto ardente,1911) e al più famoso Mörder Hoffnung der Frauen (Assassino speranza delle donne, 1907). Pure quest’ultimo dramma ruota intorno al rapporto conflittuale tra uomo e donna, mettendo in scena due attori camuffati da manichini, non meglio individuati se non come «Uomo» e «Donna».
Ma, spiega Manganelli in Nuovo commento, la futurità di un testo non consiste soltanto nel suo passato; alla prefigurazione, all’eventuale ascendenza di un autore si aggiunge la retroazione esercitata dal lettore, che garantisce la posterità del testo, sviluppando virtualità in esso contenute o trascurate.
Non diceva Borges che ogni scrittore crea i suoi precursori modificando il nostro sguardo sul passato e ogni lettore individua i precursori di un’opera ricreando intorno ad essa uno spazio di affinità e di richiami?[5] E le affinità e i rimandi dal testo di Kokoschka a quello manganelliano e viceversa non mancano.
Quattro i personaggi di Sfinge e Uomo di paglia di cui uno solo è un «uomo vivo mortale» che non a caso incarna la morte. Gli altri tre sono camuffati da burattini che sembrano manovrati dall’interno : il Signor Firdusi (nome che ripete una battuta del personaggio e in tedesco suona Führ du Sie, portala tu) ridotto ad un testone di paglia girevole, cui sono appiccicate braccia e gambe, il Signor Caucciù «uomo-serpente, colto», che si presenta come un medico ma non praticante, «solo un modesto sacerdote della scienza», e Anima Femminile chiamata «Anima» nella presentazione dell’autore, l’unica a non portare una maschera intera del corpo.
Per un impedimento che gli impedisce di rigirare la testa, il Signor Firdusi non vedrà mai Anima. L’atto unico si caratterizza per gli effetti scenici, per l’apparente nonsense che ricorda il teatro dell’assurdo, per le immagini oniriche e surreali, e una dimensione parodica che si manifesta fin dall’inizio nella lunga battuta disincantata del Signor Firdusi sul rapporto matrimoniale tra coniugi.
A prevalere tuttavia è il grottesco che, appunto, favorisce il gioco dei rimandi come per esempio nella finzione manganelliana la successione degli orecchi che dialogano con il narratore e fanno pensare alla serie dei dieci Signori «vestiti di nero, con cappelli a cilindro, invece delle facce, buchi nei quali appare di tanto in tanto una testa, che dice in fretta una delle seguenti frasi a cui il signore successivo risponde, in modo che il discorso percorre tutta la fila» come precisato nella didascalia di Kokoschka.[6]
Oppure la figurina di gomma che il Signor Firdusi s’infila al dito e presenta come suo figlio, al quale occorre provvedere una madre che non ha avuto, e la bambola nuda che il cerretano stringe nella mano sinistra.[7] Oppure, l’informazione del narratore manganelliano, quando verso la fine dice: «ritrovo la mia dimensione, sono il fantasma che imita l’uomo», che ha letteralmente il riscontro nella figura di Morte.
Ma sono riscontri puntuali, quel che importa è l’ispirazione generale che riprende il topos della vampirizzazione e lo vivifica nel rapporto di Eros et Thanatos e nel conflitto tra i sessi con la vittoria femminile.
È da rilevare la curiosa coincidenza della scelta di ‘Anima’ come denominazione della particolare figura femminile del dramma e il nome di Alma Mahler con la quale Kokoschka vivrà una passione tumultuosa dal 1912 al 1914. Dopo la fine del grande amore e la rottura che ne consegue, nel 1918 Kokoschka si era fatto fare da una sarta marionettista una bambola di pezza che riproduceva le fattezze di Alma Mahler in grandezza naturale.
Forse la storia insieme alla figura hoffmanniana di Olympia ha ispirato la bambola gonfiabile e il racconto di Tommaso Landolfi, La moglie di Gogol (ma non c’è stata una moglie di Gogol). Olympia è una soprano e Alma Malher è stata una compositrice di Lieder, che su richiesta del marito Gustav ha dovuto rinunciare alle sue aspirazioni artistiche. Pare anzi che Gustav Mahler si sia appropriato alcuni suoi Lieder. Ed era noto l’appetito sessuale di Alma. Nel dramma di Kokoschka il conflitto tra uomo e donna si svolge nel registro della spiritualità maschile sopraffatta dalla sessualità femminile.
Alma, poet. ‘anima’, richiama inoltre l’Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas / alma Venus…di Lucrezio che riunisce le due nozioni di fecondazione, creazione e di piacere.
Quanto a Gustav Mahler, Manganelli, ascoltatore maniacale, ricorda che «una sera pensosa, ammorbidita da quella nobilissima battona di Gustav Mahler» sfogliava un’enciclopedia alla ricerca di un protosiberiano perduto, e «Mentre Mahler continuava ad ancheggiare con gli occhi pieni di lacrime, io pensavo al protosiberiano». Ricerca vana, e alla fine «Mahler singhiozza».[8] La caratterizzazione nobilissima battona che continua ad ancheggiare si addice pure alla moglie Alma.
Note:
[1] La selva delle parole, edizione a cura di Bice Mortara Garavelli, Premessa di Maria Corti, Università di Parma, Regione Emilia-Romagna, Parma 1982, p.180.
[2] Dall’inferno (Rizzoli, 1985), Milano, Adelphi, 1998, p.20.
[3] Da non confondere con il film di Pietro Germi L’uomo di paglia del 1958.
[4] Oskar Kokoschka, Assassino, speranza delle donne Teatro, Introduzione e traduzione di Lia Secci, Serra e Riva Editori, 1981. Una traduzione francese figura nel numero 12 del 2017 dei cahiers de la Maison Antoine Vittez, intitolato Le drame en révolution / Écritures théâtrales allemandes 1907-1937 e dedicato a Philippe Ivernel, grande specialista del teatro espressionista tedesco.
[5] Jorge Luis Borges, «Les précurseurs de Kafka» in Enquêtes, Paris, Folio/Essais, 2012, pp. 144-147.
[6] O.K., Assassino, speranza delle donne cit., pp. 25-26.
[7] Op.cit. p.20.
[8] G. Manganelli, Il rumore sottile della prosa, Milano, Adelphi, 1994, pp.169-170. Ascoltatore maniacale, così è definito da Paolo Terni in Giorgio Manganelli, ascoltatore maniacale, Palermo, Sellerio, 2001.
Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/
Per leggere gli articoli di Giuditta Isotti Rosowsky su Periscopio clicca sul nome dell’autrice






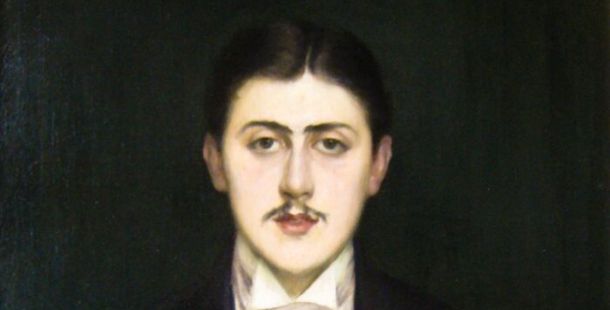
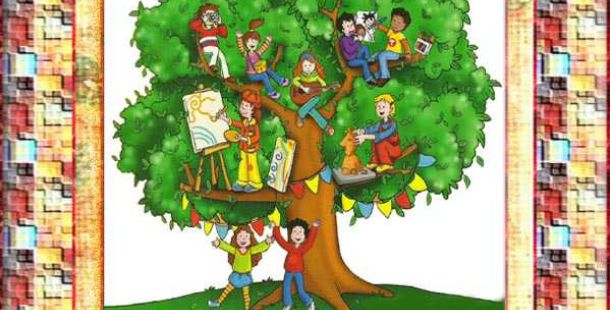
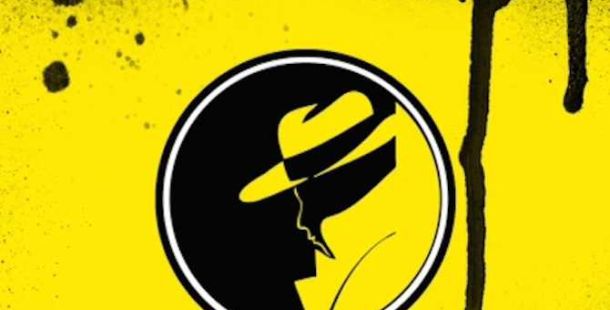




Lascia un commento