Un romanzo da leggere: «Alma» di Federica Manzon
Tempo di lettura: 6 minuti
Un romanzo da leggere: «Alma» di Federica Manzon
Una giornalista di nome Alma, protagonista del romanzo di cui vogliamo parlare (Feltrinelli 2024), torna a Trieste dov’è nata e vissuta per una ventina d’anni per prendere possesso di un’eredità lasciatale dal padre. È aprile, ci resta tre giorni – un triduo pasquale indicano i titoli di tre capitoli -, tre giorni incorniciati all’inizio e alla fine da una breve sosta su un’isoletta istriana che fu il luogo di residenza del Maresciallo Tito.
La configurazione circolare dell’intreccio tuttavia non chiude. Certo, nel romanzo una storia sentimentale termina generando un sentimento di pienezza per un incontro finalmente riuscito, ma lo scioglimento non cancella l’impressione di provvisorietà che impregna la narrazione anche alla fine, come se tutto potesse riprendere e continuare. «Quanti inizi possono avere le storie? Dipende da chi le racconta o da come sono andate a finire» osserva Alma, e nel libro, più che una conclusione l’epilogo sembra piuttosto una sosta, un’interruzione.
Ogni giorno è un capitolo con un blocco di ricordi e di fatti che si affollano sotto una luce particolare. La città, inseparabile dai suoi dintorni, disegna uno spazio mentale e il racconto scivola dalla terza persona alla prima, dalla realtà fattuale esterna a quella interiore della memoria, dal presente al passato, ai diversi momenti del passato, in uno scambio senza soluzione di continuità. La causalità tipica del romanzo classico è assente. Il movimento narrativo si allunga, si distende e allarga in un susseguirsi di episodi e accadimenti come in un caleidoscopio. La sua durata cancella i limiti del corto segmento temporale che racchiude il romanzo e porta il lettore in paesi limitrofi, devastati dalla guerra.
Intorno alla protagonista gravitano i familiari e Vili, un ragazzo d’une decina d’anni di origine serba, che il padre di Alma ha portato un giorno a vivere definitivamente con loro sottraendolo ai rischi incorsi dagli intellettuali comunisti dissidenti come i genitori di Vili suoi amici, caduti in disgrazia presso il presidente dei “Comunisti di Serbia“. Le vicende individuali si mescolano e si formano nella storia con la S maiuscola.
L’etichetta incollata a Trieste come città di confine, città a mosaico, di culture, di religioni e di tradizioni diverse per quanto giusta è diventata uno stereotipo inerte. Sotto la penna di Federica Manzon lo stereotipo si anima, prende corpo e vivacità in una sottile corrispondenza tra la gente e i suoi luoghi.

Le asperità del Carso, gli scogli di Barcola, la piazza grande che si apre sul mare e invita a lanciarsi senza pezze d’appoggio (non sapevo che fosse la piazza con un lato marino più grande d’Europa), il Viale dei Platani, il Viale per antonomasia dove abitavano i nonni di Alma e dove lei da piccola trascorreva l’estate…. Il nonno, buon borghese che continua a vivere nell’aura del mitico passato austro-ungarico, rappresenta un punto fermo nella vita familiare disordinata della bambina, scandita dalla presenza aleatoria e imprevista del padre. L’asperità del paesaggio si ritrova in una certa angolosità e irrequietezza dei personaggi. La geografia ha sempre il sopravvento, decide di tutto, pensa Alma che vive «di qua» in un riferimento continuo al «di là» oltre il confine, dove corrono i pensieri, i sogni, gli ideali e i passi del padre. Ricerca e fuga si sovrappongono e si confondono e i due motivi governano tutto il romanzo.

Una condizione di alterità caratterizza i personaggi, ma è un estraneità per così dire familiare e connaturata. Gli anni della fanciullezza di Alma sono anche quelli dell’antipsichiatria, a Trieste Franco Basaglia aveva aperto le porte e i cancelli dell’ospedale psichiatrico, sostituendo a quel luogo chiuso le microaree, perché i cosiddetti matti sono solo un po’ diversi dagli altri, basta saperli trattare. In quell’area, la Città dei Matti della finzione, lavora la mamma di Alma. Viene in mente a proposito una curiosa espressione del dialetto triestino, che esisteva ben prima di Basaglia, secondo la quale «el mato» indica un tizio qualsiasi («el mato me ga dito», il matto mi ha detto), come a dire che l’estraneità, per lo meno nella parlata triestina, sembra una condizione generale.
Terzo elemento che caratterizza nel romanzo la città e quasi tutti i suoi personaggi è una vitalità colorata e luminosa che ovviamente contrasta con lo squallido grigiore di Belgrado durante la guerra. Tra il Carso e il mare si raggrumano i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza. «Il mare della città, come un pub irlandese, riunisce tutti: mescola ricchi e poveri, quelli con il letto rifatto dalla cameriera, e quelli con il padre che lavora in Germania, quelli con la madre da tenere d’occhio perché non combini guai, chi ha la merenda e chi no». Alma ci andava a tuffarsi con una banda di ragazzini eterogenei, come in un’istantanea il ricordo si fissa: «spicchiamo il volo nel cielo intensamente blu per poi cadere avvolti in schizzi schiumosi. Apparteniamo tutti a questa scogliera. Qui siamo stati tutti, almeno una volta, degli dèi».
Nella liturgia religiosa del triduo pasquale il sabato santo rappresenta una pausa, un momento di attesa fiduciosa. Non così nel romanzo; al contrario, nel lungo capitolo centrale intitolato al sabato santo domina la centralità del negativo. Nell’ex-Jugoslavia le guerre hanno riacceso antagonismi ancestrali, riportato distruzione e odio, massacri e sofferenze. Crollano gli ideali di fratellanza e di unità, del voler vivere insieme per dirla con Jaurès, che la recente Repubblica Socialista Federale sembrava voler e poter attuare. Una mattina del settembre 1991, l’anno in cui la Slovenia si dissocia dallo Stato jugoslavo, il padre di Alma torna a casa sconvolto. «Arriva che l’alba scollina livida dal Carso». È riuscito a scappare, agitato racconta della situazione di là con frasi inceppate e confuse. Vukovar, la città croata che mescola tutti, «Vukovar, città dei matrimoni misti» è sotto assedio. Senza più speranza. Del resto, pochi mesi prima c’erano stati i fatti di Polog nei pressi di Mostar con il blocco dell’armata popolare jugoslava. «Sulla strada di Polog è finito il comunismo» aveva concluso laconico.
Anche nella storia particolare di Alma e Vili il capitolo rappresenta un’acme, è il momento del massimo equivoco tra i due giovani, dell’incomprensione che da sempre ha insidiato i loro rapporti. Di nuovo la narrazione intesse salvezza e negativo.
Cinque fotografie in bianco e nero sottolineano punti precisi del racconto. Non saprei dire se sono necessarie al testo come un suo complemento. Di sicuro creano un legame che va oltre la semplice illustrazione. Vili è un fotografo per passione e vocazione. Tramite il padre di Alma aveva ricevuto in regalo dal suo una macchina fotografica che portava sempre con sé. Era un ragazzo chiuso, come murato in se stesso, e ostinato, non lasciava mai trapelare nulla che avesse a che fare con il suo passato, con le sue sofferenze. Le foto parlano per lui, ma possono essere mal interpretate, immagine e vettore della realtà sono o sembrano comunque più oggettive dei discorsi. Sono un documento che inserito nel romanzo garantisce la verità della finzione mentre avvalora l’enigmaticità e la qualità letteraria della scrittura. Insomma un libro che avvince e fa conoscere una città, una storia e richiama tragicamente un passato prossimo che sembra il presagio di una guerra attuale.
Una volta di sfuggita la narratrice ricorda il presente della scrittura menzionando l’Ucraina. Affiora allora un’associazione d’idee con un episodio evocato, avvenuto sette anni prima della secessione delle repubbliche federate. A una festa nazionale jugoslava i gruppi etnici ballavano separati, senza mescolarsi; per il lettore pare quasi un annuncio non percepito del futuro imminente. «Il tempo – noterà Alma – è un concatenamento di blocchi separati e stagni, escono da uno e entrano in un altro dove non c’è traccia di quello che è stato prima».
Per leggere gli altri articoli di Giuditta Isotti Rosowsky clicca sul nome dell’autrice





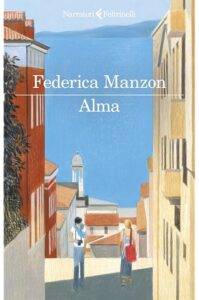









Lascia un commento