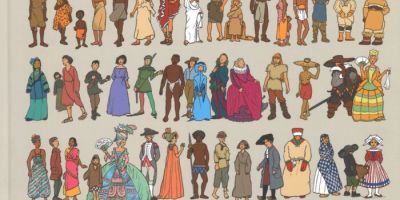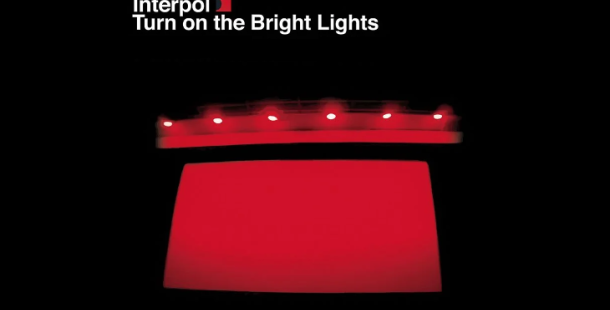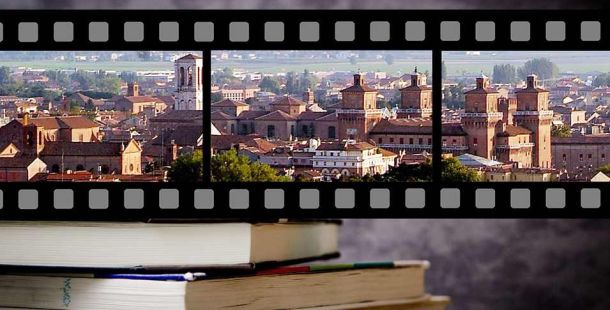Un futuro da sognare non da dominare
Tempo di lettura: 4 minuti
Guardiamo al futuro con ansia, desiderio, aspettative, speranze, disillusioni, inquietudine, preoccupazione, a volte anche gioia, perché costruire visioni dà alle nostre azioni una qualche direzione. Il futuro, così come lo cerchiamo nelle nostre raffigurazioni mentali, nelle proiezioni o nella letteratura d’anticipazione è un’astrazione, l’astrazione di un desiderio o di una paura che abbiamo oggi e che diventa una presenza impalpabile. Nel nostro sistema cognitivo siamo costretti a immaginare il futuro ed è ciò che ha reso grandi i nostri progenitori: preconizzare un tempo a venire è ciò che dà forma al presente.
Abbiamo bisogno di profeti e profezie; i media chiedono previsioni di esperti e siamo intransigenti quando falliscono, anche se sappiamo che la complessità rende tutte le previsioni inevitabilmente difficili, a volte impossibili. Abbiamo bisogno che il futuro possa essere predetto per scienza o magia, da una maga affabulante o dagli algoritmi sofisticati della supertecnologia informatica.
Gli scrittori del passato come Verne, Abbott, Wells, si avventuravano nel futuro con le loro narrazioni affascinanti e straordinarie, ma si tratta di un divenire in cui persone e personaggi rimangono immutabili, mentre tutto intorno a loro cambia, presupponendo che le percezioni culturali e i valori sociali rimangano costanti, mentre ciò che cambia è la tecnologia, che contribuisce a cambiare cultura e valori, accompagnata anche dalla casualità. Oggi il futuro non è più un tempo ‘ulteriore’ ma è diventato un tempo ‘che sta dopo’ diventando una procedura, una mera amministrazione del presente applicata nel futuro, sottoposta a controlli che convalidino la correttezza dell’intero processo. Studi sul futuro e metodologie di previsione da parte del mondo accademico sono state sviluppate per informare i politici sugli scenari ipotizzati, rassicurare o allertare investitori e imprenditori, tracciare linee previsionali in merito a ciò che deve ancora accadere a breve, medio e lungo periodo, sulle tematiche più diverse.
Nelle opere letterarie delle varie epoche passate, in cui dominano l’aspetto onirico, l’attesa, la scoperta, la conoscenza e la straordinarietà di un futuro, ciò che colpisce profondamente sono i dettagli, spesso incredibilmente esatti, che accompagnano le profezie visionarie che a volte richiamano a un ritorno darwiniano, altre volte sono di rottura totale col presente e con il conosciuto. Romanzi che contengono verità e realtà accostabili alla nostra epoca e rendono il futuro di allora, ormai il nostro passato. Già nel 1818 Mary Shelley nel suo capolavoro ‘Frankenstein’ anticipa il trapianto di organi, proprio quando la scienza dell’epoca stava appena iniziando a esplorare le nuove possibilità della rianimazione di tessuti morti attraverso l’elettricità, e qualche decennio più tardi, Michel Verne, figlio di Jules, descriveva nel suo romanzo ‘Un espresso per il futuro’ (1888), un sistema di trasporto simile ai treni ad alta velocità, in grado di viaggiare a 1000 km/h: lo stesso Hyperloop in fase di realizzazione che collegherà, entro il 2025, San Francisco a Los Angeles. Nello stesso anno, Edward Bellamy introduceva il concetto di carta di credito nel suo romanzo utopico ‘Guardando indietro: 2000-1887’, mezzo di pagamento che acquista diffusione solo a partire dal 1950. Nel romanzo di Herbert George Wells del 1899, ‘Il risveglio del dormiente’, esistono porte automatiche scorrevoli che funzionano tramite sensori, scoperta che sarà realizzata nel 1960. Lo scrittore americano Mark Twain, in ‘From ‘The London Times’ in 1904’, un breve racconto del tempo, immagina un dispositivo capace di collegarsi alla rete telefonica per creare un sistema mondiale di condivisione di informazioni, chiamato telectroscopio, attraverso il quale le persone rendono pubbliche e commentano le proprie azioni quotidiane, pur essendo molto lontane. I social di oggi. Scrive: “La connessione fu fatta con la stazione telefonica internazionale e giorno per giorno parlò con la sua gente, e si rese conto che per grazia di questo meraviglioso strumento, era quasi libero come gli uccelli del cielo, sebbene prigioniero sotto serrature e sbarre”. E sempre a proposito di tecnologia, Hugo Gernsback descrive senza esitazione l’impiego dell’energia solare, la tv, i registratori a nastro, i film sonori e i viaggi nello spazio, nel suo romanzo ‘Ralph R4 C 41+’ del 1911.
Intuizioni, visioni, immagini, grande slancio creativo fantastico che accompagna anche l’immancabile ‘Farenheit 451’ di Bradbury (1953), popolato di nuovi congegni e scoperte come la tv a schermo piatto e le ‘conchiglie’, dispositivi portabili non molto diversi dagli attuali auricolari. Ambientato nel 2540, il romanzo di Aldous Huxley ‘Il mondo nuovo’ (1931) anticipa la nascita degli antidepressivi o ‘pillole dell’umore’, che i personaggi chiamano ‘Soma’ e che gli scienziati non iniziarono a studiare prima degli anni Cinquanta. Il ritratto di una società capitalistica dipendente dalle droghe, che dà più valore alla libertà sessuale che alla monogamia ed è strutturata in caste. Un cult del romanzo anticipatorio è naturalmente ‘2001 Odissea nello spazio’ di Arthur C. Clarcke (1968), dove si scrive di vita intelligente, guerra nucleare, evoluzione e pericoli dell’intelligenza artificiale, super computer. Ma la previsione più accurata riguarda i fogli elettronici o ‘newspad’, che assomigliano molto all’iPad. In tempi più recenti, ‘Neuromante’ di William Gibson (1984) anticipa quello che negli anni Novanta diventerà popolare: la diffusione del World Wide Web e la nascita degli hackers. La maggioranza della gente stava ancora esplorando il funzionamento del computer, mentre i personaggi di Gibson lo utilizzavano agevolmente e altrerttanto agevolmente rubavano i dati agli altri utenti. ‘Tutti a Zanzibar’ è il romanzo di John Brunner del 1968, uno dei libri con il maggior numero di spoiler: si parla di tv on demand (che acquisterà diffusione nel 2009), tv satellitare, stampante laser, auto elettriche, legalizzazione della marijuana in molte nazioni ed Unione Europea. Il romanzo è ambientato negli Stati Uniti, governati dal Presidente Oboni.
Sogni, deliri, profonde intuizioni o cos’altro? Scriveva Karl Popper: “Il futuro è molto aperto, dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero, dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte”.