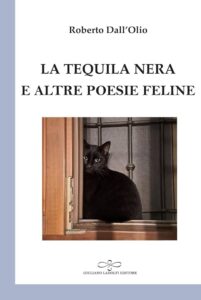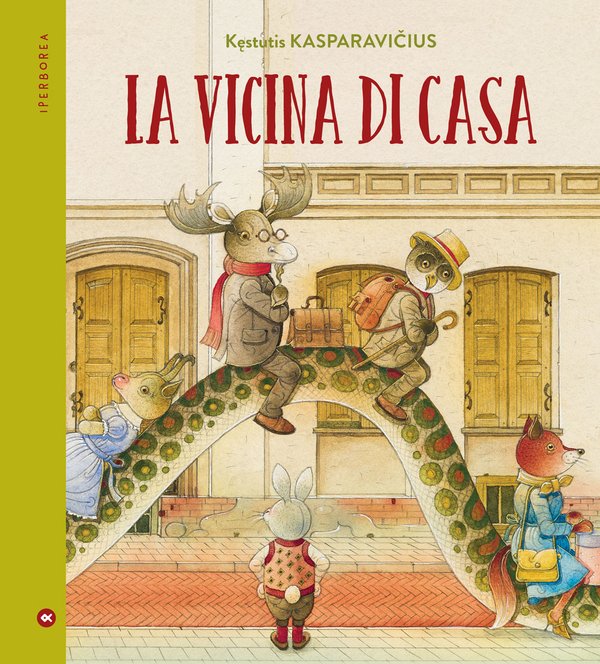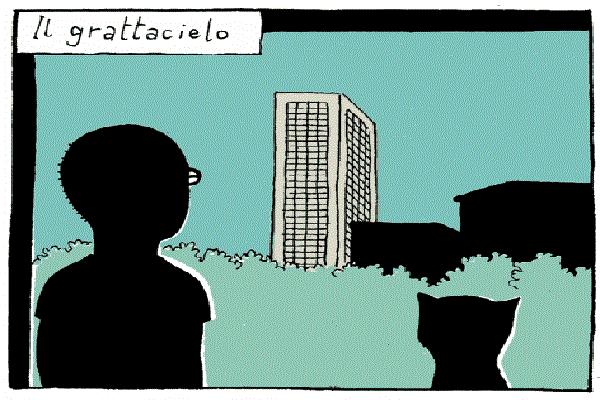Presto di mattina. La luce chiama
La luce chiama
Smarrito vagare/ a stimme di luce, buio fiorire
(D. Dolci)
La luce è come ferita, voce silente e abbagliante, che chiama gli smarriti, i dimenticati all’incontro, stigmi lucenti vibrano e il buio fiorisce di forme e colori. Strada facendo la luce si allarga, si fa spazio d’incontro: è luce di sogno quella che sale dal Natale che va all’incontro di quella promessa che scende dalla Pasqua nel giorno della Presentazione del Signore al tempio, il 2 febbraio prossimo. È detta nella liturgia orientale festa dell’Hypapante, incontro appunto, e in quella occidentale Candelora.
La luce della stella accende così i ceri di coloro che nel cammino quaresimale, ormai incombente, saranno protesi alla gioia pasquale sulle orme di Cristo, luce per le genti. Gli sguardi scrutano lontano oltre quest’ora ancora di oscurità rivolti alla luce del cero pasquale preludio della tomba vuota riempita, il mattino, di luce. È lo sguardo della fede che ci soccorre per vedere la luce ancora latente o incipiente in ogni creatura ed il mondo come creatura viva di creature; così gli sguardi divenuti luminosi alla luce sospirano come nel Cantico dei Cantici all’amato: «Oh prendimi con te! Corriamo!» (1,4).
il minuscolo corpo della terra
nel sogno di rincorrere la luce indaga
vedere ininterrotto
…
la mano accarezzando ascolta e dice
i tuoi occhi sono miniere di luce
tutti i miei fiori si aprono
(Danilo Dolci, Creatura di Creature. Poesie 1948-1978, Armando editore, Roma 1986, 227; 162; 218).
La luce della nominazione
“Luce chiama” è il titolo che introduce una breve raccolta di poesie nel volume Creatura di Creature con l’introduzione è di Mario Luzi. Egli scorge nella poetica di Danilo Dolci un intreccio con il suo progetto sociologico e pedagogico inteso come creazione di vita, esercizio maieutico del portare alla luce, far nascere, crescere, espandere al di là di se stessi per gli altri il processo della conoscenza creatrice.
Per Dolci – ricorda Luzi – la creazione è pensata come generazione continua, «un inesauribile progetto aperto alla nostra intraprendenza e necessità vitale di appropriazione e di conoscenza in progressione esistenziale e sociale: dall’ombra alla chiarezza, dall’organico e inarticolato alla luce della nominazione». (ivi, III).
Secondo Mario Luzi “la luce della nominazione” significa portare alla luce la parola, rivelarne la sua natura epifanica, ciò che vi è nascosto in essa. Nominare qualcosa equivale a farla uscire fuori, liberarla dall’insignificanza, dall’oscurità che l’imprigiona. Così il poeta non inventa la realtà ma la nomina; è questa una forma di conoscenza che sta alla base della stessa pedagogia maieutica di Danilo Dolci.
La conoscenza come luce della nominazione non è solo un atto umano, ma per Luzi, come anche per Dolci, è un atto religioso, sacro, un avere parte alla costruzione della “creatura di creature”, di una comunità che nelle interrelazioni multilaterali diventa un organismo sociale, vivente e armonico, luogo in cui la dignità e la salvaguardia della vita sta al di sopra di ogni altro valore. L’umanità ha così una struttura corale nella prospettiva sociologica di Dolci: per questo “Creatura di creature” è la comunità viva che porta alla luce e fa partorire mediante l’esercizio dell’ascolto delle persone e dell’interrogazione al fine di giungere al senso, al vero che già si possiede dentro di sé o dentro gli avvenimenti: è l’arte della maieutica generativa di coscienza e chiarore di consapevolezza.
L’educatore ascolta
essenziale,
«la sua parola è medicamento»,
impara a fare crescere domande,
sollecita consigli, studia come
sviluppare dal fondo
nuove persone, gruppi responsabili-
attento
a illimpidire esattamente
impara a fare crescere le ali.
…
Scavare la luce nel volto
di un’erba
del mare
di un bambino,
partecipare intento a una ricerca,
battersi aperto contro i parassiti
contro i fascisti,
costruire pazientemente alternative democratiche,
gli sono fasi di un processo essenziale:
cerca esprimere tutto in ogni scelta.
(D. Dolci, Poema umano, Einaudi, Torino 1974, 82; 219-220).
La luce sua chiama ancora
È una luce che chiama ancora quella di Danilo Dolci (Sesana, 28 giugno 1924 – Trappeto, 30 dicembre 1997) e proprio a Candelora, processione di tremule luci. Sociologo, poeta, educatore – insegnava vivendo e interrogando – fu attivista in Italia della nonviolenza insieme ad Aldo Capitini e indicò la centralità del lavoro come fattore di riscatto sociale e premessa di libertà e democrazia.
Nei suoi testi affiora la trama e la storia del suo impegno civile radicale per i diritti, la sua lotta alla fame, alla mafia. Il periodo vissuto a Nomadelfia, là dove fraternità è legge, fondata da don Zeno Saltini (1900-1981), – nata ufficialmente nel 1948 nell’ex campo di concentramento di Fossoli e poi spostatasi a Grosseto – ha rappresentato per Dolci un modello di vita vissuta, un vangelo “sine glossa”, francescano, in gruppi di famiglie dove tutto era in comune, con al centro i piccoli, una pratica di democrazia diretta, tramite il metodo assembleare: quello fu un punto di partenza.
Ma il suo sogno era più grande, quell’esperienza iniziale la voleva allargata a tutti. Così nel 1952 Dolci decise di trasferirsi a Trappeto, uno dei comuni più poveri della Sicilia occidentale.
Una scelta politica: vivere con gli ultimi per riscattare insieme i loro diritti. Non ricercava la protesta ma l’attenzione, inventandosi pratiche come lo “Sciopero alla Rovescia” (1956) in cui i braccianti disoccupati si misero a riparare una strada comunale abbandonata: “Se lo Stato non ci dà lavoro, noi lavoriamo gratuitamente per il bene comune“; per questo fu arrestato ma il caso divenne internazionale.
Valga ricordare anche il “Il Digiuno sul Fiume”, intrapreso per sollecitare la costruzione della diga sullo Jato e sottrare il controllo dell’acqua alla mafia: uno dei tanti digiuni pubblici in cui seppe coinvolgere l’intera comunità. Fondò Radio Sicilia Libera (1970), infrangendo il monopolio Rai, per lanciare un appello disperato a più di due anni dal terremoto del Belice. La gente viveva ancora in baracche e il territorio era devastato: qui «si marcisce di chiacchiere e di ingiustizie, la Sicilia muore». Quell’appello durò solo 26 ore poi la polizia sequestrò tutto, ma la notizia di quella disperazione si diffuse in tutta Europa.
Poema umano
Poema umano è il suo manifesto poetico e politico insieme, un grido e un patto di umanità in cui la creatività resa consapevole nelle persone diventa a poco a poco forza di cambiamento, per far fronte alla volontà di dominio, per smascherare le strutture di potere che vogliono imprigionare la vita della gente. Pubblicato nel 1974 il libro riflette così la sua esperienza siciliana di liberazione della povera gente contro lo sfruttamento, la fame, lo spreco, la sopraffazione o l’indifferenza della politica. È un “noi” che parla nel poeta, un noi che cerca riscatto per i confinati nelle zone d’ombra, che riaccende la luce della coscienza per ridestare il sogno:
C’è pure chi educa, senza nascondere
l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d’essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato
(ivi, 105)
Poema umano è così un sognare per e con gli altri; sognarli come ora non sono ancora. È questa la forma più alta di impegno civile e letterario, un sognare insieme che scaturisce dall’agire insieme, spalla a spalla, che non riflette l’amore per le parole ma l’amore per gli uomini (Kristine Wolter). E scrive Cesare Zavattini: «La poesia è in atto già nei fatti e nella vita di Danilo. È il solo della nostra generazione che ha saputo ridurre al minimo la terra di nessuno esistente tra la vita e la letteratura».
Tirar fuori i sogni significa portare alla luce le differenze di ciascuno e solo unendo le differenze e dando loro la parola potrà venire alla luce una umanità viva.
Testimonianza di questo la troviamo proprio nella premessa di Dolci al suo testo, dove ricorda che fin da ragazzo scriveva versi per concentrarsi, per fissare immagini e voci essenziali e così salvarsi dalle vane parole della retorica. In un momento di saggezza, ricorda ancora, a venticinque anni, bruciò millecinquecento versi. Tenne solo la raccolta Ricercari, come una maieutica in atto, testi a due voci, dialogici: «La maieutica è buona se in un gruppo ognuno è levatrice di ciascuno» (ivi, 241).
A “ricercar per verba” si costruisce l’uomo
Perché si rompe con la parola il silenzio dell’omertà e della povertà per far respirare la terra e in essa la gente: dal grido al canto. Il ricercare indica che la parola poetica è un respiro d’anima. Non è un possesso, bensì un’esplorazione dolorosa verso la liberazione, uno scavo e una testimonianza mediante la parola di sé e d’altri. Essa non abbellisce ma ferisce, è stigma di luce, che chiama all’azione non violenta dentro i conflitti.
Quando Ti accarezzavo e gli occhi miei
bevevano la luce del Tuo volto
Ti celavi più piccola e vicina.
A Te m’aduso come gli occhi a luce:
e pure la mia mano Ti ricerca
lievi carezze arrischia
(ivi, 8).
Nella raccolta Ricercari i testi sono come esercizi di ascolto, frammenti di un dialogo più grande, uno scambio attraverso le parole: un messaggio all’umanità. Si ricerca il senso, la realtà mischiando parole d’altri come fossero note di uno spartito a più voci che si rincorrono. “Ricercar” è infatti forma musicale rinascimentale e del primo Barocco, un intreccio aperto, improvvisato e poi articolato come nell’arte della fuga in Bach in cui Doci vedeva una costruzione complessa e ordinata, simile alla sua idea di organizzazione sociale e politica nonviolenta.
Così scrive Danilo Dolci: «Ho tenuto solo le voci dei Ricercari, che – appuntate nel ’49- ’50 nella silenziosa pianura dello Scrivia -, pur ancora letterarie, pervenivano ad un nodo essenziale: la coscienza che nella vita ciascuno è – può, deve essere – ostia agli altri. Mangiare è un dramma: cosmico. Accetto di mangiare per poter farmi mangiare.
In Nomadelfia poi altre voci ho appuntato – non ancora la mia – attento alla necessità di muoversi dalla coscienza all’atto, a non lasciarmi ammaliare dall’esercizio letterario, non ridurmi a un rapporto intellettualistico con la vita. Venuto in Sicilia nel ’52, per molti anni ho sentito come tentazione l’abbandonarmi a scrivere poesia: troppo forte sentivo il rischio di esaurire in parole urgenze che dovevano essere espresse soprattutto in azioni, fatti, esperienze da approfondire…
Finché nel ’68-’69 ho avvertito netta la necessità di valorizzare la sottile possibilità della poesia per contribuire a rispondere all’interrogativo: di che qualità volevamo lo sviluppo per cui ci impegnavamo. Non temevo più la poesia, non ne arrossivo: non scrivevo più soprattutto per me, il rapporto era divenuto di amore sereno, occasione di illimpidimento funzionale, non chiusa concupiscenza… Molte di queste pagine nella loro prima stesura sono state occasione di colloquio e reciproco approfondimento con ragazzi, giovani e adulti tra i più diversi: occasione, certamente per me, di nuova scoperta. Partinico, settembre 1974», (ivi, VII-VIII).
Costruendo, l’uomo si costruisce.
La città nuova inizia ove la terra respira,
ove ognuno respira
poesia – antenna miccia cantiere –
avvertito la terra può schiantarsi
invetrando cancrene, (ivi, 178).
La luce spare, e tutto è scuro.
Ma a poco a poco nel buio si distinguono
dalla finestra aperta sulla valle
masse piu scure e altre meno scure,
il cielo si disegna, le montagne,
si frastagliano i rami degli alberi,
oscilla al vento un ramo sottile,
si possono distinguere le foglie
scure sul fondo più chiaro del mare
(ivi, 115).
Costruttore di sogni
Così lo definisce Antonio Fiscarelli nel suo recentissimo libro: Danilo Dolci. Lo Stato, il popolo e l’intellettuale, prefazione di Luigi Bonanate, Castelvecchi Lit Edizioni, Roma 2025, è un’opera fondamentale perché fa riferimento anche a tutta la produzione letteraria su Dolci, la sua vita vista come una rivoluzione aperta. Il testo è diviso in due parti: Esperienza e pensiero (1924-1960) e Pensiero ed esperienza (1960-1997) in cui si traccia l’itinerario per educarsi al mondo nuovo. «Costruttore di un tipo particolare di sogni. I suoi, infatti, sono «sogni di fiducia», cioè sogni che rivelano il suo «bisogno di fiducia nelle persone» (ivi, 31).
Si legge nella prefazione: «l’autore ricostruisce la genealogia dei concetti-chiave e delle metafore della sua “filosofia sociale”, abituandoci, con questo metodo, ai suoi capisaldi, progressivamente… Dolci aveva interesse per le relazioni internazionali, ma soprattutto è stato un esempio unico di mobilitazione contro la guerra. Obiettore di coscienza sotto il fascismo, nei decenni seguenti, agisce, nel territorio, per i bisogni immediati della popolazione, oltre il territorio, contro la corsa agli armamenti nucleari e le guerre che crescono nelle nostre democrazie, le “guerre dei diritti”» (ivi, 10).
Dialettica della reciprocità
Lontano da ogni dogmatismo ideologico e religioso ho pensato che quel vangelo sine glossa, senza scappatoie, a cui lo aveva orientato la religiosità della madre e poi aveva sperimentato nella comunità di Nomadelfia chiedeva di espandersi oltre ogni confessione religiosa e vissuto nell’umanità, un vangelo ancora nascosto e da cercare nell’esperienza umana universale della reciprocità, come un luce perduta nel donarsi che viene ritrovata quando la si riceve dalla vita in comune con gli altri.
Fiscarelli ne fa una riflessione a commento della poesia La luce chiama l’ostia: «A dispetto di ogni possibile declinazione misticheggiante, l’idea di farsi ostia gli uni per gli altri implica la reciprocità non solo come concetto intellettuale e principio-guida di un’etica della responsabilità, ma altresì come rapporto della vita al corpo, come rapporto alla vita del corpo. Ed il corpo, in questo scenario è più il corpo di un noi (non di un noi settario, da cameratismo, ma di un noi-tutti) che quello di un io, di un me, di un mio… Il dispositivo che ne è alla base è la dialettica della reciprocità che egli ricerca tanto nei rapporti sociali, quanto nei cicli della natura…
Tale atto di consumazione che riduce il soggetto razionale e morale in ostia rivela in ultima istanza un campo di significatività del corpo inteso come esperienza comunitaria… Nell’accezione antica del termine, communitas è fare unità, fissare legami, vincoli, accordi, stabilire rapporti di reciproca mutualità e protezione, istituire patti, regole, leggi, valori.
Essere umani, humanitas in strictu sensu, per Danilo, da un certo momento in poi, inizia a significare essenzialmente essere «concime gli uni per gli altri», trascrizione laica e umanizzata di ciò che rappresenta ‘l’ostia’ per i cristiani: il corpo di Cristo. Ogni corpo è un cristo e ogni cristo è corpus (oltre che humus), sacrificabile proprio come il corpo di Cristo, e per questo è «ostia per gli altri», (ivi, 54-55; 29).
Tutto sarà tra poco mare rosso
mare di carne tribolata, e docile.
La luce è rogo d’ostie.
Quando sciaborderà l’oceano bianco
contro i muri di pietra ben connessa,
dolce sarà lo scroscio dei ghiaccioli
a noi turbati
nella tepida attesa delle rondini.
La luce chiama l’ostia.
Quando al vento nuovo
langue l’ultima neve, abbrividisce
il sonno indifferente dei grandi alberi.
È luce l’ostia, che ritorna luce
(Poema umano, 11).
Cover: Foto di <a href=”https://pixabay.com/it/users/ralf1403-21380246/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=9595813″>Ralf Ruppert</a> da <a href=”https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=9595813″>Pixabay</a>
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.