Non tutte restano prigioniere: la responsabilità di scegliere
Non tutte restano prigioniere: la responsabilità di scegliere
Nella Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, vale la pena tentare un discorso che non si lasci catturare dalle semplificazioni che dominano lo spazio pubblico. Da anni assistiamo a una narrazione che individua nel patriarcato, nel maschilismo tossico, nei “narcisisti patologici” e nell’uomo che uccide la donna indifesa, l’unico schema possibile.
È un racconto rassicurante perché offre una spiegazione univoca: da una parte il carnefice, dall’altra la vittima. Ma questa narrazione è riduttiva, non regge alla prova della clinica e, soprattutto, non permette una vera prevenzione.
Dire che “la violenza è maschile” semplifica ciò che, invece, è profondamente complesso.
Quando parliamo di uomini incapaci di tollerare la separazione dall’Altro, non stiamo parlando di un’essenza maschile né di un destino culturale immutabile. Stiamo parlando di soggetti – singolari, mai intercambiabili – la cui struttura psichica rimanda al loro rapporto con l’Altro primario, con la mancanza, con il limite simbolico. Ma sottolineare questo non significa spostare l’intero peso della responsabilità sulla figura materna o su una donna reale: vorrebbe dire, ancora una volta, semplificare.
Il punto, infatti, non è individuare un colpevole unico – il maschile, il materno, l’educazione, la cultura – ma riconoscere che il fenomeno è strutturale, multilivello, e riguarda il modo in cui ciascun soggetto accede alla separazione, alla mancanza, al desiderio dell’Altro.
Per questo la narrazione dominante finisce per occultare la complessità:
– crea un maschile “da aggiustare”;
– produce un femminile “da proteggere”;
– e ignora completamente la singolarità del legame, dell’incastro, della scelta.
La realtà clinica e sociale, invece, ci mostra altro.
Anche i fenomeni di violenza agita da donne sono in aumento, così come i fenomeni di bullismo al femminile. Parliamo di ragazze che esercitano violenza su altre ragazze, o su altri soggetti, senza che ciò trovi posto nella narrazione che vorrebbe il femminile come luogo esclusivo della cura e il maschile come luogo esclusivo della distruttività. È un dato che conferma una verità fondamentale: la violenza non ha genere.
E anche il caso della pagina Facebook “Mia moglie”, dove un grande gruppo di uomini derideva le proprie compagne, lo dimostra ulteriormente: l’amministratrice della pagina era una donna. Non perché “le donne siano peggiori”, ma perché il godimento che spinge verso l’umiliazione dell’altro non appartiene a un sesso. È umano. È strutturale. È trasversale.
Allo stesso modo, il versante femminile delle vittime non può essere compreso attraverso la retorica dell’innocenza passiva.
La domanda clinicamente pertinente è: perché alcune donne restano incastrate in relazioni invischianti, mentre altre no?
Ma da questa prima domanda ne derivano inevitabilmente molte altre, altrettanto cruciali:
– Che cosa cercano, esattamente, in quei legami così stretti da diventare soffocanti?
– Quale tipo di mancanza tenta di colmare quella relazione che appare, dall’esterno, distruttiva?
– Quale immagine di amore portano con sé e da dove viene?
– Che cosa fa sì che riconoscano come “amore” qualcosa che invece le inghiotte?
– Che cosa impedisce loro di separarsi quando il legame diventa evidentemente a rischio?
– Quale fantasma incontra il fantasma dell’altro, producendo l’incastro?
Fragilità antiche – difficoltà nel tollerare la solitudine, confini interni labili, un bisogno di conferma che precede l’incontro amoroso – possono rendere più facile confondere la fusione con l’amore, più difficile leggere i segnali dell’invasione, più complicato dire “no” senza sentirsi crollare.
Quando queste fragilità incontrano uomini che, a loro volta, non tollerano la separazione, nasce l’incastro: due soggetti che si agganciano nello stesso punto cieco, ciascuno impedito – per ragioni diverse – a sostenere il movimento della distanza.
Ed è proprio qui che si gioca il tema della prevenzione.
La prevenzione non consiste nel rieducare un genere, né nel cercare un colpevole unico. La prevenzione consiste nel non creare vittime:
– dare alle ragazze strumenti per costruire confini interni solidi;
– sostenerle nella possibilità di stare nella solitudine senza viverla come abbandono;
– aiutarle a leggere i segnali del legame;
– permettere loro di riconoscere la differenza tra amore e annullamento;
– metterle nella posizione simbolica di poter scegliere, prima di essere catturate.
E, allo stesso tempo, la prevenzione consiste nel permettere ai ragazzi di accedere alla separazione senza viverla come annientamento, di fare esperienza della mancanza senza percepirla come rovina, di tollerare l’Altro che se ne va senza doverlo annientare.
Non tutte restano prigioniere.
Non tutte diventano vittime.
E non tutti gli uomini diventano carnefici.
Per affrontare davvero la violenza, dobbiamo accettare che essa non ha genere. Ha una struttura, una storia soggettiva, un nodo specifico nel rapporto con l’Altro.
È nella complessità, non nella semplificazione, che possiamo finalmente ritrovare la possibilità di scegliere.
Per leggere gli altri articoli di Chiara Baratelli, clicca sul nome dell’autrice












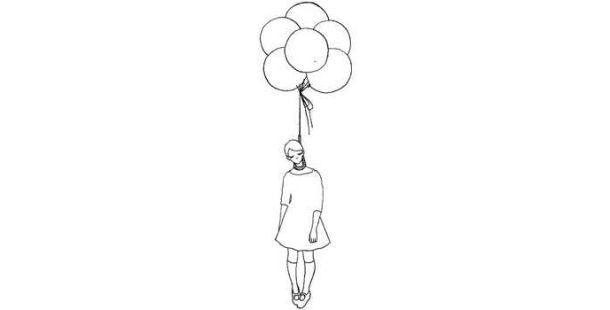
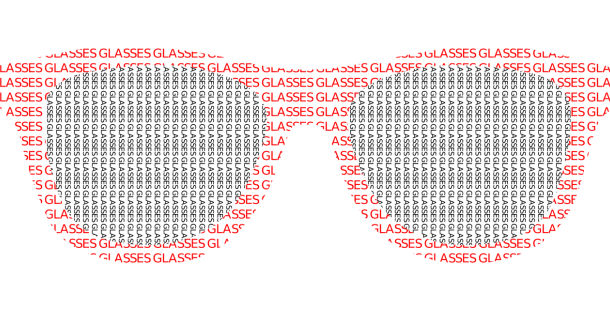


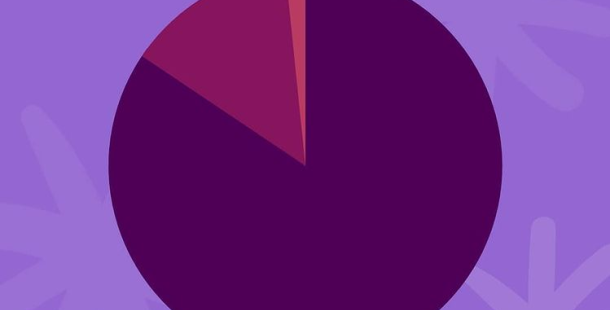

Molto utili le linee indicate per l’educazione e chiaro tutto il ragionamento. Molto condivisibile anche la dichiarazione che la violenza non ha genere, ma questo non mi sembra metta in discussione il fatto che in un mondo basato su uno schema “patriarcale” di funzionamento, usare la violenza come modo di gestire le relazioni abbia origine su un sistema che fa del potere la misura della qualità delle persone. Sbaglio?