Piedi, cammini e simboli
Piedi, cammini e simboli
Fare a pezzi un corpo e concentrarsi su uno dei suoi organi è un vizio da necrofili, un dovere da chirurghi, un vezzo poetico. Eppur a tutti è capitato di farlo. I capelli sono troppo corti o troppo lunghi; le mani sono secche, rugose, piccole, grandi, grasse o magre; i piedi sono lunghi o corti, piccoli, piatti o arcuati. La pancia non è mai abbastanza piatta, altre parti del corpo … dipende.
Non solo queste considerazioni ci accompagnano di sovente nei nostri momenti di ozio, ma si acuiscono a seconda dell’umore, del livello di stanchezza che può toccare la stratosfera, del livello di abbattimento generale causato da tutti i guai che accompagnano la terra in questi giorni.
Uno degli organi che suscita in me più riflessioni è il piede, entrambi i piedi. Forse perché basta che abbassi lo sguardo e li vedo sempre lì attaccati alla parte finale delle mie gambe, a volte un po’ più gonfi del solito, soprattutto quando fa caldo e sono stati tutto il giorno nelle scarpe da ginnastica con le quali corro di qua e di là per lavoro, parenti, amici, spese, inconvenienti e curiosità.
Anche dopo la doccia li vedo sempre là in fondo alle gambe, bagnati e scivolosi pronti a lasciarmi col sedere sul pavimento se non li appoggio subito all’asciutto, uscendo dalla gabbia di plastica che racchiude il vapore appena abbandonato dell’acqua calda finita nel tubo di scarico.
A volte li guardo più da vicino, quando sono raggomitolata sul divano e leggo gli articoli di Periscopio.it visualizzandoli sul telefono, quando mi accovaccio nell’orto per innaffiare i pomodori, le melanzane e i cetrioli, quando faccio Yoga e improvvisamente me li trovo oltre la testa nella posizione dell’Aratro. Visti da vicino sono più grandi e imponenti, con tanti ossicini, tante articolazioni e tante venuzze verdi che traspaiono sotto la pelle.
La loro salute è essenziale, attraverso di loro si vede quanta vita è stata vissuta e come la si è affrontata. Sono segnalatori di malattie se diventano violacei o piagati e portatori di intimità quando li si aggroviglia ad altri piedi spazialmente prossimi. Questo tipo di aggrovigliamento non è tra i miei preferiti, mi piace che i piedi siano liberi di muoversi, fermarsi, correre, tirare un calcio, saltare un ostacolo, ballare.
C’è molta vita nei piedi che percorrono un cammino e, ancora di più, in quelli che ballano. I piedi che ci permettono di danzare garantiscono una vera maestria, uno spettacolo sorprendente. Non c’è dubbio che i piedi siano un tramite tra musica e corpo, basta osservare i bambini quando improvvisamente sentono una canzone. Cominciano a dimenarsi a ritmo della musica compiendo movimenti tanto naturali quanto armonici.
Non c’è ancora una disciplina, un rigore nei movimenti che caratterizza le forme di danza più evolute, ma c’è una tendenza alla rappresentazione corporea che usa i piedi come tramite per la sua realizzazione. Frasi come “get on your feet”, “move your feet”, “dance your shoes off” compaiono spesso nella musica pop che imperversa in streaming, mentre i piedi come simbolo di ribellione e liberazione attraverso la danza, sono ben rappresentati in Footloose, un film del 1984 diretto da Herbert Ross e distribuito dalla Paramount Pictures.
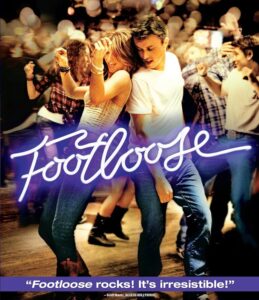 Nel film, Ren McCormack, ragazzo di Chicago, si trasferisce con la madre separata a Bomont un piccolo paese di provincia che ha bandito la musica rock, il ballo e tutto ciò che può corrompere la moralità dopo che cinque ragazzi (tra i quali il figlio del reverendo del paese Shaw Moore) sono morti mentre tornavano da un concerto. Ren riuscirà a riportare la musica in paese grazie ad una festa di ballo memorabile.
Nel film, Ren McCormack, ragazzo di Chicago, si trasferisce con la madre separata a Bomont un piccolo paese di provincia che ha bandito la musica rock, il ballo e tutto ciò che può corrompere la moralità dopo che cinque ragazzi (tra i quali il figlio del reverendo del paese Shaw Moore) sono morti mentre tornavano da un concerto. Ren riuscirà a riportare la musica in paese grazie ad una festa di ballo memorabile.
Bella storia, belle inquadrature e primi piani sui piedi dei ragazzi che ballano. Ballano, ballano, una tribù che balla. Il film ha una colonna sonora famosissima e la frase “Tonight I gotta cut loose, footloose/Kick off your Sunday shoes” (“Stasera devo scatenarmi, sfogarmi/Togliti le scarpe della domenica”) è diventata un simbolo di ribellione e liberazione attraverso la danza. Il film ha vinto due Golden Globes per le canzoni “Footloose” e “Let’s Hear It for the Boy” e tre candidature all’Oscar.
I piedi sono organi di movimento estremamente complessi, costituiti da uno scheletro composto da ventisei ossa articolate tra loro, che sfrutta per i propri movimenti un complicato sistema di forze muscolari, tendinee, capsulari, legamentose e neurotiche. I piedi, grazie alla loro complessa anatomia, sono in grado di eseguire una vasta gamma di movimenti. Questi possono essere movimenti di flessione ed estensione, inversione ed eversione, supinazione e pronazione. In aggiunta, i piedi effettuano movimenti complessi durante la deambulazione, come l’ammortizzazione, il supporto e la propulsione.
Sono organi importanti dal punto di vista funzionale, estetico e simbolico. Guardando i propri piedi non sempre ci si rende conto di quanto compagnia ci facciano e di quante persone abbiano riflettuto sulla loro presenza, utilità e bellezza. I bambini piccoli se li succhiano, i grandi li massaggiano, impomatano, tatuano, colorano, fotografano e agghindano con calze di tutti i colori e con scarpe che, in parte servono per accompagnare la camminata e in parte affermano uno status e l’eventuale desiderio di trovare l’amore.
I piedi sono affascinanti, lo sono stati per molti pensatori. Così scrive, ad esempio, il poeta Pablo Neruda nella sua Oda a los pies: “Mis pies eran dos palomas / atrapadas / por la gravedad de la vida...” (I miei piedi erano due colombe / intrappolate / dalla gravità della vita…). Oda a los pies (Ode ai piedi) è un componimento in cui il poeta celebra i piedi come parte integrante del corpo umano e della vita stessa. In particolare, sottolinea il ruolo fondamentale dei piedi nel movimento, nella scoperta, nel contatto con la terra e nell’esperienza dell’esistenza.
Nella tradizione religiosa o mistica i piedi sono simbolo di devozione e sono spesso associati all’umiltà, alla venerazione o alla sottomissione. I piedi raccontano il movimento, il cammino, la resistenza. Sono simbolo della vita in marcia, del destino e della trasformazione. Dante, nella Divina Commedia, descrive spesso il movimento dei personaggi in termini di cammino: i piedi sono ciò che li porta verso la redenzione o la dannazione.
I piedi sono anche un dettaglio estetico o sensuale. Soprattutto nel decadentismo, nel simbolismo e in certi autori moderni, i piedi possono diventare oggetto di contemplazione estetica o di desiderio erotico. Sono un elemento realistico o degradante in autori naturalisti come Zola e Verga, mentre in autori più contemporanei, i piedi sono spesso rappresentati in modo crudo, come parte di un corpo che lavora, soffre, marcisce.
I piedi sono inoltre simbolo poetico o spirituale. Per alcuni poeti o scrittori, i piedi possono evocare leggerezza, la libertà, l’infanzia, o essere segno di passaggio sulla terra. Ad esempio, Rainer Maria Rilke usa spesso immagini corporee delicate ai i piedi che danzano, scivolano e ci sfiorano.
Tanti illustri personaggi si sono occupati di piedi scrivendo, ballando, parlando, pensando. Eppure, se li guardo sono semplicemente i miei piedi e proprio in questa semplicità ritrovo il senso della loro presenza e appartenenza. Sono i miei, sono il mio corpo, altri come questi non ci sono, camminano con me e invecchiano con me. In questa loro perenne presenza sono confortanti e in questa loro accompagnare la mia età sono tranquillizzanti.
Un passo dopo l’altro, dopo l’altro, dopo l’altro … chissà dove si arriverà.
In psicanalisi, i piedi possono essere interpretati come simboli di diversi aspetti della psiche. Possono rappresentare l’ancoraggio alla realtà, l’attaccamento alla terra, l’orientamento nella vita, e il rapporto con la sessualità e la sessualizzazione.
Alcuni psicoanalisti hanno inoltre collegato i piedi a simboli di potere e controllo, così come al desiderio e alla gratificazione. James Hillman, nel suo approccio psicologico, considera i piedi come un ponte tra il corpo e lo spirito, simbolicamente collegati alla nostra capacità di muoverci nel mondo e di prendere decisioni.
I piedi, per Hillman, sono strumenti per l’esperienza del camminare, una pratica che lo psicologo vede come un modo per entrare in contatto con il mondo e con sé stessi. Il cammino e la sua associata azione di camminare, usano come tramite i piedi e come fine l’entrare in contatto con il mondo.
Un contatto che può causare grande sofferenza in questo periodo, in cui la terra e i suoi abitanti soffrono per delle guerre inutili e devastanti, le grandi democrazie non si sa se siano davvero grandi e, soprattutto, se siano ancora democrazie. Un mondo che rende triste il cammino. Per questo i piedi dovrebbero fare male, il loro contatto con il mondo li dovrebbe rendere molto dolenti, in accordo con il rifiuto della violenza in tutte le sue manifestazioni.
Anche i miei piedi non sono ben messi, certe volte mi pungono come se contenessero aghi. Così come quelli di molti miei simili, che camminano su questa terra bellissima e adesso dolorante. Ma questo non deve interrompere il cammino, né farci credere che sia inutile camminare, anzi attraverso il cammino possiamo vedere con maggiore lucidità il mondo. Percorrendo strade e sentieri sia fisici che spirituali, possiamo trovare pensieri buoni che addomesticano la preoccupazione per il futuro e possiamo riscoprire la semplicità di un gesto quotidiano che migliora la vita.
Tutto ciò grazie ai nostri piedi che sono garanzia di movimento, veicolo di cammino e soggetto di rappresentazione simbolica.
Intanto li guardo, questi miei piedi magri e lunghi, e penso di dover rammendare le calze, perché hanno un buco da cui esce l’alluce. Non che mi dispiaccia così il mio alluce, lo vedo in una inquadratura originale, ma questo non si confà al buongusto imperante e un po’ di senso di comunità deve albergare in ogni comportamento e parola.
Belli i piedi per quello che ci permettono di fare e pensare dirigendo il cammino verso un modo nuovo.
Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/
Per leggere tutti gli articoli e gli interventi di CatinaBalotta, clicca sul nome dell’autrice







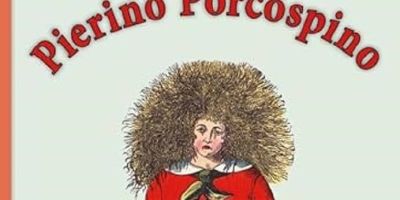





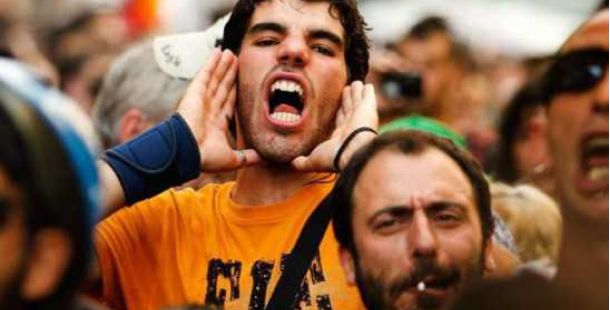




Bellissimo articolo, ti fa camminare in mo(n)di nuovi!
Grazie!. Effettivamente manca una “n” a “mondo”, ma credo che si capisca anche quello. 🙂