Cos’è veramente la Sovranità Alimentare?
Ce lo spiega l’inventore: il documento di Via campesina.
Tempo di lettura: 8 minuti
L’istituzione, nel primo governo della Destra, del nuovo Ministero per la Sovranità Alimentare, è stata oggetto di grandi applausi, feroci critiche e vari e variopinti commenti. Molti si sono stupiti – io non sono tra questi – dell’utilizzo in versione patriottica e populista di quella locuzione, “sovranità alimentare”. che eravamo abituati a sentire in tutti altri ambiti e con opposte intenzioni.
Le parole, prima ancora delle idee e delle notizie, sono forma e sostanza del mio lavoro. Così ho imparato che le parole hanno una storia lunga e complicata, esattamente come la vita di ognuno di noi. Una parola può apparire, scomparire e riapparire in un campo e un senso diverso o addirittura opposto. Qualche volta una parola può andare incontro ad uno straordinario successo, invadere i media, fino a trasformarsi in un semplice intercalare, cioè non significare niente di niente.
Non è forse questo il triste destino di parole come resilienza, sostenibilità?
La “Sovranità alimentare” sta seguendo la medesima parabola. Nella sua breve storia – ha raggiunto da poco 25 anni – è già stata rubata, riutilizzata, ribaltata, banalizzata.
In questi casi, la cosa migliore da fare è risalire la corrente. Andare alle origini. Interrogare gli inventori (senza copyright) della “sovranità alimentare”.
Vía Campesina (in spagnolo: “la via dei contadini”) è un movimento internazionale, una federazione formata da 182 organizzazioni presenti in 81 paesi, tra questi, per fare un solo esempio, Sem terra, lo storico movimento sociale brasiliano contro il latifondo e le multinazionali dell’alimentazione.
 Via Campesina coordina le organizzazioni contadine dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene dell’Asia, dell’Africa, dell’America e dell’Europa.
Via Campesina coordina le organizzazioni contadine dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene dell’Asia, dell’Africa, dell’America e dell’Europa.
Si oppone con azioni concrete allo sfruttamento dell’ambiente e del lavoro, al sistema agricolo capitalistico e propone l’agricoltura sostenibile.
Proprio Via Campesina ha coniato il termine sovranità alimentare.
Cosa è, cosa dovrebbe essere, cosa è necessario fare per attuare la sovranità popolare, ce lo racconta un recentissimo documento di Via Campesina, tradotto e diffuso in tutto il mondo, ma che in pochi hanno avuto la possibilità di leggere. Periscopio lo riproduce integralmente.
Buona lettura. e diffidate dai falsi e dalle imitazioni.
Francesco Monini
Direttore responsabile di Periscopio
Dichiarazione politica di Via Campesina del 16 ottobre 2022 in occasione della Giornata internazionale d’azione per la sovranità alimentare dei popoli contro le multinazionali
Tradotto dall’originale del sito di Via Campesina da Altragricoltura – Matera
Il nostro mondo fragile deve affrontare un’incombente crisi alimentare globale. L’impatto del COVID-19 ha spinto più persone nella povertà. Le misure di confinamento hanno devastato i mezzi di sussistenza delle famiglie e dell’economia e interrotto le catene di approvvigionamento. A livello globale, secondo il Global Report on Food Crises 2022 (GRFC), i livelli di fame rimangono allarmanti come nel 2021, con circa 193 milioni di persone in 53 paesi in condizioni di grave insicurezza alimentare e bisognose di assistenza urgente. Questa grave carestia è alimentata da conflitti, condizioni meteorologiche estreme, i drammatici effetti economici e sociali della pandemia e, più recentemente, dalla guerra in Ucraina. I prezzi delle materie prime alimentari all’inizio del 2022 erano al punto più alto in 10 anni e i prezzi del carburante al punto più alto in 7 anni. L’attuale crisi alimentare riguarda l’accessibilità economica; anche dove il cibo è disponibile, il suo costo è fuori dalla portata di milioni di persone, mentre l’aumento dei prezzi aggrava le sfide per coloro che possono a malapena permettersi il cibo in tempi normali.
La crisi alimentare in questo momento è senza precedenti, perché si svolge nel mezzo di un contesto globale più difficile di quello delle crisi alimentari e dei combustibili del 2008. L’intensità e la frequenza degli shock climatici sono più che raddoppiate rispetto al primo decennio di questo secolo. Negli ultimi 10 anni, circa 1,7 miliardi di persone sono state colpite da disastri climatici, di cui quasi il 90% sono diventati rifugiati climatici. Fame, malnutrizione e povertà sono più difficili da superare a causa di guerre, conflitti e disastri naturali in corso. Ciò ostacola tutti gli aspetti di un sistema alimentare, dalla raccolta, lavorazione e trasporto del cibo alla sua vendita, disponibilità e consumo.
Ma porre fine alla fame non riguarda solo l’offerta. Oggi si produce abbastanza cibo per sfamare tutti sul pianeta. Il problema è l’accesso e la disponibilità di cibo nutriente, che è sempre più ostacolato da molteplici sfide, come la pandemia di COVID-19, il conflitto, il cambiamento climatico, la disuguaglianza, l’aumento dei prezzi e le tensioni internazionali.
Mentre il passaggio dal multilateralismo al modello multistakeholderismo ( ndt: ovvero il passaggio dal sistema del multilateralismo che coinvolge gli stati e le grandi corporazioni alla base delle politiche dell’Organizzazione Mondiale del Commercio a quello che coinvolge tutti gli altri portatori di interesse della società civile e dei cicli economici) si allarga nel dibattito interno alle piattaforme delle Nazioni Unite, in realtà le multinazionali continuano a controllare il dibattito e la narrazione sul cambiamento. Il loro potere sui sistemi agroalimentari ha continuato a crescere e la finanziarizzazione sta trasformando cibo e terra in oggetti di speculazione. Il recente processo UNFSS (United Nations Forum on Sustainability Standards) è un chiaro esempio di questa tendenza. Il fallimento delle politiche neoliberiste e dell’agricoltura industriale (compresi gli OGM) nell’accrescere i raccolti e i profitti, ha portato alla concentrazione del potere in poche società transnazionali (TNC) che controllano i Big Data, i terreni agricoli, le risorse oceaniche, le sementi e gli input agrochimici, con il risultato che ormai dominano sempre più i nostri sistemi alimentari e si appropriano dell’80% del cibo prodotto dagli agricoltori a conduzione familiare. La finanziarizzazione ha portato a una concentrazione del mercato senza precedenti per alimentare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e (bio)tecnologie, con l’obiettivo di espandere le frontiere del capitalismo per impadronirsi di tutta la biodiversità del mondo.
In tutto il mondo, c’è una tendenza alla riduzione dello spazio di partecipazione civile e alla riduzione delle attività di difesa dei diritti umani. Gli attivisti a livello locale sono sempre più vulnerabili alle violazioni dei diritti umani, all’oppressione e alla criminalizzazione. La violenza della repressione di Stato, che utilizza le forze armate e di sicurezza, prende di mira le persone e colpisce masse di manifestanti pacifici in tutto il mondo. D’altra parte, il primato e la legittimità del settore pubblico è sempre più minato dall’azione delle lobbies che si appropriano dei processi politici e da una narrativa dello sviluppo che assegna il ruolo guida agli investimenti del settore privato, mentre il multilateralismo è attaccato da un nazionalismo virulentemente populista e da un modello multipartitico egemonizzato dalle lobbies.
Negli ultimi tre decenni è cresciuta una rete sempre più solida, diversificata e articolata di piccoli produttori alimentari, lavoratori e altri attori sociali danneggiati dal sistema alimentare globalizzato guidato dalle multinazionali, che sostiene una trasformazione radicale dei sistemi alimentari e dell’agricoltura basata sulla sovranità alimentare. Questi movimenti si sono decisamente impegnati a difendere e gestire sistemi di fornitura degli alimenti ecologicamente e socialmente sostenibili e territorialmente radicati, che si tende a chiamare “alternativi”, sebbene forniscano fino al 70% del cibo consumato nel mondo. . Ripensare le politiche agricole come una questione di sicurezza economica e nazionale deve essere una priorità.
Il movimento per la Sovranità Alimentare è stato una parte dinamica dell’articolazione della trasformazione e delle soluzioni sin dagli anni ’90, e attraverso lo storico Forum di Nyéléni sulla Sovranità Alimentare nel 2007 e il Forum sull’Agroecologia nel 2015. 25 anni dopo la messa in campo del concetto di Sovranità Alimentare, i nostri movimenti uniscono le loro voci chiedendo un cambiamento sistemico per aprire la strada a un futuro di speranza.
Chiediamo un intervento immediato per:
- La cessazione della speculazione alimentare e la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari nelle borse merci. Il prezzo degli alimenti commercializzati a livello internazionale deve essere legato ai costi di produzione e seguire i principi del commercio equo, sia per i produttori che per i consumatori;
- La cessazione del controllo dell’OMC sul commercio alimentare e l’esclusione della produzione alimentare dagli accordi di libero scambio. I paesi devono avere riserve alimentari pubbliche e regolamentare il mercato dei prezzi, al fine di supportare i produttori alimentari su piccola scala in questo contesto difficile;
- La creazione di una nuova organizzazione internazionale per condurre trattative trasparenti negli accordi commerciali tra paesi esportatori e importatori, in modo che i paesi che dipendono dalle importazioni alimentari possano accedervi a un prezzo accessibile;
- Proibire l’uso di prodotti agricoli per produrre biocarburanti o energia. Il cibo dovrebbe essere una priorità assoluta rispetto al carburante.
- Una moratoria globale sul pagamento del debito pubblico da parte dei paesi più vulnerabili. Fare pressione su questi paesi per pagare il loro debito è altamente irresponsabile e porta a crisi socioeconomiche e alimentari.
Chiediamo cambiamenti radicali nelle politiche internazionali, regionali e nazionali per ricostruire la sovranità alimentare attraverso:
- Un cambiamento radicale nell’ordine del commercio internazionale. L’OMC deve essere smantellato. Un nuovo quadro globale per il commercio e l’agricoltura, basato sulla sovranità alimentare, dovrebbe aprire la strada al rafforzamento dell’agricoltura contadina locale e nazionale, garantire una base stabile per la produzione alimentare delocalizzata, sostenere i mercati guidati dai contadini locali e nazionali e fornire un sistema commerciale internazionale basato sulla cooperazione e sulla solidarietà;
- L’attuazione della popolare e globale Riforma Agraria, per fermare l’accaparramento di acqua, semi e terra da parte delle multinazionali e garantire ai piccoli produttori diritti equi sulle risorse produttive; protestiamo contro la privatizzazione e l’accaparramento della terra e del patrimonio da parte di interessi finanziari con il pretesto di proteggere la natura, attraverso mercati del carbonio o altri programmi di compensazione della biodiversità, senza tener conto delle persone che vivono in questi territori e che si sono presi cura di quel patrimonio per generazioni;
- Uno spostamento radicale verso l’agroecologia per produrre cibo sano per il mondo. Dobbiamo affrontare la sfida di produrre cibo di qualità sufficiente, riattivando la biodiversità e riducendo drasticamente le emissioni di GHG;
- Una regolamentazione efficace del mercato degli input (quali credito, fertilizzanti, pesticidi, sementi, combustibili) per sostenere la capacità di produzione alimentare dei contadini, ma anche per garantire una transizione giusta e ben pianificata verso pratiche agricole più agroecologiche;
- Governance alimentare basata sulle persone, non sulle multinazionali. La conquista della governance alimentare da parte delle transnazionali deve cessare e l’interesse delle persone deve essere messo al centro. Ai piccoli proprietari deve essere assegnato un ruolo chiave in tutti gli organi di governance alimentare;
- Lo sviluppo di politiche pubbliche per assicurare nuove relazioni tra chi produce cibo e chi lo consuma, chivive nelle zone rurali e chi vive nelle aree urbane, garantendo prezzi equi definiti in base al costo di produzione, che consentano un reddito dignitoso per tutti coloro che producono sul campo e giusto accesso a cibi sani per i consumatori;
- La promozione di nuove relazioni di genere basate sull’uguaglianza e il rispetto, sia per le persone che vivono nelle campagne che tra la classe operaia urbana. La violenza contro le donne deve cessare ora.






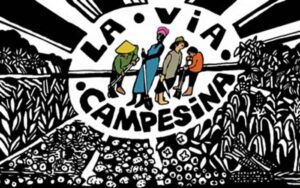












Lascia un commento