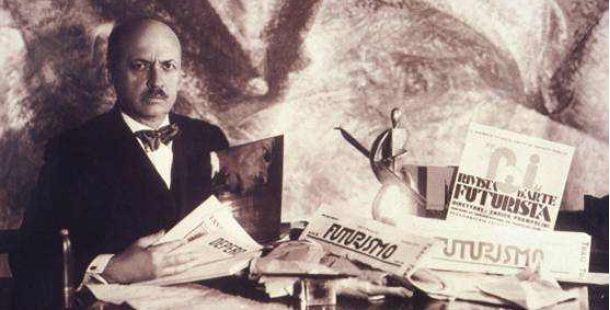ARCHIVIO DELLA MEMORIA
La commedia macabra del terrorismo e il nero lenzuolo della fine
Stavo scendendo dalla collina, il clima era splendido, se avessi dovuto scegliere il giorno perfetto, ecco ci ero dentro. Così ragionavo tra me e me facendo attenzione a dove mettevo i piedi, le zolle erano ancora un po’ sollevate e mi capitava, affrontando la discesa ripida, di inciampare, scivolare e capitombolare giù. Ma non ci furono incidenti, la mia mente, di solito abbastanza confusa, tentò di fregarmi facendomi immaginare asini che volano o, peggio, facendomi tornare alla memoria il tentativo poetico che la sera prima avevo composto per cercare il sonno prefigurandomi una notte tranquilla, per favore senza sogni: “Saliamo – avevo scritto, nel pensiero – saliamo ogni giorno sul Golgota della nostra vita, guidati da una cultura incosciente e la sera scivolo giù da quel monte per finire nel pattume della società”: sul monte ora c’ero davvero, sicché, inciampando qua e là, mi ritrovai sotto un albero di ciliegie marasche e ai miei piedi il corpo immoto di una ragazza. Uno straccio pareva. Mi fermai di botto, quel corpo sconosciuto, le braccia così bianche sulla terra bruna, mi aveva trasferito in un altro mondo, chissà quale e chissà dove, l’aria muoveva soltanto la maglietta, i jeans – mi pare che quell’essere indossasse i jeans – erano aderenti alle gambe e l’aria della pur splendida primavera non era in grado di scompigliare gli indumenti.
E tu chi sei?, chiesi al sole e al vento, ma nessuno rispose. Un filo di sangue aveva formato una macchia sul petto della ragazza. Allora cercai di ricostruire la piccola popolazione che aveva preso possesso della cascina Spiotta lassù in alto: sapevo che doveva esserci o esserci stato il capo della banda di terroristi, comandati da Renato Curcio, poi Massimo Maraschi, quindi il sequestrato Vallarino Gancia, chiamato anche il “re dello spumante”. Non ricordavo altri. Una sola donna: lei, rivoluzionaria della prima ora, Margherita (Mara) Cagol, fondatrice delle Brigate Rosse, figlia di noti intellettuali altoatesini.
Avevo la bocca arsa dalla sete, c’erano le ciliegie, chiesi scusa al cadavere e cominciai a mangiare i frutti vermigli; finalmente arrivò una pattuglia formata da due carabinieri. Chi è?, chiesi indicando il cadavere. E lei?, fu la risposta. Giornalista, dissi piano, non si sa mai, pensai: ero già in disaccordo con la mia santa professione. C’era stata una furiosa sparatoria, mi informarono i carabinieri, erano morti due militi, era morta la Mara, Curcio era scappato, il rapito era stato liberato, ma, insomma, non era stata una grande operazione di polizia. Il magistrato inquirente mi disse che aveva richiesto l’intervento di una pattuglia consistente, non di pochi uomini, “ma non lo scriva”, si raccomandò, “sapevamo che nella cascina Spiotta c’era il commando brigatista”. Capii allora che esistevano ordini superiori. E il brigatista catturato, chiesi, che fine gli fate fare? “Quello lo incrimino per il sequestro e per l’omicidio”. Ma alla fine dell’iter giudiziario il brigatista fu liberato. Costume italiano. Mi accorsi così che l’affare Brigate rosse era veramente una faccenda di Stato sulla quale il cittadino-pantalone non doveva mettere occhio, nemmeno dal buco della serratura (quello usato da noi giornalisti).
La commedia macabra era appena cominciata, per anni ci sarebbero stati ammazzamenti brutali, quando non selvaggi, giudici inquirenti pilotati dall’alto, spie, ladri di Stato, assassini assoldati per tenere in ebollizione questa nostra società dominata da loschi figuri, loschi figuri quasi sempre di volgare ignoranza: “No – pensai parlando al cadavere – questa non è la Rivoluzione, è una violenta scazzottatura”. Di giorno in giorno aumentavano i motivi di odio, lo stato di polizia non aiutava certo a rappacificare una società pronta sempre a farsi iniqua, a condannare i più deboli, a mandarli al macello con un’indifferenza sconcertante, a fare guerre per l’onore del principe e tutto al fine di costruire un Paese sempre più ignorante, la gente, o il popolo se vuoi, soffocato da stupide burocrazie in cui non rimane che annegare, naturalmente con la benedizione di un porporato: come comanda la società di oggi. Era questo il Paese che volevamo?
Non so, quel giorno di primavera ero preso da quel cadavere che guardava il cielo, sinceramente io guardavo le marasche, mi faceva pena quell’essere che aveva scelto di uccidere ed essere ucciso per ricominciare dal nulla… Siamo dominati da un sordo rancore, la poesia è stata cancellata e con essa la bellezza che pur esiste, abbiamo dilaniato la nostra intelligenza, che è il nostro Dio, ci hanno gettato addosso un nero lenzuolo, ci hanno asciugato le poche lacrime rimaste. Andiamo pur avanti. Si fa per dire andiamo avanti. Non era questa la rivoluzione.