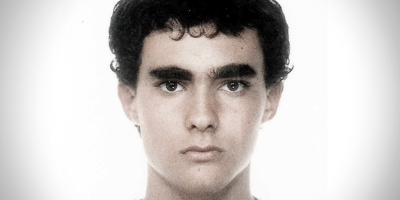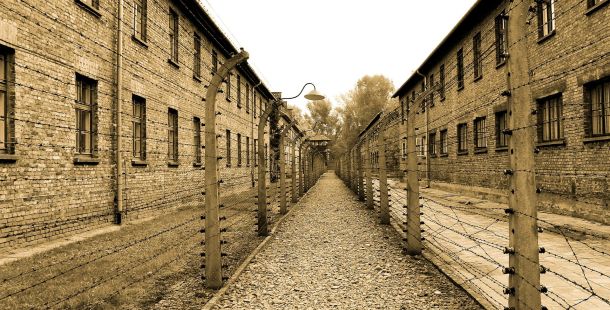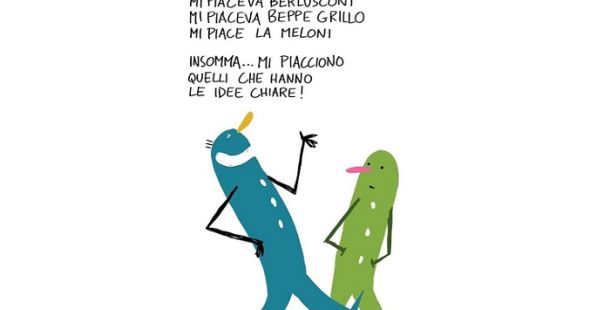L’EVENTO
Iperealismo e atmosfera d’antan nei ritratti chic di Corcos
di Anna Maria Fioravanti
Corcos, un “artista fatto per piacere, come la sua pittura, attenta, levigata, meticolosa: donne e uomini come desiderano d’essere, non come sono”, scriveva Ugo Oietti nel 1933.
Ritrattista della ricca società internazionale e dei più importanti intellettuali dell’epoca, il livornese Vittorio Matteo Corcos (Livorno 1859-Firenze 1933) perfezionò il suo stile inconfondibile a Napoli con Domenico Morelli, poi, accanto a De Nittis e all’abile mercante Goupil a Parigi, dove soggiornò per sei anni, dal 1880 al 1886. Virtuosismo tecnico, ricerca della bellezza ideale e solida preparazione culturale plasmano fatalmente la sua attenzione per la sofisticata eleganza di un mondo femminile elitario, dove donne bellissime e di alto rango impongono un modello estetizzante, misto di realtà e finzione. Frequentazioni ‘giuste’ lo mettono in contatto con Degas, Manet, Caillebotte, Zola, Edmond de Goncourt, De Nittis, arricchendo così della lezione naturalista la tenuta figurativa, la sicurezza del tocco, gli abili accordi cromatici di ritratti femminili a pastello alla Watteau.

In realtà, i suggerimenti dell’Impressionismo non lo attirano, tanto che più volte dichiarò i propri dubbi e resistenze nei confronti dell’avanguardia francese. Al contrario, a Parigi, Corcos era considerato il “peintre des jolies femmes”, creature dalle carni rosee, dalle labbra rosse come il sangue, dai glauchi occhi lucenti, dai veli bianchi”. Se da un lato il suo realismo esasperato e quasi fotografico è alla base della lunga e fortunata carriera di ritrattista di successo, conteso dalla mondanità più esclusiva, dall’altro l’incomprensione della critica modernista sottolineava il suo stile conservatore, desideroso di compiacere i gusti del pubblico.
Verso la fine dell’Ottocento le richieste per i suoi ritratti s’intensificano, allargando il giro alla committenza imperiale (ritratti di Guglielmo II, della moglie Augusta Vittoria e di Amelia d’Orleans 1905). Qui Corcos ricorre alla tradizione aulica della ritrattistica di corte di età neoclassica attingendo a modelli di Mengs, Batoni e Giovanni Battista Lampi, perfezionando una forma di ritratto mondano adatto a celebrare principesse ed anche celebri artiste di teatro come la soprano Lina Cavalieri (1903). Ed è proprio in questo ritratto che si confronta con Giovanni Boldini, l’altro grande ritrattista interprete, più di lui, dello spirito della donna moderna, eroina letteraria ma colta con “effetto di verità” dal tocco disinvolto ed eccentrico: come Boldini, anche Corcos ha grande capacità di captare e fissare sulla tela lo ‘status’ delle sue modelle e rendere il dettaglio prezioso sia esso un tessuto o un’ambientazione.
Ma il gusto descrittivo non sempre è finalizzato ad accentuare i risvolti emotivi, psicologici e sentimentali. A smentire tale affermazione un po’ affrettata che nasce ai margini della vasta antologica (con più di 100 opere) di Padova, è il dipinto intitolato “Sogno” (1896), un quadro giudicato modernissimo fin dalla sua prima esposizione. Corcos raffigura una giovane donna, Elena Vecchi, vestita con sobria e raffinata eleganza. Seduta su una panchina dove sono posati tre libri, un cappellino di paglia e l’ombrellino, protende lo sguardo intenso verso lo spettatore. Anche la posa disinvolta con le gambe accavallate e il mento posato sulla mano, esprime tutta la sicurezza della giovane donna intellettuale moderna, che non teme di mostrarsi inquieta e appassionata come simbolicamente indicano i petali di rosa sparsi a terra.
E di nuovo vediamo l’artista attratto dal simbolismo in una grande opera “Lettura sul mare” (1910), dipinta a Castiglioncello dove risiedeva per lunghi periodi in una lussuosa villa situata a Punta Righini (quella villa sarà acquistata poi nel 1963 da Alberto Sordi). Qui è la figliastra Ada a rappresentare con sguardo malinconico le inquietudini giovanili in un chiarore abbacinante, con il mare alle spalle, in abito bianco: è seduta al centro fra due giovani ragazzi con un libro aperto sulle ginocchia: uno è sdraiato sul muretto, l’altro è seduto. Tutti sono assorti, chi nella lettura, chi in riflessioni su quanto letto.
I tre libri dalla copertina gialla delle edizioni Flammarion sono in bella vista in primo piano. Un iperrealismo magico ferma l’immagine come un fotogramma e lascia nella luce bianca sottili segni di inquietudine. Quell’inquietudine che Pascoli, Carducci e D’Annunzio, assidui frequentatori del salotto letterario fiorentino della famiglia Corcos e del cenacolo del Marzocco hanno interpretato con grande maestria.
Un deciso rinnovamento di mezzi espressivi e delle tecniche pittoriche che molto debbono alla fotografia, lo faranno emergere come protagonista nella rappresentazione della vita moderna, di quello spirito anticonformista ed elitario che caratterizzò l’epoca dannunziana del decadentismo. Monumentale è il ritratto della famiglia Moschini (1910), dove l’individuazione delle figure della madre attorniata dai quattro figli e dal padre seduto al limite della scena, contro lo sfondo del litorale livornese di Castiglioncello giunge alla traduzione fedele delle fattezze dei modelli ritratti nei loro raffinati ambiti estivi. E, come una foto d’epoca, ci restituisce il clima sentimentale e mondano in cui l’opera si cala. Nel virtuosismo di una gamma coloristica rosata che esalta gli incarnati, le vesti, la balaustra marmorea, il ritratto della famiglia Moschini rientra nell’atmosfera rarefatta preraffaellita di Lawrence Alma Tadema (1836-1912), in cui figure panneggiate all’antica sono ritratte sullo sfondo di paesaggi marini e avvolte da romantico languore e raffinata indolenza.
Tutto ciò lascia affiorare il milieu culturale dell’alta borghesia e dell’aristocrazia che amavano essere celebrate secondo un gusto nutrito di cultura letteraria e figurativa e da una sensibilità psicologica profondamente in sintonia con la temperie culturale del tempo che l’artista coglieva nello sguardo dei suoi effigiati tanto da affermare: “In un ritratto quel che conta sono gli occhi: se quelli riescono come voglio il resto viene da sé”.
Che Corcos sia stato affascinato dal gusto decadentista di Alma Tadema e dalla sua rivisitazione dell’antico come prototipo della bellezza e armonia universale lo denunciano i precisi richiami che spesso affiorano nelle sue opere come i petali di rosa, le pose sensuali e le scenografie classicheggianti. Nel bellissimo dipinto “In lettura sul mare”, il giovanotto in impeccabile abito di lino bianco disteso sulla balaustra, è citazione letterale di famose opere dell’artista anglo-olandese, cui lo univano affinità elettive per la pittura elegante e purista e per la passione idealizzante dell’universo femminile.
“Corcos. I sogni della Belle Époque“, a cura di Ilaria Taddei, Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, Padova, Palazzo Zabarella, Fondazione Bano, fino al 14 dicembre.