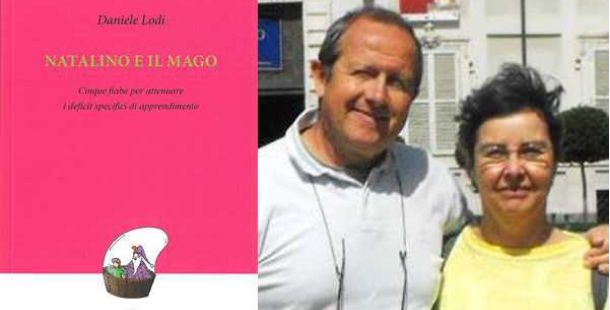LA STORIA
Fotografia e arte digitale di Stefano Bonazzi: dell’amore e di altri demoni
Voglio fare lo scrittore, o il pittore, o magari tutti e due. Forse scriverò un libro e disegnerò le illustrazioni! Così la gente mi capirà.
Da sempre appassionato di grafica e design, nerd per vocazione, studente all’istituto alberghiero.
A 20 anni frequenta un corso di grafica multimediale a cui segue uno stage in agenzia, e comincia a comporre immagini e parole. A scattare fotografie; rielaborandole, aggiungendo, mescolando, per poi creare cose sue. A distruggere quei corpi armoniosi e perfetti creati al mattino, durante il lavoro di webmaster e grafico, immersi in una luce artificiale come i legami fasulli da cui rifugge.
Soggetti e scenari che conserva inizialmente per sé, nell’anonimato di un portatile sulla scrivania; che poi pubblica su Flickr e Deviantart in una parabola ascendente sino al Toca.me di Monaco di Baviera, festival di grafica di livello mondiale, in cui si classifica terzo vincendo una suite. Cominciando a creare seriamente, alla ricerca di gallerie che rappresentino il suo stile. Espone a Miami e Seoul, a Verona e Milano, in personali e collettive. I suoi sono risultati di processi di manipolazione di fotografie originali attraverso l’abbozzo con carboncino e il ritocco digitale con Photoshop, tecniche di colorazione alternativa e illustrazione di fotografie attraverso rendering e Poser per gli effetti 3D, a volte dietro lastre di plexiglass. Ricreando quello accade nella vita reale, raffigurando l’incomunicabilità del mondo contemporaneo, l’impossibilità di essere realmente se stessi in una perfezione imposta ed esasperata, traducendo lo smarrimento e l’incertezza di qualcuno che cerca a volte un altro qualcuno, a volte un altrove.
– Perché indossi quello stupido costume da coniglio?
– E tu, perché indossi quello stupido costume da uomo?
Solo maschere su corpi nudi o ben vestiti in accostamento grottesco esseri strani e alienati, solitari e talvolta soli, basiti e immobili come i paesani statici e alienati di Grant Wood, i ritratti criptici e ambigui di Mark Ryden, l’umanità dolente di Roger Bowlen, gli ansiogeni acquarelli provocatori di Gottfried Helnwein in un circo mai festoso ma alienante, decadente come in universi malati. Ma veri più che mai, questi personaggi grigi che prendono le distanze, freaks orgogliosi di esserlo, dalla finzione di una realtà che opprime con abbaglianti colori di plastica, rivelando la parte notturna dell’essere umano.
Armoniose ballerine ingessate nei tutù neri in attitudes su rocce nere; impeccabili donne-tailleur nascoste da maschere antigas e musi di animali senza vita; figure femminili fuse in bicchieri di latte o spente in una nuvola fumo, come sigarette tristi, inverni nucleari alla Gia Carangi, grotteschi manichini in abito da sera si fanno ammirare da un invisibile pubblico; dame prendono il tè sedute a un tavolino dimenticato. Viandanti con l’unica guida di girandole colorate; eleganti nobiluomini in tuba e bastone che attraversano campi di fiori, o tristi Pierrot compianti persino dall’adorata luna; bimbi sperduti in balìa di navi di carta. Distorte mescolanze tra Bianconigli e malefici Cappellai Matti che ingannano una Alice al di qua non di uno specchio ma di un armadio; gentiluomini nei frac neri prigionieri di spiagge invase da ombrelli abbandonati; violinisti in costumi barocchi intonano melodie statiche, imprigionate su una pagina patinata, che nessuno ascolterà; Forrest Gump con ventiquattrore studiano l’orologio, attendono un autobus che non passerà mai.
28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi… ecco quando il mondo finirà.
Composizioni statiche come i ritratti di Annie Leibovitz, che ne mantengono solo la limpidezza stilistica e ne perdono il candore del bianco e del nero; scene che disorientano lo spettatore, animali domestici che provocano disagio quanto gli insetti claustrofobici di Floria Sigismondi.
Panorami angoscianti e desolati, crudi e disturbati come le narrazioni di Lynch, onirici e fiabeschi come le storie di Tim Burton, immobili ed evocativi come i soggetti inanimati di Hiroshi Sugimoto, evanescenti e desaturati come i campi lunghi di Riccardo Varini.
Sono polverosi deserti o mondi metafisici, di un’ironia esasperata e soffocante. Cieli azzurri ma non celesti, come occhi che guardano passivi panorami accecanti. Mari color della pece e palazzi abbandonati. Sale pubbliche desolate, distorte distese d’erba. Enormi palloncini, mongolfiere sottosopra. Lampade addormentate, sedie di legno in vana attesa. Arcolai e poltrone boudoir. Ospedali deserti, arcate gotiche che raccolgono confessioni non dette.
Mondi da cui non si fa ritorno, il cui silenzio urla qualcosa che resta intrappolato nell’impossibilità di urlare il proprio nome, come imprigionato in una bolla d’acqua. Sono spiazzi desolati di un circo abbandonato, prati disseminati di piccole case sospese da fili di marionette; vagoni di metropolitane deserti e asettici che avviluppano queste caricature umane, a volte; altre le osservano maligne e silenziose, realtà pesanti e allucinatorie, il nulla che avanza inghiottendo gli abitanti di Fantasia attratti da esso morbosamente e senza chiave di accesso né uscita. Spazio ostile o interiore di chi lo occupa, che quasi lo plasma.
Plasma del mezzo che distrugge la vita ma che la ricrea, nelle visioni di qualcuno che cerca a volte un altro qualcuno, a volte un altrove.

Sostieni periscopio!
Giorgia Pizzirani
I commenti sono chiusi.