Globalizzazione, populismo e l’Europa incompiuta
Tempo di lettura: 7 minuti
Globalizzazione, populismo e l’Europa incompiuta
Chi come me ha più di 70 anni ricorda bene gli anni ’70 e ’80, quando i lavoratori italiani e occidentali producevano gran parte di quello che i consumatori del loro paese (tra cui loro stessi) acquistavano. Anche allora c’era qualche prodotto estero, ma era poca cosa nella nostra spesa settimanale. Fu la “prima” società dei consumi del secondo dopoguerra. Essa originò i famosi Trenta Gloriosi, 30 anni eccezionali, forse l’unico periodo della storia in cui c’è stata in Occidente crescita enorme unita all’eguaglianza (nelle rivendicazioni post ’68 c’erano gli aumenti salariali uguali per tutti). Una sorta di libero scambio temperato in cui le produzioni nazionali erano prevalenti.
Dal 1999 inizia tutt’altra storia. Il comunismo sovietico è imploso da 8 anni sotto il peso della sua inefficienza e mancanza di libertà e il liberalismo senza regole crede sia giunto il momento in cui si possa omologare il resto del mondo al proprio credo. Bill Clinton abroga nel 1999 la divisione tra banche d’affari e banche commerciali fatta da Roosevelt nel 1933, che era una risposta al tracollo della borsa e intendeva rilanciare l’America col New Deal, chiedendo alle banche di fare il loro antico mestiere: prestare alle imprese. Da Clinton in poi invece sarà possibile per tutte le banche fare molti più profitti con la speculazione finanziaria, che non prestando soldi a imprese e famiglie per sostenere l’economia reale.
Gli Stati Uniti decidono poi, spinti dagli appetiti delle loro multinazionali, di far entrare la Cina nel 2001 nel commercio mondiale (WTO), delocalizzando migliaia di imprese in modo da decuplicare i profitti sfruttando il basso costo del lavoro cinese. La teoria è che il libero scambio favorisce i consumatori, i quali devono poter comprare i beni ai prezzi più bassi.
Pochi (a parte i sindacati) si preoccupano del fatto che le nostre manifatture vanno spostando all’estero il lavoro manifatturiero (Cina, Vietnam, India, …), dove costa molto meno. La propaganda del libero scambio stronca ogni dissenso in quanto porterebbe occupazione, salari e benessere nei paesi poveri e dunque è “progressista” (più affari per le imprese e per i paesi poveri).
Sarà uno studio dell’economista serbo-statunitense Branko Milanovic (il cosiddetto “elefante”) che, mettendo insieme tutti i lavoratori e i padroni del mondo, come fossimo un solo paese, farà notare come dal 1988 al 2008 i vincenti della globalizzazione siano tutti i padroni (più dei paesi ricchi che poveri) e gli operai dei paesi poveri (cinesi in primis), mentre i perdenti sono operai e classe media dei paesi ricchi. E più di tutti gli operai americani che, perdendo il lavoro in una società fortemente individualista, meritocratica e moralista, vivono uno smarrimento esistenziale. Passando “dalle stelle alle stalle” molti finiranno nell’alcolismo, nella droga, nei suicidi.
Un’epopea ben descritta dall’attuale vicepresidente americano J. D. Vance in Hillbilly Elegy (Elegia per i bifolchi delle colline) che diventerà un romanzo e un film di successo. Questo fenomeno ha colpito (in misura minore) anche l’Europa del Sud, in particolare con l’allargamento ad Est del 2004 che ha fatto entrare nell’Unione circa 100 milioni di lavoratori a basso salario.
I perdenti della globalizzazione – lavoratori spesso votanti del centro-sinistra o socialdemocratici – si sono rivolti ai partiti di destra sperando in una maggiore protezione (anche dalla immigrazione illegale). Emmanuel Todd, sociologo francese di sinistra che ha avuto grande successo col suo libro La sconfitta dell’Occidente, sostiene che questi operai sono stati trasformati con la globalizzazione in una “plebe”, il cui tenore di vita deriva sempre meno dal loro lavoro nelle manifatture e sempre più dal lavoro sottopagato degli operai cinesi, bengalesi, africani, etc…
La teoria del libero scambio ha mantenuto la sua promessa col consumatore, che paga molto meno per qualsiasi bene, a scapito però del produttore. Ma poiché gran parte dei consumatori è stato “bollito” dalla società dei consumi e non vuole tornare in fabbrica, si affermano le plebi occidentali “parassite” che votano però, cosa imprevista dagli apostoli della globalizzazione, partiti di destra o Trump.
Nel frattempo si è verificata un’eterogenesi dei fini: gli Stati Uniti, che erano primi al mondo e pensavano con la globalizzazione di trovarsi con superpoteri, sono diventati vulnerabili. Con 30 anni di globalizzazione hanno arricchito una minuscola élite ma impoverito il loro Stato, producendo: 1) il più alto deficit commerciale al mondo, 2) il più alto onere annuo sul debito pubblico, 3) la distruzione della propria manifattura, 4) una società zombi, in via di crescente disgregazione sociale e sull’orlo della guerra civile.
Nel frattempo la Russia, pur essendo europea e bianca, non partecipa al gioco dello sfruttamento globale ma si ostina a voler rimanere una nazione sovrana al di fuori del sistema. Pur essendo in calo demografico come tutto l’Occidente, cresce economicamente (+70% i salari) e presenta una certa stabilità sociale derivante dalla sua storia di famiglie comunitarie e da una religiosità meno in crisi di quella occidentale. Una democrazia autoritaria, dove ci sono elezioni ma gli oppositori sono ridotti al silenzio, che però cura i rapporti con le minoranze etniche musulmane (il 15% della popolazione).
Nel frattempo la Cina, che non è affatto una democrazia, è diventata un gigante economico: salari medi saliti da 400 a 15.000 dollari all’anno, con 500 milioni di cinesi che consumano come i 440 milioni di europei (quindi con un grande mercato interno) e oggi leader globale in 57 delle 64 tecnologie critiche (fonte: Australian Strategic Policy Institute), quando nel 2007 gli Stati Uniti erano leader in 60 aree su 63. Ciò spiega la guerra dei dazi tra Usa e Cina: se rimanesse tale, le due economie non avrebbero più scambi tra loro, con l’Europa che sarebbe inondata da merci cinesi a basso prezzo.
Nel frattempo il Pil dei Brics è diventato maggiore di quello del G7 occidentale e tra i Brics troviamo tre democrazie (Brasile, India, Sudafrica).
Questo quadro fa capire perché gli Stati Uniti sono in grande difficoltà (al di là della narrazione mainstream propinataci da 20 anni) e tentano azioni di disaccoppiamento dalla Cina e re-industrializzazione che erano già iniziate con Biden e che Trump enfatizza (Make America Great Again). Riportare le fabbriche in patria, ridurre il deficit commerciale e il debito pubblico è impresa improba. Il caos dazi (stop and go, a beneficio ora delle big tech ora degli speculatori, con ribassi e rialzi delle borse) ne dà la misura.
Ma chi pensa di affidarsi di nuovo alla globalizzazione che abbiamo conosciuto, al vecchio liberismo, alla “realtà” delle borse, alla finanziarizzazione che spinge un ingegnere a lavorare in banca o in un fondo speculativo più che in una fabbrica, non ha capito che il mondo neo-liberista senza regole è al tramonto, anche perché senza fabbriche il Pentagono stesso ha spiegato che non si può vincere una guerra convenzionale (come mostra quella ucraina).
Questo quadro fa capire le difficoltà dell’élite europea, sedotta e abbandonata dagli Stati Uniti, con una globalizzazione che ha svuotato anche il suo tessuto produttivo, ampliato le disuguaglianze e minato le basi materiali del benessere di lavoratori e classi medie a vantaggio dei ricchi e dei paesi dell’est. La guerra in Ucraina ha posto fine ad un modello di crescita tedesco ed europeo basato su export di tecnologie in Russia in cambio di materie prime e gas a basso prezzo. Le sanzioni alla Russia hanno comportato una riduzione del Pil europeo di -1,5% (più di quanto si stima avvenga coi dazi di Trump).
Consapevole che siamo agli albori di una Nuova Yalta (una riconfigurazione dei rapporti di forza nel mondo) l’ élite europea non vuole perdere terreno (come gli Stati Uniti), né il potere che dipende, in democrazia, dal consenso dei propri elettori. L’incertezza è enorme, non sapendo se può contare sul proprio leader storico. Si potrebbe superare il finto dualismo liberismo-protezionismo, col rilancio del “social standard” nella regolazione dei movimenti internazionali di merci e di capitali. L’idea è dell’ILO (Agenzia dell’Onu per Lavoro e politiche sociali) e consisterebbe in una limitazione dei commerci (dazi) con quei paesi che attuino politiche di competizione al ribasso su salari e condizioni di lavoro, regimi di tutela ambientale e sanitaria, regole presenti già nei Trattati UE e contenute nello statuto del Fondo Monetario Internazionale, che già in passato ha ricevuto l’attenzione del parlamento europeo.
D’altro canto l’unità europea non esiste e ci vuole tempo. Così si sposta l’attenzione verso un nemico esterno (immigrati, autocrati, Russia), e si vorrebbe mantenere la guerra in corso con la Russia per trovare il tempo di costruire al 2030 una interoperabilità tra eserciti di nazioni diverse. La motivazione è sempre quella: l’invasione dell’URSS (ora della Russia) in Europa. Frank Kofsky ha ricostruito nel libro Truman and the War Scare of 1948, come la CIA sapesse benissimo (la fonte sono i documenti desecretati) che non c’era alcuna azione offensiva dell’URSS, ma bisognava convincere la gente per rafforzare il dispositivo militare della Nato e la crisi di grandi aziende come Lockheed e Northrop.
Se anche l’operazione di riarmo delle singole nazioni riuscisse (e ci vogliono anni), l’unità europea non si costruisce per automatismo. Ed è quella che porta a una politica estera comune, alla difesa comune, a politiche sull’immigrazione, l’industria, il fisco, l’energia, il welfare che farebbero bene agli europei. Come la moneta unica non ha fatto gli Stati Uniti d’Europa, non la faranno le armi e non sarà facile convincere gli europei che le armi sono la priorità e non scuole, salute, cura del territorio, occupazione.
La minaccia maggiore viene perciò non dalla Russia, che non ha capacità di fare guerra alla Nato, ma dal consenso interno che traballa. Come reagiranno gli elettori all’erosione in corso dello stato sociale? Sociologi e storici ammoniscono gli economisti (concentrati sul PIL) su quanto può incidere la disgregazione delle società. La rivolta popolare interna (cosiddetto “populismo”) è la vera minaccia di questa Europa incompiuta.



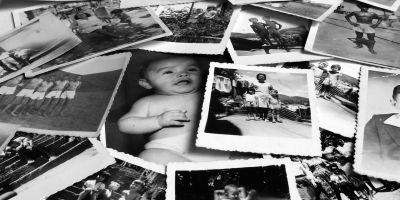













Lascia un commento