Esiste una terza via tra Liberismo e Protezionismo?
Tempo di lettura: 8 minuti
Esiste una terza via tra Liberismo e Protezionismo?
Premetto che i politici che mi piacciono sono quelli che testimoniano con il proprio stile di vita i valori e le idee in cui dicono di credere. Bepe Mujica, presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015, devolse il 90% del suo stipendio ai poveri e Olof Palme, primo ministro svedese (socialdemocratico), che incontrai nel 1985 (un anno prima che fosse ammazzato perché girava senza scorta), andò a pranzo con noi italiani in visita col bus.
Politici che non si fanno strapagare, che servono i propri cittadini e che non rubano. Già questo può far capire perché non mi piace Trump che, alzando e poi abbassando i dazi in pochi giorni, ha usato il potere per arricchire suoi amici (e forse sé stesso).
Ma non sono così sciocco da criticare Trump sulla base di fatti personali, perché mi interessa capire la sua politica. Alcuni analisti avevano spiegato perché l’America fosse in difficoltà, mentre il mainstream li magnificava. Trump sa di queste difficoltà e la sua politica (dai dazi alle guerre in corso) origina dalle debolezze cresciute proprio per via della globalizzazione voluta dagli stessi americani neocon (neoconservatori repubblicani) ma sostenuta pienamente anche dai democratici.
Gli Stati Uniti hanno il più grande deficit commerciale al mondo e il debito pubblico (36.860 miliardi di dollari) è maggiore di quello dell’Italia; il deficit annuo era zero nel 2001, nel 2024 è di 1.830 miliardi. È l’effetto della distruzione della manifattura americana che ha prodotto una disgregazione sociale senza precedenti.
Dall’entrata in vigore del WTO (2001) e poi del NAFTA (2008) gli Stati Uniti hanno perso più di 90mila fabbriche, le disuguaglianze sono salite alle stelle al punto che il 63% degli americani non è in grado di far fronte ad una spesa imprevista di 500 dollari. Le aree deindustrializzate della Rust Belt hanno visto abbassarsi di 4-5 anni la speranza di vita di milioni di ex lavoratori licenziati e i morti per droga sono saliti da 36mila del 2008 a 107mila nel 2023.
A questi dati (occultati per anni), il mainstream magnificava l’andamento del Pil, l’enorme aumento della capitalizzazione di borsa, dei profitti e gli 870 miliardari (record assoluto) raggiunti nel 2024.
Frutti del libero scambio e della globalizzazione a cui molti vogliono tornare prima possibile, facendo il tifo per Wall Street affinché “la realtà e la finanza facciano capire a questo bullo come stanno le cose”.
La globalizzazione ha un aspetto finanziario molto rilevante, che qui non posso approfondire, ma rammento solo che da tempo “guida e condiziona” tutta la manifattura e in Italia il recente risiko bancario ha creato 5 miliardi di plusvalenze a favore dei big della finanza (Delfin eredi Del Vecchio che hanno pagato una miseria di imposta di successione, Caltagirone, Mediobanca, Benetton,…). Non è quindi strano che molti laureati in matematica e fisica lavorino più nella finanza che non nella manifattura.
La globalizzazione ha favorito, oltre ai processi di finanziarizzazione, quelli di delocalizzazione delle manifatture creando filiere (fornitori) lontanissimi su scala mondiale alla ricerca del massimo profitto. I gamberetti pescati e precotti nel Mare del Nord vengono inviati per camion in Marocco per essere sgusciati, poi sono rispediti in Olanda per essere confezionati e infine venduti in Germania dopo 13 giorni e aver compiuto 6.500 km.
Le auto assemblate in Germania hanno telai provenienti dalla Polonia, airbag dal Giappone, sedili dalla Tunisia e chip elettronici da Taiwan, per citare solo alcuni degli oltre 30 fornitori in media che compongono oggi un’auto. Vale per tutto, anche per i nostri jeans il cui cotone è acquistato in Usa, poi filato in India, ma spedito in Cina per essere tagliato su misura con una tintura che arriva dal Brasile e con bottoni metallici dalla Namibia, prima di salpare su container per l’Europa.
È sulla base di questa logica liberista, assunta pienamente anche dall’Europa, che non c’è mai stata una politica industriale, secondo la teoria che il libero mercato è sufficiente da solo a creare sviluppo e benessere. Dopo 25 anni ci si è accorti che non è vero, che a guadagnarci è una ristretta élite contro la maggioranza fatta di famiglie comuni e operai frantumati e sotto pagati.
L’imprenditore Silvagni di Valleverde (e altri marchi italiani) vende scarpe per 30 milioni nel 2024. Ogni anno i ricavi calano e si accentua il declino (come quello di tutta la manifattura in Italia ed Europa e non solo in America), erosa da una concorrenza sleale. Vediamo perché.
Le scarpe che importiamo (per esempio dagli Stati Uniti) vengono realizzate in paesi terzi con manodopera sfruttata e salari inaccettabili, non dico in Europa ma negli stessi paesi terzi, se solo ci fosse un sindacato.
Silvagni propone dazi del 20% se gli Stati Uniti proseguono a fare le scarpe in paesi terzi (Vietnam, Bangladesh, Indonesia) che poi esportano (finto made in Usa) in Europa. Se invece sono fatte in Usa Silvagni dice che è giusto che non ci siano dazi. Le scarpe importate dalla Cina in Italia hanno oggi un dazio del 17% se di materiale sintetico e del 4% con pelle (idem dall’India). Sono dazi giusti e nessuno li ha mai contestati.
L’Unione Europea ha proposto di far pagare 2 euro per ogni pacco low cost on line che arriva in UE (4,6 miliardi di pacchi) spesso dalle piattaforme Temu e Shein della Cina) sotto i 150 euro, per sostenere i costi doganali aggiuntivi e ambientali.
Se fossimo per il libero scambio dovremmo abolirli? E cosa facciamo con le scarpe che ora la Cina delocalizzerà in paesi poveri che non pagano dazi in Italia? Oggi poi col dollaro che si è svalutato sull’euro del 10% le importazioni sono ancora più minacciose.
Per Silvagni sono politiche inaccettabili che lentamente distruggono le nostre manifatture, il nostro saper fare, esattamente come sta avvenendo per la chimica. Chi può dargli torto? Come si vede la questione dazi è un tantino più complessa del si o no ai dazi di Trump e del “w il libero scambio”.
Ce la prendiamo (giustamente) con Eni che ha chiuso il cracking di Marghera, recando un danno incalcolabile alle altre imprese chimiche che usavano quella materia prima e ad altre fabbriche non chimiche. Ma Eni ed altre imprese, controllate dallo stesso Stato italiano, o Hera dai Comuni, seguono la logica neo liberista del massimo profitto.
ENI ha chiuso il cracking di Marghera perché quel ramo produttivo era in deficit. ENI (che ha fatto 6,4 miliardi di utile nel 2024) risponde solo ai suoi azionisti che vogliono un dividendo sempre più alto e se ne infischiano di operai e altre imprese o dell’ambiente.
Certo lo Stato sarebbe potuto intervenire. Ma chi mai si è occupato di politica industriale in Italia da 20 anni o di difesa della nostra manifattura? Forse Bersani e pochi altri. E ciò spiega perché le imprese non investono in Ricerca (in Italia è la più bassa in rapporto al Pil) tra tutti i paesi Ocse.
Ma altrettanto dicasi per gli investimenti. La borsa spinge a fare profitti a breve ed è su questo che sono valutati i Ceo (Adriano Olivetti è lontano). Non stupisce quindi che anche in Europa (e in Italia) la manifattura soffra come in America. Ma là c’è Trump che sta facendo il diavolo a quattro per raddrizzare la barca e, mentre noi lo irridiamo, le nostre barchine manifatturiere affondano.
La manifattura italiana è in calo da 26 mesi consecutivi: chi ne parla? idem del disastro a cui è avviata la nostra gloriosa chimica che ha avuto l’unico premio Nobel in Europa per la chimica proprio a Ferrara con Natta.
Come rafforzare le manifatture, le produzioni reali e creare campioni italiani ed europei che contrastino lo strapotere delle multinazionali americane (e cinesi) in alcuni settori? Più che parlare male di Elon Musk, sarebbe meglio avviare una politica industriale per competere con gli 8mila satelliti di Starlink o con i big tech, ma pare che l’obiettivo sia vincere la guerra con la Russia (sic!).
Nella storia della politica e dell’economia i progressisti si sono sempre battuti per avvicinare i luoghi di produzione ai luoghi di consumo. Prima di tutto per ragioni ambientali. L’attuale sistema economico liberista è tossico e sta seppellendo il pianeta sotto un mare di traffico e di consumi usa e getta.
Chi paga gli sversamenti in mare delle navi porta container? Chi la manutenzione dei mille camion che percorrono ogni giorno la strada da Ostellato a Ferrara e tutte le altre strade del mondo consumate dai tir, che hanno sostituito i magazzini sui piazzali delle fabbriche con un magazzino che viaggia incessantemente 24 ore su 24 sui camion e sulle navi da quando i giapponesi hanno inventato il just in time e l’americano McLean i container?
Ma c’è anche una ragione legata all’occupazione, al saper fare dei popoli e ai salari più alti quando i fornitori sono in casa tua o nei paesi vicini. Il prezzo da pagare è una minore innovazione, ma non sempre l’innovazione si traduce in benessere (lo vediamo con gli smartphone per i giovani) ed è saggio testare le innovazioni per un tempo minimo a dare garanzie ai clienti prima di immetterle sul mercato (oggi le auto sono collaudate dai clienti!), anche se questo comporta meno profitto.
Se ciò avvenisse ci sarebbero prodotti più sicuri, meno disuguaglianze, meno inquinamento, maggiore tenuta delle comunità e più sviluppo umano, specie se si introducono accordi con i paesi di importazione (dove il costo del lavoro è minore) che impongono salari dignitosi (minimi) e congrui al reale valore che i lavoratori producono.
Ma c’è anche un aspetto che riguarda gli squilibri commerciali che aveva già osservato Keynes. Una logica di neo-liberismo porta a puntare tutto sull’export e trascurare la crescita della Domanda interna (Consumi + Investimenti + Spesa Pubblica) e di conseguenza i veri bisogni delle persone, il welfare, che nell’istruzione e sanità non sono solo “costi” ma investimenti e servizi vendibili e formazione di cui abbisognano i nostri giovani e le imprese. Domanda interna significa anche investire nella ricerca e nelle infrastrutture che sostengono la competitività delle imprese e nella sicurezza dei territori e delle persone.
Negli anni ’80 e ’90 si sviluppò un grande movimento mondiale di sinistra e sindacale che lottava contro il libero scambio senza regole, oggi questa cultura è stata assunta dalla destra nazionalista (e il sindacato appoggia Trump), mentre il centro-sinistra par volere acriticamente il libero scambio e fa il tifo per Wall Street, un vero paradosso.
Peraltro disporre di una propria manifattura non è solo funzionale a conservare e sviluppare propri saperi e tecnologie con un’occupazione ben pagata, ma significa anche sicurezza energetica, sanitaria (vedi Covid), agro-alimentare e militare, come ha spiegato il Pentagono a Biden nel 2023 (non avevano più munizioni…).
Un altro protezionismo (differente da quello di Trump) è quindi possibile, o se si vuole, un altro liberismo regolato è possibile rispetto a quello deregolato a cui abbiamo assistito e che molti vorrebbero ripristinare sic et simpliciter.
Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/
Per leggere gli articoli di Andrea Gandini su Periscopio clicca sul nome dell’autore.



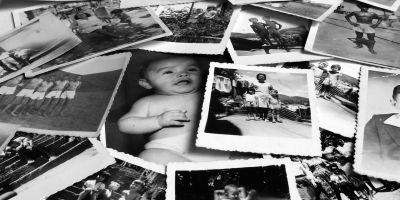






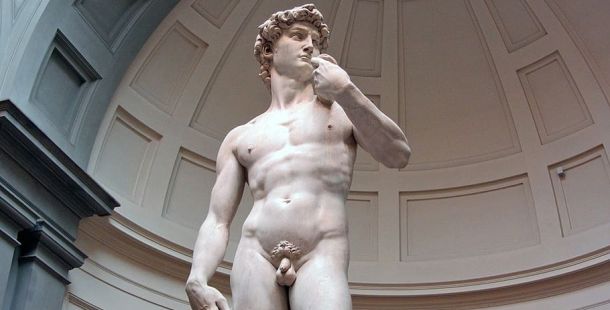



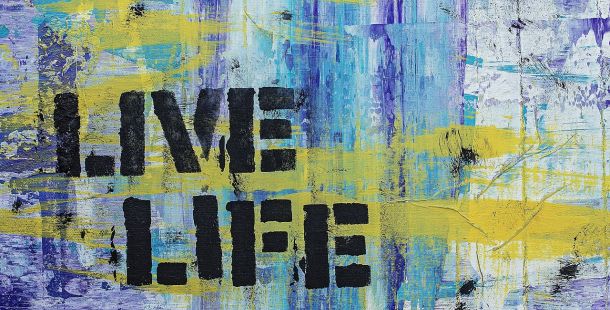


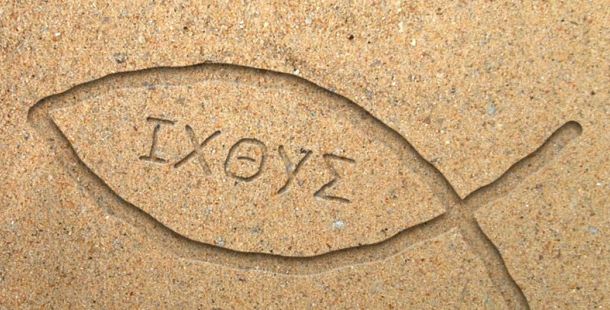
Lascia un commento