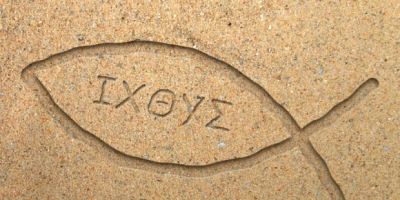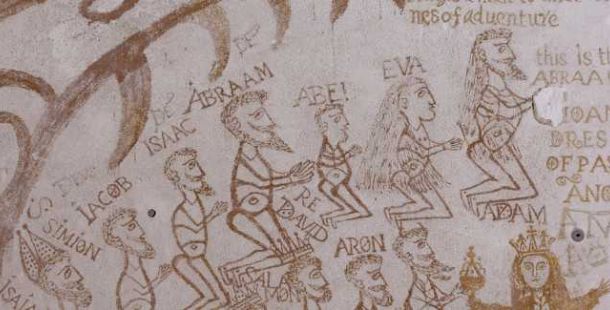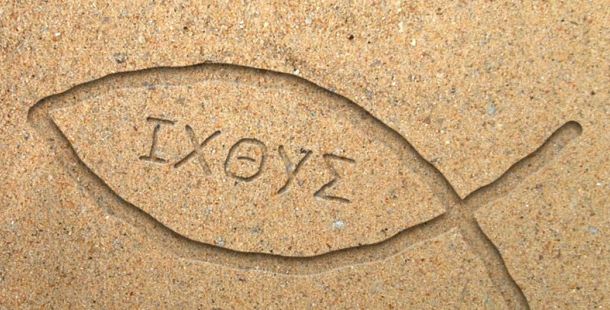Dalle “retrovie” delle missioni alla Chiesa tutta missionaria
Uno studio di Miriam Turrini
La pubblicazione è del 2017, ma mi è capitata tra le mani solo di recente. È il numero 40 dei Quaderni del Centro di documentazione della parrocchia di Santa Francesca Romana (Cedoc).
Un parroco, don Andrea Zerbini, che da anni pubblica studi di storia della chiesa locale, e non solo, e ha creato una biblioteca di decine di migliaia di titoli di scienze religiose e teologia: semplicemente geniale.
Il quaderno numero 40 s’intitola: Dalle “retrovie” delle missioni alla Chiesa tutta missionaria. Il Centro missionario diocesano di Ferrara-Comacchio (1929-2000), scritto da Miriam Turrini.
Alla storica ferrarese, allieva di Paolo Prodi e docente all’Università di Pavia, va il merito di avere fatto parlare le carte del Centro missionario diocesano come, ritengo, nessun altro avrebbe saputo fare.

Un archivio finito nelle mani di don Zerbini, al quale si dovrebbe dire un grazie grande come una casa, per averlo custodito e valorizzato in uno studio che andrebbe prescritto come un farmaco contro la perdita di memoria. Prima o dopo i pasti non importa.
Lo studio è uno spaccato di storia ecclesiale vista dall’angolo di una diocesi, che attraversa sei papi (da Pio XI a Giovanni Paolo II), e cinque vescovi (Ruggero Bovelli, Natale Mosconi, Filippo Franceschi, Luigi Maverna e Carlo Caffarra).
La cavalcata dal 1929 al 2000 in sella al Centro missionario diocesano, è come una sonda locale che ci racconta cambiamenti e passaggi d’epoca, che non è esagerato definire sorprendenti.
Troppo spesso si giudica come minore la storia locale rispetto a quella con la esse maiuscola, ma è un errore. Leggere e diffondere queste pagine sarebbe cosa buona e giusta, non tanto per ricordare con nostalgia i tanti protagonisti, quanto per mettere a fuoco temi, intuizioni e limiti di un percorso pastorale, cui occorrerebbe prestare attenzione perché continuano a parlare al presente e dare attualissime indicazioni sul domani. È la lezione della storia, alla quale anche in ambito ecclesiale si ha l’impressione che non si presti il dovuto ascolto.
Un esempio è, appunto, il significato della parola missione, ossia la chiave di lettura della ricerca di Miriam Turrini e, allo stesso tempo, la cartina tornasole della temperatura storica che cambia ed evolve, attorno a questo tema cruciale per la chiesa.
Ai tempi del vescovo Ruggero Bovelli il linguaggio usato era delle missioni tra gli infedeli, espressione di mentalità, cultura, teologia e pastorale. Al netto delle numerose e meritorie mobilitazioni per raccogliere aiuti in un tempo disastrato da fascismo, guerra, distruzione e miseria, scrive bene Miriam Turrini che il contesto era quello di “propagare la fede progressivamente nell’intero mondo e salvare le anime inserendole nella chiesa attraverso il battesimo” (pag. 261). Era questa, in fondo, l’ansia sottesa all’Opera della Santa Infanzia, articolazione vaticana delle allora Pontificie opere missionarie.
In un mondo essenzialmente diviso tra ‘fedeli e infedeli’, il modello era la conquista alla fede per la diffusione del Regno di Cristo e non è casuale che in questo clima la rivista per la diffusione di idee e iniziative si chiamasse Crociata Missionaria.
Per nomina dell’arcivescovo Natale Mosconi, gli anni ’50 e ’60 vedono l’allora Ufficio missionario diocesano, animato dall’impegno, ma soprattutto dal talento, di don Alberto Dioli, accanto alla vulcanica Gisa Trevisani.
Don Dioli fece a tal punto della missionarietà il principio organizzativo della propria vita, da diventare egli stesso un prete fidei donum (l’enciclica di Pio XII del 1957) e partire come missionario per l’Africa nel 1968. Fatali furono alcune chiavi di volta per comprendere quel passaggio d’epoca, fra cui i pontificati di Giovanni XXIII (dall’enciclica Mater et Magistra del 1961) e Paolo VI, oltre alla maturazione di un’idea di missione più attenta alla crescita delle chiese indigene, la riflessione sul colonialismo, l’emergere delle istanze di giustizia e promozione umana, accanto alla carità e il ritorno sul piano locale in termini di cultura ed educazione alla mondialità.
Missione non era più un semplice dare, portare e civilizzare, fra popoli avanzati e arretrati, ma iniziava a diventare una trama di rapporti nel rispetto delle rispettive originalità e culture.
Soprattutto, con il clima inaugurato dal concilio Vaticano II, iniziava a farsi strada un’idea di chiesa basata sull’ecclesiologia della comunione di chiese. Missione non erano più i soli preti missionari, ma anche l’ingresso dei laici in un compito destinato a essere non un singolo settore della pastorale, ma il modo di essere – l’intima postura – di tutta l’ecclesia, sacramentalmente concepita come locale e, come tale, universale. Una vera e propria accelerazione teologica, destinata a incontrare attriti durante l’episcopato Mosconi.
Se, da un lato, la svolta conciliare chiedeva di tradursi pastoralmente in un rapporto di aiuto innanzitutto tra chiese locali, dall’altro, Mosconi restava culturalmente dentro il modello ecclesiologico centralistico romano. Destinare prioritariamente i fondi raccolti alle Pontificie opere missionarie (PP.OO.MM.) della Santa Sede, significava che la linea economica delle risorse doveva ricalcare quella ecclesiologica, che gerarchicamente scendeva dal papa, ai vescovi, ai preti, fino al gregge dei fedeli.
Occorreva attendere l’ingresso in diocesi del vescovo Filippo Franceschi (1976), perché questo cambio di paradigma fosse riconosciuto e diventasse l’essenza di un intero disegno pastorale. Il respiro dell’Ufficio missionario (poi Centro missionario) entrava così in una sintonia speciale con quello interamente diocesano, segno di una chiesa che si scopriva tutta missionaria.
Nelle pagine di questo capitolo Miriam Turrini è esemplare nel far parlare le carte come di un vero e proprio stato di grazia che, per quanto durato pochi anni (nel 1982 terminò l’episcopato ferrarese di Franceschi), fu per tanti versi irripetibile.
La spinta di quella sintesi si protrasse per anni durante il successivo episcopato di Luigi Maverna (1982-1995), con un singolare coinvolgimento della città ben oltre i confini ecclesiali (Camera di Commercio, istituzioni, banche, scuole), nelle campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi. Un percorso inclusivo che arrivò a inaugurare una fase di collaborazione inedita con le amministrazioni locali – Comune e Provincia – da sempre espressione della cultura politica social-comunista.
Eppure, qualcosa si ruppe rispetto al precedente periodo. Scrive Miriam Turrini: “il progetto ecclesiale organico prospettato durante l’episcopato Franceschi pare sfumare: l’arcivescovo Luigi Maverna intraprende il percorso del sinodo mentre in ambito missionario si afferma la frammentazione delle iniziative” (193).
Quello della frammentarietà di gruppi e iniziative in campo missionario è un problema che riaffiora ciclicamente nella storia ecclesiale, con limiti d’impostazione nazionale oltre alle peculiarità locali.
Con Mosconi gli attriti nascono perché la sintesi fatica a trovarsi in un paradigma ecclesiologico di tipo gerarchico, sospinto ben oltre il concilio. Sintesi, invece, che emerge durante gli anni di Franceschi, in cui ogni frammento pare trovare posto in un disegno.
Perché allora questa spinta centrifuga torna a fare problema durante Maverna, nonostante un modello pastorale imperniato sul sinodo (camminare insieme)? Tutta colpa di particolarismi e mancanza di senso ecclesiale?
Forse non basta dire sinodo perché tutto vada a posto e in equilibrio e il dubbio pare trovare conferma nelle parole di Turrini: “La conclusione dell’episcopato Maverna (…) non favorì lo sviluppo di una chiesa che operava attraverso piani pastorali condivisi” (229).
Chapeau, dunque a Miriam Turrini e don Andrea Zerbini per una ricerca assolutamente da leggere, con l’auspicio che l’intera chiesa locale sappia fare tesoro di queste pagine, come di quella miniera di sapere ed esperienze a disposizione nei quaderni del Cedoc.