A maggio, più di 7.000 migranti sono sbarcati sulle coste nazionali, portando l’ammontare complessivo di arrivi via mare, da gennaio 2025, a circa 24 mila unità. Nello stesso periodo, nel centro albanese di Gjadër, il totale di migranti ospitati ha raggiunto le 100 persone, con 32 rimpatri, secondo le più recenti affermazioni del ministro degli Interni (il quale ha parimenti ammesso che più numerosi sono stati i rientri in Italia dall’Albania, avvenuti in 36 casi, quale conseguenza delle decisioni della magistratura). Il tutto in un contesto più ampio, dove alle quasi 160 mila richieste di asilo presentate presso le Commissioni territoriali nel 2024 hanno fatto da contraltare soli 5.414 rimpatri dall’Italia.
Appare dunque evidente come l’attenzione politica e mediatica che in questi mesi ha catalizzato il Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, per quanto giustificata dalle serie problematiche di civiltà giuridica che solleva (affrontate anche sulle pagine online di questa rivista), abbia principalmente operato quale strumento di “distrazione di massa”, avvalorando l’idea che i muri si possano effettivamente costruire, che i porti si possano veramente chiudere e che i non-cittadini si possano efficacemente allontanare in massa, essendo questa l’unica e la migliore soluzione perseguibile (in tal senso va anche il cosiddetto Remigration summit tenutosi il 17 maggio in provincia di Varese).
Così facendo, però, si decide di ignorare l’incontrovertibile trasformazione dell’Italia da terra di emigrazione a terra di immigrazione, una delle cui priorità dovrebbe essere quella di confrontarsi in modo compiuto con l’oramai stabile porzione migrante della propria popolazione, nell’ottica di implementare – più che politiche di deterrenza – adeguati percorsi di accoglienza e integrazione che esaltino le potenzialità sociali ed economiche dei non-cittadini.
“Siamo in presenza di un malato in gravi condizioni, per quanto riguarda sia i diritti dei suoi fruitori immediati (i migranti), sia i pubblici interessi sottesi (e, quindi, il benessere dei fruitori indiretti, ossia la collettività tutta)”
Ma qual è l’attuale stato di salute del sistema di accoglienza e integrazione in Italia? Limitando l’attenzione ai meccanismi rivolti ai richiedenti e titolari del diritto d’asilo – per quanto, ed è sempre bene sottolinearlo, rappresentino solo una ridotta percentuale della ben più vasta popolazione di non-cittadini presenti nei confini italiani – siamo in presenza di un malato in gravi condizioni, per quanto riguarda sia i diritti dei suoi fruitori immediati (i migranti stessi), sia i pubblici interessi sottesi (e, quindi, il benessere dei fruitori indiretti, ossia la collettività tutta).
Ed ecco, appunto, la distrazione di massa, laddove l’attenzione di tutti è stata attirata altrove, in Albania, quando le vere trasformazioni sono avvenute in Italia. Il decreto Cutro del 2023 ha infatti riportato le lancette dell’accoglienza al 2018, riproponendo (meglio, amplificando) le scelte compiute con il “decreto sicurezza Salvini”, il cui impatto sulla sorte dei richiedenti asilo presenti nel territorio italiano era stato però oggetto di una significativa risonanza mediatica, rivelatasi principale forza motrice del suo successivo superamento nel 2020.
In estrema sintesi, il modello tradizionale di accoglienza e integrazione in Italia era quello di un meccanismo progressivo. Si andava dall’erogazione delle prime indispensabili cure negli hotspot, per poi passare attraverso destinazioni temporanee quali i Centri di prima accoglienza (Cpa) e i Centri di accoglienza straordinaria (Cas) governativi, il cui approccio “quantitativo” – in termini sia di capacità ricettive, sia di servizi erogati agli individui – risultava ammissibile alla luce della loro natura di soluzioni di breve periodo.
Obiettivo ultimo era infatti l’avvio dei percorsi di inclusione “qualitativi” in seno alle comunità locali, grazie al Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) gestito a livello comunale.
Oggi, invece, l’accesso al Sai è riservato ai soli titolari del diritto d’asilo, ai minori stranieri non accompagnati e, “possibilmente” (così il decreto Cutro), ai soggetti in condizione di vulnerabilità. Invece, i richiedenti protezione (cioè coloro la cui domanda d’asilo è pendente, davanti all’amministrazione o davanti ai giudici, con tempistiche che possono protrarsi anche per alcuni anni) restano confinati nei Cpa e nei Cas, i quali perdono il ruolo di “aree di transito” per divenire luoghi ordinari di lunga permanenza dei migranti umanitari giunti in Italia o, meglio, “non luoghi” dell’accoglienza.
Si tratta infatti di strutture destinate a ospitare anche centinaia di richiedenti protezione, collocate sovente nelle periferie cittadine, ai margini delle società, in cui l’allontanamento dai percorsi di inclusione non è solo spaziale, ma è confermato da una riduzione dei servizi offerti, limitati a prestazioni minime, essendo stati invece eliminati l’assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.
La condizione è ancora peggiore nei Casp, i Centri di accoglienza straordinari provvisori, introdotti ex novo dal decreto Cutro, la cui natura “iper-eccezionale” non solo conferma la “normalizzazione” dei Centri di accoglienza straordinari, ma legittima l’ulteriore riduzione dei servizi al loro interno, con l’eliminazione anche dell’assistenza sociale, per quanto le ricerche condotte dimostrino tutto fuorché la brevità dello stanziamento degli individui in queste strutture.
Va detto che anche precedentemente al decreto Cutro il sistema Sai si era dimostrato incapace di assorbire integralmente la richiesta di accoglienza nazionale, con percentuali elevate di migranti che permanevano nei Cpa e nei Cas, ma ora il cambio di indirizzo è netto: se prima rimaneva viva la tensione legislativa e politica verso il modello dell’accoglienza “qualitativa”, oggi tale proposito viene meno, con l’accoglienza a livello comunale che diventa ipotesi residuale ed eventuale piuttosto che obiettivo ultimo del sistema.
Né può considerarsi notizia positiva l’aumento della spesa giornaliera per migrante all’interno di Cpa, Cas e Casp disposta con il decreto ministeriale del 4 marzo 2024: è infatti un aumento “apparente”, causato essenzialmente dall’adeguamento agli indici Istat delle spese fisse (per esempio, i costi di affitto delle strutture), mentre a ridursi sono le risorse destinate al personale dei centri, laddove l’assistenza agli individui non può che essere un’attività in cui l’apporto di operatori qualificati gioca un ruolo essenziale.
D’altronde, ai pericoli per i diritti dei singoli si assommano anche i rischi per gli interessi pubblici sottesi all’implementazione di corretti meccanismi di accoglienza e inclusione. Oltre al fatto che l’integrazione sociale è un percorso complesso, le cui chance di successo aumentano con l’aumentare della tempestività del suo avvio (così da confliggere con lo “stipamento” in centri isolati da tutto e da tutti), l’approccio tracciato dal decreto Cutro mette a repentaglio l’attuazione di principi quali il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la trasparenza dell’agire delle amministrazioni e l’adeguato coinvolgimento dei vari livelli di governo. Elementi che dovrebbero invece animare l’azione della macchina amministrativa, anche in materia migratoria.
L’avere normalizzato quella che avrebbe dovuto essere una forma di gestione straordinaria dell’accoglienza, infatti, consente ora un più stabile ricorso a procedure emergenziali per la realizzazione e l’affidamento in gestione a soggetti privati dei centri di accoglienza governativa.
In altre parole, se prima del 2023 la costruzione delle strutture e l’appalto dei servizi, in deroga alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, erano ammessi alla luce della straordinarietà del ricorso a tali centri di accoglienza, avere oggi trasformato i Cas e i Casp in soluzioni stabili, senza però escludere questa facoltà di deroga, ha normalizzato la possibilità per il ministero dell’Interno di aggirare le regole preposte all’efficiente e trasparente spesa delle risorse erariali. Regole da seguirsi ogni qualvolta i soggetti pubblici si rivolgono al mercato per acquistare beni, lavori o servizi.
Ancora, il ruolo preminente ora riconosciuto ai centri governativi opera in danno delle strutture affidate alle amministrazioni comunali, con il Sai che, come detto, perde la sua natura di momento apicale dei percorsi di inclusione, comportando così il sacrificio delle realtà locali – veri contesti in cui si verifica l’integrazione –, le quali non sono più attrici, ma mere destinatarie passive del sistema di accoglienza e delle sue innegabili esternalità negative, laddove mal gestito.
Forte è il messaggio simbolico di questo intervento normativo, che si spinge oltre alla “sola” criminalizzazione del fenomeno migratorio, riconducendolo a una realtà capace di minare l’integrità della nazione, innanzi a cui reagire militarmente
A conclusione del quadro, va poi sottolineato come hotspot, Cpa, Cas e Casp siano stati inseriti nell’elenco delle “opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale”… assieme a basi navali, caserme, depositi di munizioni e basi missilistiche.
Da un lato, questo amplia ulteriormente l’accentramento della gestione, stante il coinvolgimento anche del ministero della Difesa, oltre che i margini di derogabilità dell’ordinaria disciplina appalti, considerata l’emergenzialità intrinseca a tali categorie di strutture.
Dall’altro, forte è il messaggio simbolico di questo intervento normativo, che si spinge oltre alla “sola” criminalizzazione del fenomeno migratorio, riconducendolo a una realtà capace di minare l’integrità della nazione, innanzi a cui reagire “militarmente”, come in presenza di un aggressore esterno.
Tale scelta diventa così pietra angolare del nuovo approccio all’immigrazione nel nostro Paese, come ci ricordano le parole di Zygmunt Baumann. La politica del “nemico”, infatti, «aiuta a tacitare preventivamente i rimorsi di coscienza che ci assalgono, come spettatori, alla vista dei bersagli sofferenti di quella [stessa] politica […]. Una volta riclassificati dall’opinione pubblica come presunti terroristi, i migranti si ritrovano oltre la sfera della responsabilità morale, irraggiungibili a quest’ultima; e soprattutto, al di fuori dello spazio della compassione e dell’istinto di cura» (cfr. Stranieri alle porte, Laterza, 2016).
Solo in questo modo, d’altronde, pare possibile rivolgere lo sguardo altrove e accettare in silenzio lo svuotamento dell’accoglienza in Italia.
Luca Galli
è ricercatore di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università di Milano. I suoi temi di ricerca riguardano principalmente l’amministrazione condivisa e il diritto amministrativo delle migrazioni.
In copertina: centro-accoglienza per minori non accompagnati (https://www.aibi.it/ita/accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati1800-famiglie-in-italia-pronte-ad-aprire-le-porte-di-casa-ma-ferme-al-palo-perche/)


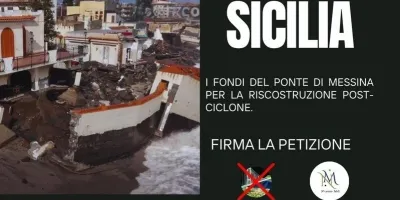















Lascia un commento