La rivolta del Lucio
Tempo di lettura: 9 minuti
La rivolta del Lucio
“Tagliatemi le palle ma gli occhi, quelli, lasciatemeli stare!” urlava così ai pestiferi ragazzotti che, in quel natale, saettavano petardi in Piazza Ducale. Gli si poteva rancar via tutto, sì. Ma non gli occhi. Quegli stessi che, in poco più di una decina di anni, era quasi avessero compiuto la transumanza dei secoli secolorum. Dal mondo contadino e del fine mestiere di bottega, al turbine incessante del prodotto industriale. Dal pasto condiviso al cannibalismo di massa. Perché così lui si sentiva; questo, la vita gli aveva dato in sorte: d’essere ingoiato, sbranato. Gli restavano gli occhi, i suoi, come malconci fanali che pure seguitavano a rischiarare una terra di nebbie. C’è chi si sarebbe senz’altro fermato. Lui no. Su quella strada, il Lucio Mastronardi, voleva andarci fino in fondo. L’ha fatto.
Qualche giorno prima, come spesso in quei tempi accadeva, faceva un freddo bestia. La sera di quel giorno, la sala era strapiena. Età media, suppergiù vent’anni. Non era affatto una novità. In quegli anni, i settanta del secolo scorso, spesso capitava di trovarsi insieme per cercar di cavare il ragno fuori dal buco, capir l’andazzo del mondo. Si era tutti lì, dunque, ad accogliere il verbo di taluni caporioni, bell’apposta venuti giù da Milano: con in testa nientemeno che la Rivolusiòn. In ogni dove, la si era sparsa la voce. Da tutta la Lomellina, da Novara, dall’Oltrepo, in centinaia l’avevano raccolta. La sala ribolliva di umori sanguigni, voci, risate, bave di fumo come segnali che, tra quelle mura, tutti ci si era dati appuntamento con la storia. Quella che conta.
Barbe nere, larghi camicioni, anfibi, clark, eskimo e gonne a quadri, lì tutti insieme ci si ammucchia, ci si prude, ci si scalda. Si è davvero una caterva. Si è, come dire e non per scherzo, all’avanguardia; l’avanguardia delle sterminate città operaie, una sull’altra, in appena un pugno di anni, in fretta e furia e con mirabolante ottimismo, tirate verso il cielo. Sì. Le città di quella classe operaia che, senza dubbio, una via al Comunismo, prima o poi, la troverà. Ed è proprio di questo che, quella sera, si andrà a parlare. Proprio lì, a Vigevano. Prima fabbrica di scarpe. Nel 1856. Regno Sabaudo. Ora, capitale della scarpa italiana. Il che vuol dire del mondo intero. Vigevano che, nel dopoguerra, in anni venti, passa, da poco più di quarantamila anime, a sfiorare i settantamila. Sono le “tribù fameliche”, come, con cruda ironia, le appella il Giorgio Bocca, qui rabattate dal Polesine, dai picchi di Calabria, dalla Sicilia rurale, ma anche dai paesini lomellini, che si vanno via via a spopolare. Le si accampa perlopiù nei fetidi rioni di un centro antico, che cade a tòcch. Ai più fortunati, sono invece destinati duu locali e un balconcino in case sghembe, tirate su in fretta e furia, in questa o in quell’altra riva della città. Vigevano: settantamila anime…novantacinquemila para da scarp fatte in appena un giorno! Più tacchi che teste. Vigevano, sì. La Stalingrado di Lomellina. Che assicura al Partito Comunista il quarantasette per cento dei voti. Un collegio strasicuro, per il foresto Armando Cossutta, il sovietico di ferro, che pochi qui han mai visto in giro, ma a cui, le cosiddette masse operaie, tutte obbediscono nel voto.
La capitale del boom economico è per questo un terra fertile e attrattiva. Per chi è arrabbiato. Per i sanculotti di varia e composita natura. Per quelli che son fuori e a sinistra del Partito. Ossia, i rivoluzionari del Mao e Che Guevara. Carta che urla: Lotta Continua, il Manifesto, Il quotidiano dei Lavoratori. Ed è appunto perché la lotta deve ad ogni costi continuare, produrre i suoi frutti che, quella sera, ci si ritrova tutti alla Sala Leoni, storico approdo della politica locale.
Inizia l’assemblea. Con grande sorpresa dei caporioni milanesi, la sala ammorba di un pestifero tanfo. Cos’è? E il modernissimo tenacio. Appena qualche anno prima, così puzzolente, lo conosceva nessuno. Ora, a Vigevano, ci fan tutti i conti. Col tenacio, la colla industriale che vien dai crucchi, se non addirittura dagli americani, si impataccano a perfezione le suole delle scarpe. Respirarlo a grandi dosi, è peggio che attaccarsi a un tubo di scappamento. Di quei tempi, se ne usa a tonnellate. In molti, ci lasceranno la pelle. Pur col freddo, quindi, si sbarattano le finestre. Nessun problema. Ci si scalda a suon di parole. Le parole sono vespe impazzite che ronzano tra gonne, jeans, chiome bisunte. La sala è una nave che, alla deriva della Storia, colta da ormoni di bufera, barcolla, si sfalda, ribolle di furenti ammutinati.
In mezzo a cotanta ciurma, c’è un uomo, un omino che, così vederlo, nessuno gli darebbe due lire. E’ piscinin, mingherlino; uno dietro l’altra, nervoso, con l’aria di chi è lì per puro caso, fuma sigarette nazionali senza filtro. Non è giovane, non è vecchio, è sempre lui. Ci ha su un paltorin che dà sul liso; un para di scarpe con la suola un po’ conciata dalle lunghe vasche quotidiane sotto i portici della piazza. Puzza un po’. Di Negroni. Il suo amaro preferito. Una sera, in un abbaino vigevanese, una di quelle sere tra amici stretti, si dice se ne sia bevuta un’intera bottiglia. Sono voci che corrono.

E’ lui. Il Lucio. Il Lucio Mastronardi. Di mestee fa da sempre il maestar elementar. Oltre a quello, da qualche tempo, gli è venuto il birlo dello scrittore. Mica uno di poco conto. Il Vittorini lo ha preso sotto braccio; il Calvino ne è stato folgorato. E’ così che il suo romanzo, Il maestro di Vigevano, dopo aver venduto un fracco, si è ritrovato finalista allo Strega. E’ così che a Vigevano è quindi sbarcato l’Alberto Sordi, in compagnia del Petri regista. Di quel romanzo han fatto un film. Lo han visto in tanti. Nel giro di poco, il Lucio Mastronardi diventa famoso. Un suo amico, capitato per caso in quel di Nuova York, tornato a Vigevano fa restar tutti a bocca aperta. Giura di aver visto in bella mostra, in una libreria vicino alla fift aveniu, il libro del maestar… tradotto nientemeno che in americano! E’ vero? Non è vero? Non importa. Basta questo per capir quanto, nella Vigevano capitale del boom, sul Lucio, se ne contano davvero di tutti i colori. Di lui dicono sia un originale, di sinistra intendiamoci…ma del tutto irregolare. Questi, son gli affetti degli amici. Gli altri, gli altri tutti, quando lo vedono girano dall’altra parte, gli danno a stretta voce del matt, del foeura ad testa, di quello che…si sa mai quello che fa e quello che dice. In molti, non gli perdonano di aver fatto fare a Vigevano una figura di cacca. Perché? Perché nel suo romanzo, in quel film, ci si son visti…
Inizia l’assemblea. Vagonate di parole. Invettive. Direttive. La Rivoluzione scalpita, sfugge, d’imperio la si riacchiappa. Gli animi si scaldano eccome. La verve è certo a un buon livello. Parla questo, parla quello, parlan tutti. Ad un tratto, il Lucio, alza la sghemba manina. Da quel corpo mingherlino, prorompe una voce alta, decisa, che chiede gli sia data la sacrosanta parola. Anche lui, vuol dire la sua. Qualcuno storge il naso, altri si toccano le balle. Già…col Lucio, si sa mai. Tra i più buoni, tra gli amici, c’è chi ridacchia sotto i baffi. A tutti vien da pensare: “toh…e adesso cosa dice?”.
S’impone il silenzio. Parla lui…
“Scusate, compagni, volevo solo dire una cosa. Solo una e poi bòn,” sibila sbìrolo. “Me mi sa che, tutti questi vostri discorsi, son davvero inutili…”
Nella sala, cala un gelo che sa di Siberia. I caporioni milanesi (ma chi è questo qua?..) sgranano gli occhi, qua e là cigola qualche risatina soffocata.
“Datemi un po’ retta. Il Comunismo…” sfiata il Lucio “non ci sarà mai! Dico mai!..E volete sapere il perché?”
Alza il braccio. Ingrossa il petto. Alla Lenin, alla Petrolini…il Lucio ha il senso della teatralità storica.
“Perché gli operai vogliono diventare come i borghesi!!!Ecco perché!”
Apriti cielo! Pernacchie, scemo scemo, fischi a iosa. Lucio si incazza. Sommerso dal bailamme, blatera, urla. Vorrebbe ancora parlare, tentar di spiegare. Ma va là! Mai domo, attacca a questionare, punta il dito. Giusto allora, anime amiche lo raccattano sottobraccio; gli spiegano che davvero non è il caso, che è meglio se va foeura di ball. Così fa…
C’è stato un momento in cui, questo nostro strano paese, ha avuto in sorte una autentica genia di profeti. Son spuntati tra tonnellate di carabattole e cianfrusaglie; tra i feticci di quell’insorgenza produttiva, quel delirio di ricchezza a tutti i costi, il definitivo passo di cambio della Storia, che va sotto il nome di boom industriale. Lucio Mastronardi ne ha svelato l’altra faccia, il ghigno scuro, quello stesso che, in quegli anni, ha fatto di Vigevano il laboratorio sociale dell’ipotesi ultima: In barba a tutto e tutti, conquistare il paradiso del consumo! Lo ha fatto non da vanaglorioso intellettuale, che scatarra nel piatto dove, il più delle volte, lui stesso mangia. No. Il Lucio, dentro il piatto, era l’avanzo. Tra gli avanzi ha trovato i suoi eroi al contrario…eroi per il semplice fatto di incarnare appieno tutta la nullità dei loro tempi. Ecco allora sortir dalla sua penna il maestro Mombelli, il Sala che fa lo scarparo, il meridionale impiegato del fisco, tutti condannati ad una vita da cronici infelici; tutti miseri, tutti vinti, banalissime pietruzze della gran macina che ogni cosa travolge. Nessuna grazia, nessun fronzolo, nessun adornamento. Per dir delle loro vite, il Lucio se ne sbatte del neorealismo, della critica sociale, così in voga di quei tempi. La sua è una scrittura spiazzante, che par abbia la tosse del catarro quello secco di chi fuma tanfo e fiele. E’ una scrittura senza alcuna invettiva; di uno che per caso traversa una strada, vede, sputa, poi svolta di fretta il cantone.
Come a dire che nulla resta da fare. Che il Mombelli, il Sala, tutta la compagnia cantante, una volta apparsi in scena, devono per forza di cose canticchiar la canzonetta che altri, per loro, hanno scritto e musicato. Non è una canzone d’autore. E’ un coro solenne. Un peana indistinto in onore del dio. Quale dio? Il dio che c’è adesso. Che veglia sui destini del cittadino ignoto, della formica che formicola nell’enorme formicaio. E’ la massa che puzza come un brodo andato a male. Il dito, la penna, del Lucio, indica nessun luogo. Come un cronista di nera si limita ai nomi, ai fatti. C’è dell’altro? C’è una via d’uscita, un fare diverso, un’estrema ridotta che sa di salvezza? No. Non più. Qui giunti; qui finisce. Come a dire che tutto, l’ammasso delle idee, delle parole vuote e vane, tutto, qui dove si è capitati, è oramai roba da averci e da comprare. L’è una storia de danee.
Tutto questo ha visto il Lucio. Al pari di un Grosz, ha dipinto, nel grottesco, il collettivo impazzimento. Nessuno, al pari di Mastronardi ne ha colto fino in fondo la tragedia. Ci han provato il Bianciardi, il Calvino, il Piovene. Lo ha cantato il Pasolini. Nessuno, con pari, disarmante, ferocia.
L’identica ferocia che, da parte a parte, ha infilzato la sua vita. Fino al punto di non capirci più nulla. Di farla per sempre finita. Perché, a un certo punto, a furia di sbatter la testa di qui e di là, a questo ha pensato il Lucio. Che un bel dì tenta di ammazzarsi buttandosi giù dal balcone di casa. Un gesto tragico, senza dubbio. Che assume, come di chi vive nei suoi romanzi, i contorni della tragica farsa. Quel giorno, giù dal balcone, invece di sfracellarsi sull’asfalto, il Lucio centra in pieno il tettuccio decappottabile di un’utilitaria. Lo sfonda. Si rompe qua e là. E’ vivo. Dirà gli è andata male. Nel frattempo, litiga di brutto con il suo direttore scolastico. Lascia indietro la scuola. Va a lavorare alla biblioteca Sormani di Milano. Non sopporta la città. Lascia anche Milano. Torna a Vigevano. Litiga ancora; per questo, condannato, passa alcuni giorni in cella a San Vittore. Esce. Va in pensione. Crede di avercela fatta. Di poter finalmente scrivere in pace. Ma va là. Dai che fuma come un turco, di lì a poco respira più. Sta male. La visita a Pavia è perentoria: ha un brutto cancro.
L’ultima volta che lo vedono vivo, cammina come un matto avanti indree sul ponte di quel Ticino di cui tanto, nei suoi romanzi, ha parlato. Lo cercano per giorni. Poi, lo trova un pescatore. Bon. Ciao Lucio. Fin de la storia.
In Copertina: Lucio Mastronardi – sta in “Lucio Mastronardi ed il romanzo del boom”, Latina Città Aperta, 16.04.2021
Per leggere gli altri racconti, poesie e articoli di Luigi Balocchi clicca sul nome dell’autore









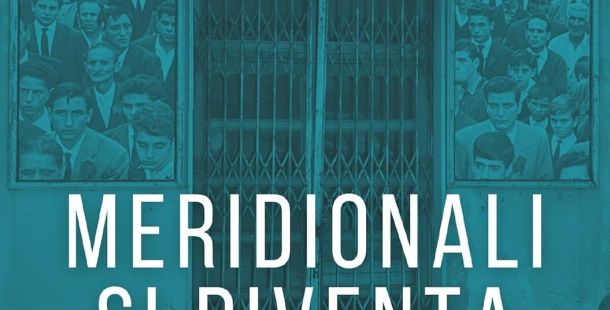
Veramente un brano bellissimo, sospeso tra la storia e il racconto. Grazie Luigi.