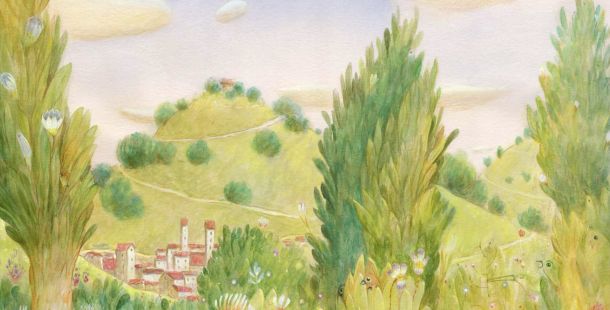Alle origini dell’età ibrida
I ragazzi degli anni ottanta sono cresciuti con il Commodore 64. In quegli anni, tra gli adulti, molti guardavano i computer con sgomento. Un buon numero di medici si sentivano richiedere certificati che giustificassero l’esonero dall’uso, tanto era il terrore che tra molte impiegate i nuovi strumenti di lavoro suscitavano. Tra gli esperti dilagavano le discussioni circa la possibilità che l’intelligenza artificiale (termine che i più usavano in termini evocativi) fagocitasse, annullandole, le capacità del pensiero umano. Per noi erano, semplicemente, un modo più veloce per scrivere la tesi.
Non ricordo quando ho avuto il mio primo computer, ricordo che è stato amore a prima vista. Anche se occupava molto spazio e faceva un po’ di rumore. Anche se bisognava conoscere le funzioni dei tasti e talvolta digitarne tre alla volta per produrre l’operazione voluta. Il ricordo più dolce era che potevo scrivere con una mano e con l’altra “giocare” con la mia bambina. Poi sono arrivati i floppy, che nome delizioso! Li ho buttati via qualche mese fa, accettando – non senza fatica – l’idea che la mia memoria andasse persa. Anche questa è una conquista nel tempo dell’archiviazione universale.
L’età ibrida è il titolo di un libro recente di A. Khanna e P. Khanna (Codice), il cui sottotitolo è Il potere della tecnologia nello scenario globale. L’argomentazione sbarazza definitivamente qualunque illusione che il mondo possa essere interpretato con le categorie a cui eravamo abituati. Soprattutto, toglie di mezzo l’idea che i nuovi media siano semplicemente strumenti da utilizzare. Le tecnologie sono in realtà un linguaggio che crea un ambiente, un mondo da abitare. Non si tratta di discutere se questo mondo ci piace di più o di meno di quello che abitavamo in passato – la cosa è del tutto irrilevante – si tratta di comprendere quali implicazioni ha questo scenario per le persone, le organizzazioni, le imprese. Un’era, fatta di oggetti, merci, pratiche è finita, un’altra iniziata è in rapidissima evoluzione.
La tecnologia crea e distrugge. La tecnologia è generativa, vale a dire è in grado di generare valore, ma distrugge lavoro; diffonde opportunità, ma è spietata con coloro che ne restano fuori; crea paradossi, ad esempio possiamo impiegare meno tempo da Bologna a Parigi che da Ferrara a Parma; semplifica e complica la vita allo stesso tempo perché genera ridondanza.
Internet moltiplica il tempo e lo fagocita, il tempo digitale non equivale al tempo cronologico, è multitasking e quindi variabile: possiamo fare più cose in contemporanea e vivere più tempi contestualmente. Mentre i tempi si sovrappongono, anche i valori si mescolano e non si dispongono su assi contrapposti. L’ibridazione il tratto di questo tempo.
Sapranno sopravvivere le imprese e le organizzazioni in grado di offrire valore, le altre sono destinate all’estinzione. Sapranno sfruttare le opportunità le persone dotate di capitale culturale e di capacità riflessive. La tecnologia non si riferisce solo a macchine o ad oggetti, ma soprattutto a processi, abilità, comportamenti, presuppone processi di appropriazione e adattabilità.
La tecknick – che gli autori del libro citato definiscono il quoziente tecnologico di una civiltà – è dunque una qualità che tutti dovremmo sforzarci di curare, singoli individui, imprese, comunità, città e nazioni. Conoscenza e innovazione potranno produrre relazioni virtuose, salvaguardando spazi di lentezza per pensare.