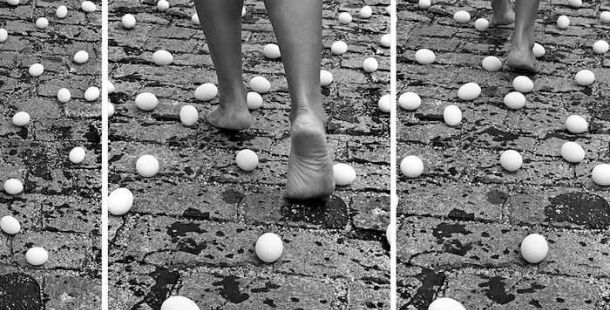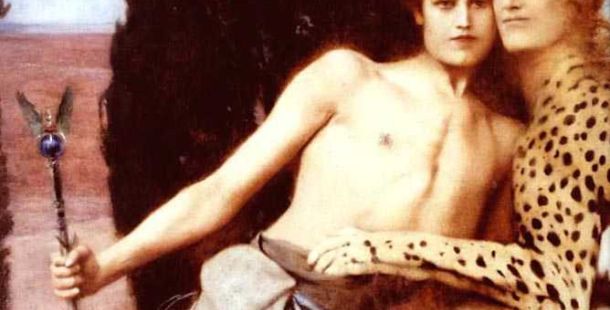LA BELLEZZA CI SALVERÀ
La luce dell’infanzia nell’arte: origini di un universo sconosciuto
L’interesse crescente degli studi storici per la storia dell’infanzia ha come punto di riferimento il fondamentale testo di Philippe Ariès, “Padri e figli nell’Europa medievale e moderna”, pubblicato a Parigi nel 1960. Si tratta della più interessante e vasta indagine sulla storia dell’infanzia dal medioevo alla contemporaneità, concentrata sull’evoluzione del concetto stesso di infanzia, concetto che aveva svolto un ruolo centrale nella costruzione della famiglia moderna.
Non a caso, Ariès parla di sentimento dell’infanzia e va a ricercarne i mutamenti nelle raffigurazioni artistiche, nell’abbigliamento, nei giochi ovvero nelle fonti dell’esperienza della vita infantile e soprattutto nel mondo dell’istruzione scolastica, giungendo a sostenere che proprio i cambiamenti delle idee sull’infanzia avessero radicalmente modificato l’esperienza del bambino.
La famiglia moderna con le sue dinamiche aperte alle esigenze dei bambini e alla loro affettività è, secondo Ariès, fenomeno recente da individuare tra il XVII e il XVIII secolo: riteneva quindi che ci fosse stata nel tempo un’evoluzione significativa degli atteggiamenti e dei sentimenti nei confronti dell’infanzia. Secondo lo storico francese, infatti, nella società medievale l’interesse per il bambino non era strutturato e su questo argomento negli anni ottanta del secolo scorso molti studi correggeranno il tiro, evidenziando come intuì Linda Pollock (1983) un nuovo approccio al problema, basato sulla continuità e non sul cambiamento. Anche il mondo antico e il medioevo confermano, per la studiosa, un interesse più concreto, pur nella limitatezza del bambino inteso come essere incompleto, le cui capacità non erano neppure da porre in relazione con quelle dell’adulto, tanto che quando le fonti antiche descrivono i bambini è per sottolinearne innanzitutto la loro debolezza fisica e mentale e per sottometterli ai doveri e alle responsabilità dei genitori.
Una documentazione certa di riconoscimento di status per i bambini, emerge chiaramente con l’avvento del Cristianesimo.
E’ Gesù che per primo mostra un inedito sentimento per l’infanzia e si rivolge ai bambini con affettuosa attenzione: “E gli presentavano dei bambini perché li toccasse; ma i discepoli sgridarono. Visto ciò Gesù si sdegnò e disse loro – lasciate che i bambini vengano a me, non li ostacolate, infatti a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Amen dico a voi, chiunque non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto – E avendoli abbracciati li benediceva ponendo le mani su di loro”(Marco 9,31). Gesù insiste varie volte sull’accoglienza che si deve dare ai piccoli: “Chi accoglie uno di questi bambini nel nome mio, accoglie me”(Marco 9,37). “Chi dà un bicchiere di acqua ad uno di questi piccoli, non perderà la mia ricompensa (Matteo 10,42). Nel giudizio finale i giusti saranno ricevuti per ciò che diedero da mangiare a uno di questi più piccoli” (Matteo 25,40).
Nei Vangeli l’espressione “piccoli” a volte indica bambino, altre volte indica “gli esclusi”. Infatti al tempo di Gesù e della scrittura dei vangeli i bambini facevano parte degli esclusi della società e quindi Gesù, mettendosi dalla parte dei più piccoli, sceglieva gli indifesi e quelli che non avevano diritti.
Nell’accogliere i bambini, Gesù esprime parole dure su coloro che causano scandalo ai fanciulli, li tocca quando le madri si avvicinano a Lui per chiedergli una benedizione e si identifica con i bambini (anche se gli apostoli si oppongono poiché toccare gli esclusi significa contrarre impurezza), dicendo “chi raccoglie un bambino accoglie me” (Marco 9,37); “tutto ciò che farete a uno di questi piccoli, lo avrete fatto a me (Matteo 25,40).
1. CONTINUA

Sostieni periscopio!
Anna Maria Baraldi Fioravanti
I commenti sono chiusi.