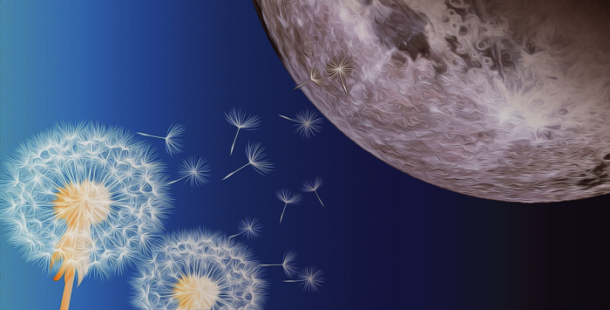La voce favolosa di Leopardi
Della voce (e non solo) si fa spesso un uso sguaiato, come se il pensiero, la riflessione non dovessero precederla e accompagnarla. Ecco dunque che vale riflettere con una velocissima scheda sul modo nel quale voce e vocalità appaiono e si manifestano nel nostro più grande autore moderno, nato e scomparso nella seconda metà di un lontano mese di giugno.
Chi si stupisse perché la parola voce appare nelle migliaia di pagine dello Zibaldone soprattutto nel senso di rimando lessicografico, voce da dizionario per studiare l’etimologia delle parole e ricostruirne il senso, mostrerebbe di non conoscere la complessa figura di Leopardi. Che era capace di unire la passione per il sapere, il rigore della ricerca filologica, a una dispiegata vocazione al canto.
Sarà nella sua opera poetica che dovremo muoverci per trovare un’altra voce che niente ha a che fare con un lemma: una voce che corrisponde all’intonazione, al timbro proprio ad esseri amati e scomparsi, o che modula nella notte canti che nel silenzio diventano subito di malinconia e abbandono.

Dalla voce collettiva che nella canzone All’Italia consentiva di serbare memoria dei caduti alle Termopili, da quella della libertà che risuona in Sopra il monumento di Dante, da quella antica degli avi dell’Angelo Mai, si arriva presto alle voci “care al cuore” del Primo amore (più tardi di Consalvo), soprattutto alle voci di Silvia, di Nerina.
Non poter vedere gli occhi, non potere udire la voce che una volta risuonava nelle stanze di Recanati (dunque del mondo): è così che Leopardi parla dell’interruzione dei rapporti e dell’esperienza del morire. La voce del tempo (quella che ridesta il finito nell’Infinito) porta via la vita, e con quella ogni possibilità di dar senso al cosmo.
E dunque il poeta non potrà che levare alta la voce (così anche nelle Operette morali, nel Dialogo della Natura e di un Islandese) per accusare l’arcana forza generatrice e chiederle ragione dell’assurdità e crudeltà dell’esistenza.
Sarà una voce, la sua, che, nata dal “dolor mio nel sentire”, sarà capace di distinguere il canto delle erbe nel mattino, di riconoscere le voci (Leopardi nello Zibaldone aveva riflettuto sugli organi della fonazione e sulle tonalità), distaccandole dal silenzio assordante, dall’indifferenza opposta dalla Natura. E così la sua voce, ora vibrata, ora sommessa, ma sempre ferma e decisa, continua ripetere, mai stanca di denunciare.
Mentre l’altra voce, il suono della poesia, offre parole, ritmo, perfino paradossale e solidale consolazione, in liriche che trovano senso e ragione nel vagheggiamento del perduto e in un’ininterrotta invettiva.
Per altro la voce della sua poesia non doveva discostarsi troppo dalla voce reale, se ci arrischiamo a stabilire un rapporto tra la vocalità che emerge dai versi e il suono vivo percepito da chi ebbe modo di ascoltarlo.
Racconta De Sanctis, che lo aveva incontrato alla scuola di Basilio Puoti, che Leopardi “parlava gentile e modesto”. L’amico Ranieri ricorda che la sua voce, quando era ormai prossimo alla morte, era “fioca”, eppure pronta a disputar “dolcemente”.
Il fatto è che Leopardi aveva cercato, attraverso una voce diventata poesia, la durata di un io che solo nella scrittura della voce poteva trovare modo di continuare ad esistere. Un grido di protesta e pietà, una voce che, giunta fino a noi, dopo l’invettiva, prima del suo scioglimento, ancora rompe il silenzio (l’assenza di voce) dimostrando che è possibile la fusione di bellezza e verità.