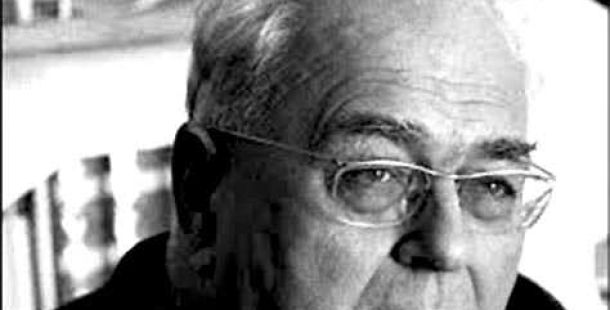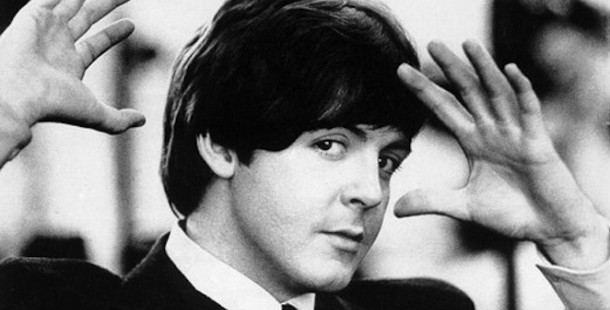NOTA A MARGINE
Storia più antropologia: fra pratica sul campo e polverosi archivi l’importanza dell’interdisciplinarità
Interdisciplinare. E’ un termine particolarmente in voga. Fatto positivo e sintomo, probabilmente, che nel complicato mondo contemporaneo abbiamo davvero bisogno di sistemi utili per facilitare la convivenza fra saperi e discipline tutti importanti ma spesso di per sé insufficienti per aprire un dialogo davvero costruttivo. Il rischio infatti è quello di perdersi fra questa moltitudine di moderni settori di studio; un rischio che il più delle volte coincide con la netta circoscrizione delle stesse discipline in contesti di nicchia, ostacolando il dibattito. Tutto ciò influisce sul nostro patrimonio, sul nostro futuro e soprattutto sulla nostra capacità di innovare. Ecco allora il bisogno di interdisciplinarietà.
E grazie ad alcune Department lectures, l’Università di Ferrara è stata teatro negli ultimi giorni di alcuni seminari a carattere, appunto, interdisciplinare, occasioni preziose per far sedere attorno ad un tavolo esperti di differenti discipline, pronti a dialogare da più punti di vista su importanti tematiche comuni. Dopo il seminario incentrato sulla situazione degli Urban studies in Italia [ne abbiamo scritto su Ferraraitalia, leggi qua], lunedì 30 novembre è stata l’occasione per analizzare il longevo e difficile rapporto nel tempo tra storia e antropologia, due ambiti fra cui il confronto non è mai stato semplice, nonostante la stretta relazione nella finalità e negli obiettivi. “Quale dialogo?” è l’inevitabile sottotitolo dell’evento organizzato da Giuseppe Scandurra e moderato da Michele Nani (docente Unife e antropologo il primo, storico e membro del Cnr a Roma il secondo), animato dagli interventi dei relatori Ferdinando Fava (antropologo e docente Unipd), Enrica Guerra (storica e docente di Storia medievale a Unife) e gli esperti di storia contemporanea Andrea Rapini (Università di Modena e Reggio Emilia) e Michele Colucci (ricercatore al Cnr-Roma).
Introducendo il suo discorso con l’azzeccata frase dello storico Marc Bloch, “La storia è la scienza degli uomini nel tempo”, ad aprire la discussione è Fava, il quale afferma che se l’antropologia viene universalmente riconosciuta come “la scienza degli uomini” diventa facile capire i legami tra le due e constatare che “storia e antropologia sono discipline che convivono già da parecchio tempo”. Per Fava la chiave del rapporto sta quindi nel paradigma temporale, poiché “mentre quando un antropologo è sul campo risulta essere arrogante a causa della sua pretesa di conoscere il mondo a partire dalle relazioni interpersonali, lo storico, rinchiuso in archivio, non ha presente le relazioni pratiche e reali e si trova costretto a basarsi esclusivamente su delle tracce, consultando documenti”.
Ad approfondire questa delicata tematica legata al rapporto tra lo storico e il tempo è stata Enrica Guerra che, in quanto medievalista, ammette che “il forte divario tra me e le persone che studio fa sì che io mi debba calare nei loro tempi e nelle loro situazioni; ogni concetto o situazione vanno ribaltati”. Per quanto riguarda il citato limite delle fonti nel mestiere dello storico, Guerra ricorda che “soprattutto nel mio campo ogni fonte è sì testimonianza ma sempre parziale e mai completa, così come mai si può essere in grado di capire se ciò che abbiamo a disposizione è completo o quantificare quanto è andato perso”. Come fare quindi per lavorare in modo efficace? Ironicamente la docente Unife afferma che “la vita dello storico è una vita piena di dubbi” e che per agire contro la problematica dell’affidabilità delle tracce in possesso è necessario essere “il più onesti e trasparenti possibile nella ricostruzione dei fatti. Quello che conta maggiormente è contestualizzare le ragioni”.
Storico e scrittore (tra le sue pubblicazioni un’analisi storico-sociologica sulla Vespa e su Bourdieu in Algeria), Andrea Rapini definisce la storia come “lo studio del passato a partire dal presente, non da una camera stagna, lo storico studia gli uomini nel tempo, percorre continuamente la linea che parte dal passato ed arriva al presente e viceversa”, e proprio per questo afferma che “storicizzare è fondamentale: il presente va valorizzato nella lettura del passato, ciò di cui dobbiamo dimenticarci del presente sono le categorie mentali e il ritorno in voga degli studi di genere, culturali e coloniali ne sono la perfetta dimostrazione“. Per Rapini diventa importante “evitare il più possibile gli anacronismi nella moltitudine di nuovi cantieri di ricerca in ambito storico dei nostri giorni” e per far sì che ciò avvenga individua nella riflessività il “punto maggiormente in comune tra le varie discipline che abbiano a che fare con la storia”; il dovere di tutti diviene quindi “aprire realmente il confronto” poiché “per capire cosa ci accade intorno non bastano più le quote delle varie discipline, perché insufficienti rispetto alla complessità del mondo. Le discipline sono gabbie circoscritte al mondo accademico, non hanno più valenza per capire il problemi della storia e, per dare una svolta al sistema, devono saltare”.
Dopo questo importante monito, è stato infine Michele Colucci a intervenire. Lo storico, responsabile di un laboratorio di studio sull’immigrazione interna presso il Cnr e autore di un libro sull’immigrazione italiana nel secondo dopoguerra, che della collaborazione quotidiana tra diverse discipline ne ha fatto quindi un mestiere, ricorda quanto sia “difficile mettere in pratica l’interdisciplinarità, oggi un desiderio fin troppo abusato”. A livello di approccio sono importanti “il linguaggio e le tradizioni“ così com’è necessario “riuscire a fare un lavoro di continua rimessa in discussione anche da parte del ricercatore: questo punto di vista fluido è un arricchimento e gli storici ne hanno realmente bisogno”. Tutto ciò è quindi difficile da applicare tra le varie discipline e il laboratorio gestito da Colucci ne è la dimostrazione “perché – afferma – si tratta di un cantiere estremamente ricco ma allo stesso tempo difficile da portare avanti a livello di dialogo, anche se tuttavia oggi riuscire in questo è l’unico modo per cogliere il rischio delle provocazioni”. Colucci infine ricorda come la (ri)scoperta del territorio sia lo strumento privilegiato per capire ciò che cambia: “A differenza della geografia, dell’antropologia e così via – conclude – l’unica scienza sociale studiata in tutti gli istituti è la storia! E se si pensa in che maniera oggi la storia recente sia entrata all’interno del dibattito pubblico, bisogna ammettere che gli storici risultano essere molto indietro e poco consapevoli dell’estrema importanza del loro ruolo”.