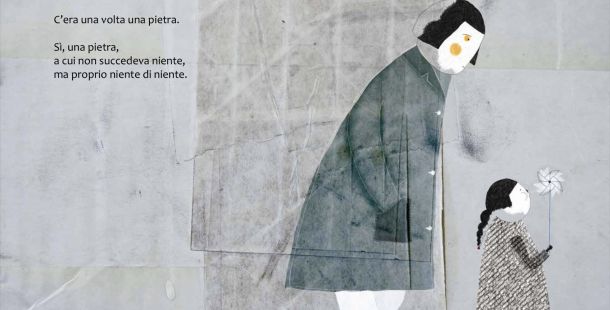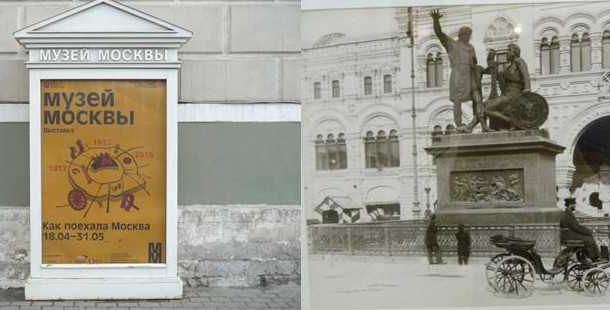Il cucchiaino scomparso
Tempo di lettura: 4 minuti
Può la tavola periodica degli elementi incontrare la mano sinistra? Le emozioni, la passione, il coinvolgimento? Pare proprio di sì. Perché, fuori dalla scuola, puoi scoprire che anche la scienza ha un’anima, le sue debolezze e può perfino incuriosire, quasi intrigare. Goethe e Mark Twain ne avevano una particolare attrazione, una soddisfazione estetica per la sua regolarità, per le sue ripetizioni ricche di variazioni come una fuga di Bach.
E tuttavia la bellezza della tavola non è solo astrazione. Essa ha ispirato l’arte in tutte le sue forme. L’oro, l’argento e il platino sono di per sé gradevoli da contemplare. Gli elementi hanno un ruolo importante nel moderno design e nella produzione degli oggetti belli che rendono piacevole la vita.
Nella storia della tavola periodica ci sta anche la mitica Parker 51 per via del pennino al rutenio.
Ancora, quel certo pizzico di sale che a volte manca ad alcuni cervelli si ricava dal litio, con il quale sono state curate le stravaganze di diversi artisti a partire dalla follia del poeta americano Robert Lowell.
Il cucchiaino scomparso di Sam Kean (Adelphi) è la dimostrazione che la chimica può essere compresa e non solo imparata a memoria. Offre l’opportunità di guardare a questa materia con occhi altri da quelli a cui ti costringe la scuola con la spada di Damocle delle interrogazioni.
Già Primo Levi, chimico, si era misurato con la tavola di Mendeleev nel suo Sistema periodico al quale lo stesso Kean dichiara di ispirarsi. Ma la narrazione di Sam Kean, è proprio il caso di dirlo, produce reazioni a catena. Un grande romanzo della Chimica non privo di colpi di scena. Un affascinante libro che, come ha scritto Odifreddi, dovrebbe essere letto dai molti che della chimica sanno una cosa sola: che c’è.
La tavola periodica, come la vede Kean, è un castello con due torri asimmetriche. Al castello si accede seguendo la mappa che conduce alle singole stanze, ognuna occupata da uno dei centododici elementi presenti in natura e non solo. Per ognuno di loro Sam Kean ne ha delle belle da raccontare.
I gas nobili sono incorruttibili e perfetti, gli atomi creature conformiste e prive di immaginazione, gli evanescenti e capricciosi elettroni se ne vanno di casa a caccia di vicini più interessanti.
Il pianeta Giove è un impostore, perché in realtà è una stella mancata. Il mito di re Mida, che lo stesso Ovidio con le sue Metamorfosi contribuì ad alimentare, non è altro che una patacca di ottone. Il tocco di Mida, con buona probabilità, era solo dovuto alle quantità di zinco della Frigia, metallo che gli accidenti della geografia gli avevano fatto trovare in grande abbondanza nel suo angolo di Asia Minore.
Così come dietro all’Eldorado e alle leggende sulla corsa all’oro ci sta «l’oro degli sciocchi» che splende ancora di più dell’oro vero: la pirite, disolfuro di ferro.
L’ignoranza della proprietà degli elementi ci rende dei perfetti allocchi. Come gli spettatori esterrefatti di fronte allo svanire nel tè del cucchiaino di gallio, metallo malleabile e di colore argenteo simile all’allumino, ma che al solo contatto del calore della mano si scioglie.
L’eka-alluminio, oggi chiamato gallio, solleva una domanda di fondo: che cosa fa realmente progredire la scienza, le teorie che inquadrano la nostra visione del mondo o gli esperimenti, il più semplice dei quali può demolire la più elegante delle teorie?
«È la teoria che decide ciò che possiamo osservare» ebbe a dire una volta Albert Einstein. Alla fine della storia, è probabilmente impossibile capire quale delle due facce della medaglia, teoria o esperimento, abbia maggiormente contribuito al progresso della scienza.
Sappiamo che sbagliare non sempre porta a conseguenze disastrose. La gomma vulcanizzata, la penicillina e il teflon sono tutte scoperte figlie di errori. Ritrovamenti casuali ed errori accidentali hanno spinto in avanti la scienza per tutto il corso della storia.
Gli studi più avanzati nel campo dell’intelligenza artificiale sembrano indicare che un chip al silicio potrebbe egregiamente sostituire un nostro neurone, ma se la storia sessant’anni fa avesse preso una piega diversa, favorendo lo sfortunato germanio anziché il silicio, oggi tutti parlerebbero della celebre Germanium Valley dalle parti di San Francisco.
La prerogativa degli elementi è che esistono e basta, né creati né distrutti. Secondo i calcoli di un fisico, dieci minuti dopo il big bang tutta la materia conosciuta era già presente.
Ma c’è un’altra faccia, la più inquietante, ed è che gli elementi da sempre hanno servito e scatenato guerre.
Che Niobe e Tantalo, vittime eccellenti dell’ira degli dei, possano aver a che fare con il nostro cellulare, forse nessuno di noi l’avrebbe sospettato. È difficile da credere, eppure da loro discendono i nomi del tantalio e del niobio, elementi senza i quali i nostri cellulari non esisterebbero, ma il cui possesso fa sì che i nostri telefonini grondino sangue. Il controllo dei giacimenti di coltan, miscela complessa di minerali di tantalio e niobio, è all’origine del più spregevole saccheggio, del peggiore macello dai tempi della seconda guerra mondiale. A partire dalla metà degli anni Novanta, guerre e guerriglie nella Repubblica Democratica del Congo, che detiene il 60% delle riserve mondiali, hanno mietuto più di cinque milioni di vittime.
Insomma, un altro prezioso libro da leggere, un’altra intelligente narrazione che fa della storia della scienza un ipertesto tutto da scoprire.