Il pane nel lavatoio
Il pane nel lavatoio
Aversa, inverno del 1943
Anna aveva quattordici anni, ma ne dimostrava dieci. Magra come un fuscello, con le ginocchia sempre sbucciate e i capelli raccolti alla meglio sotto un fazzoletto stinto, era una delle tante bambine diventate grandi troppo in fretta. La guerra, ad Aversa, non era fatta di bombe ogni giorno, ma era peggio: era fame, silenzio, attesa e occhi sempre aperti. Era il rumore dei camion tedeschi per le strade e il vuoto della dispensa in casa.
Il padre era morto in Africa, dicevano. Nessuno l’aveva visto cadere, solo una lettera arrivata mesi dopo, scritta da un ufficiale che parlava di “onore” e “patria”. La madre lavorava quando trovava qualcosa, spesso raccattava legna o andava nelle campagne a chiedere un tozzo di qualcosa in cambio di panni lavati, puliti o rattoppati.
Anna, per aiutare, andava dalle suore. Quelle del convento di Sant’Agostino, che accoglievano orfane e cucinavano minestre con l’odore della speranza. In cambio di qualche ora al lavatoio, le davano un pezzo di pane duro. “‘Nu filone piccolo”, lo chiamavano. Ma per Anna era un tesoro. Lo prendeva con le mani tremanti e lo infilava nel seno, tra la pelle e la sottoveste, per non farselo portare via da nessuno. Lo conservava caldo con il suo corpo.
Il lavatoio del convento era una stanza fredda, umida, con le vasche di pietra scura, sempre piene d’acqua gelata. Le suore portavano lenzuola, camicie, sottane da pulire. Anna strofinava con il sapone di cenere, con le mani rosse e screpolate. Le unghie rotte, i piedi gonfi. Ma non diceva nulla. Sapeva che solo lavorando avrebbe potuto guadagnarsi quel pane.
Quel giorno, un lunedì, pioveva. La pioggia batteva sui vetri, e il cielo era basso. Anna aveva finito quasi tutto il bucato. Si chinò per prendere una coperta spessa, la sollevò e cominciò a sviolinare, come diceva la suora anziana, strofinando con forza per far uscire la schiuma.
Fu allora che accadde.
Sentì uno scivolare. Un tonfo sordo. Si voltò e vide il filone — il suo pane — galleggiare nella vasca, tra la schiuma e i panni sporchi.
Per un attimo rimase ferma. Il cuore le batteva forte. Il pane era tutto quello che aveva.
Lo tirò su subito, con le mani. Era zuppo, molle, con qualche filo di sapone attaccato. Aveva l’odore delle lenzuola sporche, del freddo, dell’acqua stagnante. Lo strizzò tra le mani, come se potesse cavarne ancora qualcosa di buono. Poi si guardò intorno.
Nessuno la stava osservando.
E allora, lo addentò.
Lo morse con rabbia, con dignità, con dolore e fame. Lo mangiò tutto, un morso dopo l’altro, anche se il sapore era amaro, anche se sapeva di lavandaio, di suora, di miseria. Le scendevano le lacrime — non capiva se dal freddo, dalla vergogna o dalla fame che non si fermava mai.
Passarono gli anni. La guerra finì, come finiscono tutte le guerre: tardi, male, e lasciando dietro chi non ce l’ha fatta.
Anna crebbe. Si sposò, in seconde nozze, con un tranviere vedovo, ebbe due figli. Ma quel pane, il pane caduto nel lavatoio, non lo dimenticò mai.
Ogni volta che qualcuno si lamentava del pranzo, ogni volta che buttavano via una crosta troppo dura, lei stringeva i denti e diceva:
“Io una volta ho mangiato il pane lavato nel sapone. E non me ne sono mai pentita.”
E nessuno rideva. Perché nei suoi occhi c’era qualcosa che nessun tempo poteva cancellare: la fame, e l’orgoglio di non essersi mai arresa.
In copertina: Lavatoio antico pubblico Sant’Agata sui due Golfi: immagine Wikimedia Commons

Sostieni periscopio!
Tutti i tag di questo articolo:







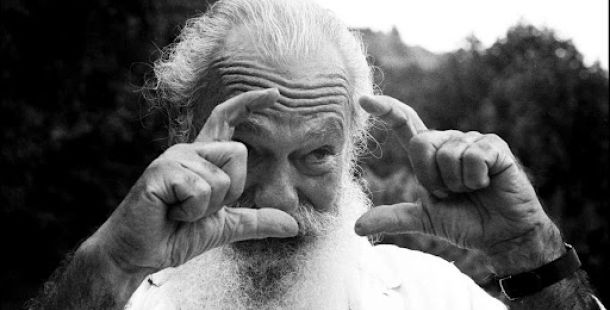
Che bellooo! Un ritmo incalzante e commovente. Una realtà resa poesia di