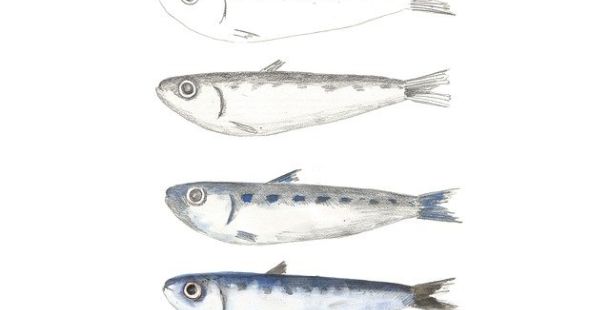LA LUCE GENTILE DI BERLINGUER
Lo sberleffo leghista e il triste buio della Sinistra
Trentasei anni fa, dal palco di un comizio a Padova, Enrico Berlinguer, un fazzoletto sulla bocca a contenere il vomito, le gambe che non lo reggevano più, portava a termine con grande fatica il suo discorso, tra militanti e cittadini che gli urlavano “basta Enrico!” tentando di preservare dal male quell’uomo fragile, minuto, ancora lontani dall’idea del vuoto che avrebbe lasciato.

A distanza di trentasei anni, tale Salvini da Milano approfitta del fatto che la Lega sposterà la sede romana in via delle Botteghe Oscure per dichiarare, con l’usuale sprezzo del ridicolo, che la Lega a suo dire avrebbe ereditato i valori della sinistra di Berlinguer.
Non griderò alla lesa maestà, né mi soffermerò troppo sulla provocazione del losco figuro, che alla maniera trash tanto apprezzata dai suoi fans declama uno slogan allucinato, fraintendendo (apposta) il dato reale: cioè che anche alcuni operai ora votano Lega. Questo è il dato di fatto, la disperazione di persone che abbracciano valori di odio per paura sociale. Ma la comunicazione del figuro non si cura della realtà del dato, parte dal dato di realtà per costruire un racconto fasullo. E’ l’essenza della sua propaganda, del resto. Salvini, ad ogni modo, mi serve solo come gancio per tornare su Berlinguer, sulla sua prematura scomparsa e sul fatto che non ha lasciato eredi. Nè il losco figuro, che smetterò di citare per non dargli l’importanza che non merita, nè altri. E questa vuole essere un’affermazione seria.
Lo sgomento e il senso di perdita di milioni di persone che non lo avevano mai conosciuto, ma che piansero la sua morte come quella di un familiare amato – me compreso, ed ero un ragazzo – potevano essere riservate solo a lui e a Sandro Pertini. La stessa fisiognomica dell’individuo, la sua postura, la sua frugale eloquenza hanno esercitato un fascino collettivo la cui anomalia risiedeva nella singolare sobrietà. Infatti il culto della personalità indirizzato verso i leader di movimenti politici ispirati al marxismo sceglieva figure iconiche, retoriche, condottieri vestiti da guerrigliero, la cui scomparsa trasportava il lider maximo in un cielo empireo e generava un lascito mitologico depurato dalle debolezze umane sul quale, con naivetè, continuare la battaglia (unica eccezione forse Pepe Mujica).
Il carisma di Berlinguer si fondava, viceversa, anche sulla sensazione di fragilità che lo accompagnava, persino coreograficamente, quando saliva sul palco di congressi pletorici o di adunate oceaniche, rendendole docili al suo eloquio pulito, scandito ma privo di enfasi. Un insopportabile luogo comune dei politici, che vorrebbe segnalare un presunto, ridicolo disinteresse personale, recita: “non importano i nomi, importano i contenuti, non contano gli uomini, contano le idee”. Stupidaggini. Gli uomini contano eccome, e non per la banale ragione che se non esistessero gli uomini non esisterebbero le idee, ma perché la credibilità di un individuo incarna, letteralmente, un’idea, ed il seguito che riscuoterà. E quando è mancato l’uomo Berlinguer, all’improvviso, lo scarto tra l’autorevolezza della persona e il fiume delle idee che avrebbe dovuto tramandare ai suoi compagni e alle cosiddette masse è apparso incolmabile.
Berlinguer era un comunista guardato con sospetto sia a Ovest che a Est. A Ovest temevano che riuscisse ad aggirare la conventio ad excludendum che congelava il consenso comunista nel freezer delle roccaforti rosse, fino a farlo approdare al governo centrale. A Est temevano la sua eresia, il fatto che volesse coniugare socialismo e democrazia rappresentativa e si potesse portare dietro un Paese atlantico fino a slabbrare la cortina di ferro, al riparo della quale una elefantiaca nomenklatura coltivava i suoi privilegi (sarebbe stato avvincente averlo vivo durante la stagione della perestroijka di Michail Gorbacev).
Partiamo da Ovest. Quando Berlinguer, nel 1973, teorizzandola con tre articoli su Rinascita, propone una riedizione del dualismo tra Don Camillo e Peppone trasformandolo in una alleanza cattocomunista non lo fa per buttarla in commedia, ma per scongiurare la tragedia. Per evitare che la drammatica strategia della tensione in atto dalla strage di Piazza Fontana (1969) in avanti, attribuita con depistaggi agli anarchici ma frutto di una saldatura mai interrotta tra neofascisti clandestini e settori fascisti degli apparati dello Stato, sfoci in un golpe “alla cilena” con l’instaurazione di un regime autoritario e con la sospensione delle garanzie costituzionali.
Berlinguer, ovviamente, non partorisce l’idea del compromesso storico in preda ad elucubrazioni di stampo complottista. Alcuni documenti sottratti all’ambasciatore greco in Italia (e finiti poi sulla stampa britannica) disegnavano una strategia degli Stati Uniti che, con la collaborazione del regime dei colonnelli in Grecia, intendeva radicalizzare lo scontro sociale per bloccare l’ascesa per via democratica dei comunisti italiani al governo. Non poteva essere tollerato, nel cuore del Mediterraneo, che un paese chiave del Patto Atlantico venisse governato da un partito che si richiamava alla dottrina comunista. Nonostante, infatti, la parte comunista della Resistenza avesse dato un contributo fondamentale alla scrittura della nuova Carta Costituzionale, di cui le regole di funzionamento dello Stato in termini di democrazia parlamentare costituivano nucleo centrale, gli equilibri internazionali usciti da Jalta e l’esito della (allora non conclusa) controffensiva al nazifascismo non prevedevano che l’Italia potesse avere un partito comunista al governo. La pregiudiziale antifascista di diritto su cui si erigeva la Costituzione Repubblicana copriva una pregiudiziale anticomunista di fatto, in nome della quale si muoveva un potentissimo sottobosco, solo parzialmente scoperchiato dalla magistratura ma rimasto tuttora oscuro nelle propaggini più sinistre, mostrato con mirabile capacità analitica e visionaria da Pier Paolo Pasolini nel famoso articolo “Io so”, pubblicato sul Corriere della Sera del 14 novembre 1974.
Facendo digerire al partito il compromesso storico (e a se stesso l’appoggio a un monocolore DC guidato da Andreotti) Berlinguer non scelse lo Stato deviato e infido che esisteva, ma l’idea di Stato che aveva in mente. Sotto questo profilo e con le debite differenze, fece una scelta assimilabile a quella di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che scelsero lo Stato di un futuro senza di loro, contro lo Stato presente che ne inquinava il lavoro e ne minava la reputazione e, letteralmente, le strade che avrebbero percorso.
Lo scelse, lo Stato, anche rischiando il partito, lasciando scoperta un’ala sinistra che, in alcuni suoi esponenti, divenne disperata e saldò, oggettivamente, una velleitaria idea di rivoluzione armata con le pulsioni autoritarie degli apparati deviati, uccidendo non solo Aldo Moro, ma la prospettiva da lui disegnata con Berlinguer. Di questa incredibile miopia politica i brigatisti sono stati colpevoli, quanto della barbarie umana che li ha portati a bruciarsi la vita in carcere. Così in DC venne restaurato l’ancien regime riportando in vetta gli uomini più torbidi, Berlinguer rimase orfano dell’autorevole sodale che aveva condiviso con lui la prospettiva della confluenza al governo delle due più radicate tradizioni sociali italiane, e si riposizionò quasi forzatamente sull ‘alternativa democratica’: un lavoro di più lunga lena che prevedeva di cacciare lo Scudo Crociato all’opposizione, ma che dovette fare i conti con un Bettino Craxi riottoso all’idea di un nuovo fronte popolare, che avrebbe ridotto il Partito Socialista Italiano alla subalternità verso i comunisti.
Guardiamo a Est. Berlinguer non fu impaziente di dichiarare formalmente l’autonomia del partito italiano da Mosca, in termini economici, organici e ideologici. La preparò per gradi, in modo che quando la dichiarò, nel 1980, la dichiarazione suonò nel partito come una presa d’atto e non come uno strappo del “capo”; esattamente il contrario di quanto fece Achille Occhetto, nel 1989, sull’onda – non certamente banale – della caduta del Muro.
Non fu impaziente, ma fu implacabile nel marcare il progressivo affrancamento dal giogo del socialismo reale. Glielo disse in faccia già nel 1969, a Breznev, e glielo disse a Mosca, alla presenza di tutti i comunisti del mondo: “Respingiamo il concetto che possa esservi un modello di società socialista unico e valido per tutte le situazioni. In verità le stesse leggi generali di sviluppo della società non esistono mai allo stato puro, ma sempre e solo in realtà particolari, storicamente determinate e irripetibili”. Certo, c’era stata l’invasione dell’Ungheria, nel ’56, nemmeno condannata, e quella della Cecoslovacchia nel ’68, bollata semplicisticamente come un “tragico errore”, che si portò dietro la critica radicale di intellettuali di valore come Luigi Pintor, Rossana Rossanda e Lucio Magri, il cui esplicito dissenso, concretizzato nella pubblicazione del giornale eretico Il Manifesto, portò alla loro radiazione dal partito, tre anni prima che Berlinguer diventasse Segretario Generale.
In ogni caso, per chi pensa che Berlinguer sia stato troppo timido nell’accelerare il processo di autonomia dal blocco socialista: nel 1973, mentre tornava all’aeroporto di Sofia dopo uno spigoloso faccia a faccia con la nomenklatura bulgara, un incidente coinvolse l’auto a bordo della quale viaggiava. Berlinguer se la cavò con delle contusioni e la convinzione, confidata ai familiari e a Macaluso, che sarebbe stato prudente non mettere più piede in Bulgaria. Se per il Patto Atlantico Berlinguer era l’astuto e accorto gramsciano che cercava di entrare nella stanza dei bottoni dalla finestra, visto che la porta era sbarrata, per il Patto di Varsavia Berlinguer era inaffidabile, un deviazionista, un non ortodosso che da Segretario del più grande partito comunista d’Occidente minava le fondamenta del sistema. E’ probabile che avessero ragione entrambi.
Per Berlinguer austerità non era un modo di fare buon viso a cattiva sorte, visto che lo choc petrolifero ci faceva viaggiare a piedi. Era fare i conti con “l’ingresso sulla scena mondiale di popoli e paesi ex coloniali che si vengono liberando dalla soggezione e dal sottosviluppo a cui erano condannati dalla dominazione imperialistica. Si tratta di due terzi dell’umanità, che non tollerano più di vivere in condizioni di fame, di miseria, di emarginazione, di inferiorità rispetto ai popoli e paesi che hanno finora dominato la vita mondiale”. I nuovi problemi posti dai moti di emancipazione di questi popoli devono far abbandonare “l’illusione che sia possibile perpetuare un tipo di sviluppo fondato su quella artificiosa espansione dei consumi individuali che è fonte di sprechi, di parassitismi, di privilegi, di dissipazione delle risorse, di dissesto finanziario”. A questa nuova sobrietà dei consumi, nel nome anche di un parco uso delle risorse naturali (intuizione attualissima), corrisponde un profilo etico che lo porta a stigmatizzare il nascente, onnivoro appetito dei partiti verso le istituzioni, tale da portare l’Italia ad essere dominata da un rapporto di clientela paramafioso tra chi ha bisogno di lavorare e chi tramuta in favore le opportunità, in cambio di un’adesione non ideale, ma organica al partito, che si sostituisce allo Stato non di diritto, come nelle economie della pianificazione, ma di fatto. Il suo partito non sarà affatto estraneo a queste pratiche, facendo strame della “questione morale” sollevata dal suo leader.
Berlinguer pre-vide tutto questo, ma non fece in tempo a diventare coautore di quel futuro. La sua scomparsa fu precoce ed imprevista per la sua famiglia e per un partito che, con tutta evidenza, non era preparato alla sua successione. Nemmeno Berlinguer lo era, impegnato com’era a immaginare gli sviluppi politici e a gestire le urgenze presenti nel pieno della sua, pur estenuata, vitalità. Quella scomparsa prematura apre un vuoto verticale, un vertiginoso burrone che rende tutti, all’improvviso, orfani. Orfani non solo di una personalità dal carisma quasi riluttante, ma di un armamentario ideologico e strategico che nella sua incarnazione aveva una forza persuasiva, e senza di lui appare ad un tratto sottile, privo di una sostanza che Berlinguer solo sapeva conferirgli.
Come se il marxismo senza Berlinguer non avesse più l’unico interprete capace di renderlo adatto ad interpretare la modernità, e rimanesse un’attrezzatura datata, statica, protoindustriale. Come se la “terza via” avesse un senso solo se raccontata da quest’uomo pulito, nei tratti e nei modi, e senza la sua figura ad illuminarla (con una lucetta che oggi sarebbe sicuramente ad alto risparmio energetico), la strada dell’economia del capitale diventasse troppo oscura, insidiosa, possente ed infida, e noi fossimo privi di strumenti che ci permettessero di prevederne le temibili curve.
Come se togliere la parola “comunista” dal nome del partito non significasse fare un salto ambizioso dentro il futuro liberandosi di una zavorra, ma sottrarre il peso e la consistenza originaria di quel pensiero fino a renderne deboli le fondamenta, e impalpabili i fini.
Come se l’elaborazione teorica che intendeva prendere il meglio dell’analisi marxiana e dell’esperienza socialdemocratica, saldarle e superarle entrambe, fosse in realtà il sogno di un uomo, e non un filone degno di approfondimento. Con quale motivazione essere austeri se lo scopo di una società radicalmente altra non è più l’orizzonte cui tendere? Con quale dirittura morale mantenere un disinteresse per i privilegi materiali se non si lavora per il bene collettivo, ma solo individuale o della propria famiglia?
Questa inadeguatezza dei successori nel sostituire ad un fine salvifico, quasi messianico, un orizzonte “costituzionale” di inveramento dei diritti umano, laico, ma ugualmente radicale, ha consegnato i più scafati al disincanto, al cinismo ed al piccolo cabotaggio, i meno attrezzati alla paura e all’odio. E nell’ assecondare e rappresentare queste pulsioni, che per alcuni sono l’essenza della natura umana, la destra è molto più brava.