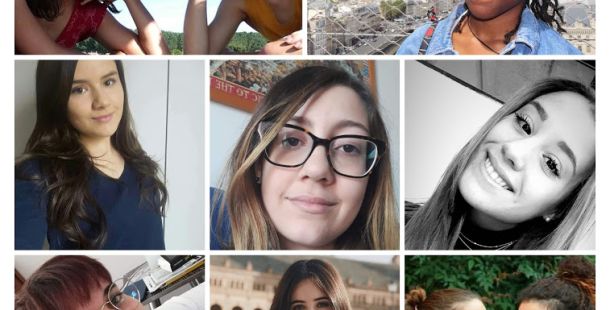Vite di carta /
“Casa d’altri”, il racconto perfetto di Silvio D’Arzo
Tempo di lettura: 7 minuti
Vite di carta. “Casa d’altri”, il racconto perfetto di Silvio D’Arzo
Così è stato definito da Eugenio Montale: “un racconto perfetto”. Mi riferisco a Casa d’altri, scritto nel 1947 da Ezio Comparoni, un giovane autore di Reggio Emilia che per pubblicazioni precedenti si era dotato di altri pseudonimi e che per questo suo racconto lungo aveva scelto di firmarsi Silvio D’Arzo. Ho ritrovato il suo nome in appunti ormai datati, presi a un corso d’aggiornamento per docenti di letteratura italiana; il relatore era il grande Andrea Battistini, che ne caldeggiò la lettura a chi gli chiedeva quali fossero gli autori canonici del Novecento. E’ passato anche troppo tempo, ora voglio conoscerlo. Per prima cosa cerco negli scaffali della mia libreria e trovo quasi subito un volumetto che ho comprato all’epoca, L’uomo che camminava per le strade: una raccolta di racconti dello stesso D’Arzo uscita nel 1993 a cura di Daniele Garbuglia, in cui è riportata una buona bibliografia sull’autore; da lì spicca il nome di Eraldo Affinati come curatore dell’opera saggistica di D’Arzo, raccolta sotto il titolo Contea inglese.
Ho conosciuto Affinati e letto il suo intenso L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani; so che lavora con passione e scrive con sguardo profondo. Si aggiunge a Montale e a Battistini nello spingermi verso questo giovane scrittore reggiano che era del 1920, come mio padre, e come me si era laureato in Lettere a Bologna, lui però a soli 21 anni. Un grande talento morto a 32 anni di leucemia. Non so da cosa vi facciate convincere voi nelle scelte di lettura, io sono piuttosto sensibile alle parabole di vita così segnate dalla tyche e mi lascio guidare volentieri dal giudizio di coloro che mi sono maestri.
Eccomi dunque con il volumetto dei racconti tra le mani. Scelgo di leggere in ordine casuale i testi che vi sono raccolti e sono ben contenta che Casa d’altri qui non ci sia. Sento che devo rispettare delle tappe di avvicinamento al capolavoro. Vado solo a sbirciare le poche righe che lo riassumono nella edizione Einaudi del 1980, che intanto mi sono procurata, in cui la introduzione è scritta proprio da Affinati: i protagonisti sono un prete e una vecchia. Il fulcro della storia ruota intorno a una domanda che la donna rivolge al prete. Mi piace. Mi piace che i personaggi siano persone così e che le parole scambiate tra loro stiano al centro del racconto.
 Comincio a leggere e la voce narrante, che è quella del parroco di un paese dell’Appennino reggiano, mi introduce alla povera vita che si conduceva lassù poco dopo la fine della seconda guerra. Nelle pagine iniziali siamo dentro la vita quotidiana del prete: sta lasciando la casa di un morto e dà le disposizioni per il funerale del giorno seguente; incontra il giovane parroco del paese vicino che è appena arrivato ed è pieno di iniziative e lo raggela dicendogli che lì, nella zona di Montelice, la vita non cambia mai, non succede niente di niente.
Comincio a leggere e la voce narrante, che è quella del parroco di un paese dell’Appennino reggiano, mi introduce alla povera vita che si conduceva lassù poco dopo la fine della seconda guerra. Nelle pagine iniziali siamo dentro la vita quotidiana del prete: sta lasciando la casa di un morto e dà le disposizioni per il funerale del giorno seguente; incontra il giovane parroco del paese vicino che è appena arrivato ed è pieno di iniziative e lo raggela dicendogli che lì, nella zona di Montelice, la vita non cambia mai, non succede niente di niente.
C’è un giorno diverso, però. L’esordio della storia è nei fatti che vi accadono sul far della sera: il prete sta tornando a casa e nota una donna che giù nel canale lava dei panni. E’ sola nella natura autunnale dalle tinte viola e tiene vicina a sé una capra. Il parroco non la conosce: deve essere venuta a vivere qui da poco; la pensa come un “uccello sbrancato” e nei giorni che seguono ripensa a lei. Si aspetta che prima o poi vada da lui a parlargli, come fanno tutte. Da lui che si è ridotto a essere “un prete da sagre e nient’altro”, mentre ai tempi del seminario veniva chiamato doctor ironicus per la sua arguzia. Vecchio lui, ormai, e vecchia e solitaria lei. Per molte sere ripassa dal punto in cui l’ha vista la prima volta, solo per inquadrarla un momento nel freddo della sera, mentre la luce se ne va.
È amore. Rileggo alcuni passaggi per comprenderlo. Amore fulmineo, è predilezione e attrazione totale. Solo che D’Arzo dissemina brevi segnali linguistici di questo terremoto interiore che travolge il parroco e li distribuisce nei suoi pensieri, a piccoli dosaggi. Mentre le giornate scorrono, apparentemente uguali, il prete non pensa ad altro che ad allontanarsi da casa sul far della sera per rivedere la vecchia. Assume anche informazioni su di lei e viene a saperne il nome, Zelinda, e l’età, sessantatre anni. Fa la lavandaia e fatica da mattina a sera con la sola compagnia della sua capra. “Mai una volta alla processione: mai ai Vespri: mai in chiesa”. Una sorta di Lupa verghiana.
Attendo che arrivi la domanda fatidica che lei rivolge al prete tempo dopo, la sera in cui hanno camminato insieme per un tratto di strada. Ora sono giunti sulla soglia della casa di lei, sull’estrema soglia mi verrebbe da dire, e lei chiede: “se in qualche caso speciale…qualcuno potesse avere il permesso di finire un po’ prima”. Ecco, di nuovo non capisco. Ritorno indietro alle pagine in cui il prete si accorge della vita faticosa che Zelinda porta avanti, un giorno dopo l’altro. Non ho considerato abbastanza “il male di vivere” che la riguarda. Ho voluto cercare nelle pagine solo i segnali dell’attrazione che il prete prova per lei, scomodando lo Stilnovo con i suoi nodi concettuali: lo sguardo che innamora l’uomo, la visione epifanica della donna e il suo incedere e la sua ritrosia, come elemento che ancor più incatena l’amante.
Devo aver seguito una falsa pista di lettura. Non solo, ammetto che fatico a rapportarmi allo stile di questo testo: ora trasmette mille echi letterari che me lo rendono familiare, da Manzoni a Fenoglio, da Verga a Machiavelli, ora mi torna estraneo e diverso da ogni altro racconto o romanzo del Novecento che ho attraversato. Saranno le frasi brevi, dal tono perentorio. Frasi costruite spesso su battute popolari che comprendo solo in parte. E sì che sono emiliana come l’autore. Il ritmo narrativo è segmentato e si alternano asserzioni dalla carica semantica sempre diversa: una breve frase sul tempo autunnale già freddo, la successiva sui gesti del personaggio, quella dopo sugli universali della vita e della morte. Non so se mi piace. Capisco che nel mio ruolo di lettore sono in cammino e la strada non è agevole. Lo stile di Silvio D’Arzo un minuto mi fa sentire ‘a casa’ e un minuto dopo mi ha tolto ogni certezza. Meno male che l’introduzione di Affinati mi soccorre ed è un raffinato scavo dentro al testo, di cui fa emergere lo straordinario valore letterario.
Ho recuperato il senso della domanda: Zelinda vuole sapere se è permesso che qualcuno si tolga la vita, che lei ponga fine alla sua. Cosa le risponde il nostro prete, che in lunghi anni di ministero pastorale a Montelice ha celebrato matrimoni alla buona, cresimato ragazzi e messo d’accordo “sette caprai per un fazzoletto di pascolo”? Dice egli stesso “Sul momento non mi venne parola. Ma poi no, non fu neanche così: alla bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni e consigli e ‘per carità’ e ‘cosa dite’…Tutte cose d’altri, però…Di mio non una mezza parola: e lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di mio, e tutto il resto era meno di niente”. È una risposta inadeguata. Nella studiata simmetria del testo spicca l’asimmetria tra i ”cosa dite”, convenzionali, e la profondità filosofica della domanda.
Il prete da sagre chiude il suo racconto con due brevi sequenze: l’una nella casa di Zelinda, dove la salma di lei viene lavata e il pianto funebre sta per cominciare. L’altra quando, qualche tempo dopo, incontra il prete di Braino e trova che la vita del paese lo ha ingrassato. I segni del tempo che è trascorso sono tutti qui: le morti che si sono succedute (anche Melide, la perpetua, non c’è più), i chili che il curato ancor giovane ha messo su nella monotona vita della montagna.
“Allora mi vien sempre più da pensare ch’è ormai ora di preparare le valige per me e senza chiasso partir verso casa. Credo d’avere anche il biglietto. Tutto questo è piuttosto monotono, no?”
Casa? Penso che voglia intendere la vera casa, in cui un parroco aspira a tornare più di ogni altro, la casa del Padre. Anche se la relazione tra le persone del racconto è tutta orizzontale e la religiosità di Zelinda, che vuole morire e degli altri che restano a vivere, si consuma nei riti che essi compiono e nelle liturgie. Questa terra è casa d’altri. Così come cose d’altri sono le parole inadeguate, le parole trite. Credo di avere afferrato il senso che regge il racconto.
Mi tiro un po’ su, ma il cammino dentro questo testo è ancora lungo.
Nell’articolo faccio riferimento ai seguenti testi:
– Silvio D’Arzo, L’uomo che camminava per le strade, a cura di Daniele Garbuglia, Quodlibet, 1993
– Silvio D’Arzo, Casa d’altri e altri racconti, a cura di Eraldo Affinati, Einaudi, 1980
– Eraldo Affinati, L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani, Mondadori, 2016
Per leggere gli altri articoli e indizi letterari della rubrica di Roberta Barbieri clicca [Qui]