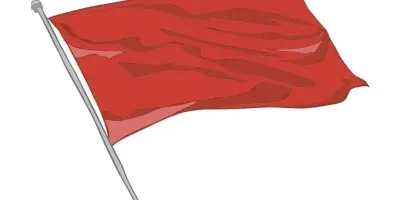La cultura marmellata
Certi caratteri nazionali resistono tenaci e persistenti nel tempo. Per esempio, a quasi due secoli di distanza, sembra confermata la diagnosi di Leopardi: “Le conversazioni d’Italia sono un ginnasio dove colle offensioni delle parole e dei modi s’impara per una parte e si riceve stimoli dall’altra a far male ai suoi simili… Gli italiani posseggono l’arte di perseguitarsi scambievolmente colle parole, più che alcun’altra nazione.” (“Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani”, 1824).
Il gusto di colpirsi a sangue con le parole è l’opposto della principale dote richiesta al vero confronto, che deve rispettare l’altro mentre ne critica le idee. Senza questa normale disposizione non c’è vera conversazione. Ma essa cresce solo dove esiste una società veramente civile, in cui le élite dettino tono e stile. In Italia, negli ultimi decenni, abbiamo registrato un degrado del linguaggio. Il principale strumento di informazione e intrattenimento, la televisione, ne è stato il veicolo principale. Sono stati promossi a star personaggi che hanno sfondato grazie al turpiloquio, all’ostentazione di arroganza ed aggressività. Al posto dell’eleganza e della eccellente testimonianza di cultura e di educazione civica del mitico maestro Alberto Manzi, è arrivato un esercito di intolleranti e di maleducati. Una parte della politica ha fatto suo questo stile. Soprattutto quella nuova. Mi riferisco alla Lega di Bossi e Borghezio e, per ultimo, al M5S il cui capo, Grillo, rivendica il V Day come l’evento fondativo del movimento.
Quale conseguenza deriva da questo degrado? Che il foro pubblico è stato occupato da un populismo ignorante e prepotente, secondo il quale l’opinione della gente più semplice e ignara sarebbe il fondamento della democrazia. Pian piano, è scomparsa l’idea che per confutare una posizione occorra conoscerla e che non basta, per neutralizzare una critica, squalificare il suo portatore con qualche etichetta qualunquista.
Bisogna riconoscere che la tendenza a sorvolare su prove, fatti, verifiche è una delle eredità peggiori del post-’68. Una parte di quei protagonisti (magari passati attraverso l’imposizione ai docenti del 18 garantito) pensava che la verità dovesse essere messa ai voti e non basata su competenza e rigore nella sua ricerca. Il prodotto più deteriore è stato un certo relativismo che non significa tolleranza e rispetto della pluralità, ma assolutizzazione di ogni punto di vista a scapito della verifica dei fatti. Così si presenta il relativista assoluto: “io la penso così. Non mi interessano le dimostrazioni!”. Ma se l’analisi della realtà viene annullata dalle credenze dei singoli e dei gruppi, allora al posto del pensare si sostituisce una propaganda fatta di retorica fumosa e abuso di parole astratte. Già gli antichi filosofi greci, avevano ben chiara la differenza tra credenze e conoscenze. La credenza non ha bisogno di essere dimostrata, la conoscenza sì: per questo Socrate non si stancava mai di dialogare. E il meglio della modernità (illuminismo, empirismo, rivoluzione scientifica, liberalismo) ha rappresentato il primato della cultura della sobrietà e della permanente ricerca e verifica pratica di idee e valori.
E’ uscita, in questi giorni, una raccolta di articoli e saggi di un raro intellettuale illuminista del nostro tempo, Giovanni Jervis (“Contro il sentito dire”, Bollati Boringhieri). In uno di questi saggi ricorre alla definizione di cultura-marmellata. E’ una metafora che vuole evocare un mondo in cui prevalgono le idee spalmabili, quel modo di pensare diffuso privo di caratteristiche salienti, amorfo, mai troppo impegnativo, mai compromettente, utilizzabile da tutti e in tutte le circostanze.
E voilà! Ecco pronto l’universo delle mode, dei tic e dei sentito-dire, degli stereotipi ripetuti senza capirne il senso, delle leggende metropolitane, dei titolo sensazionali che ispirano le agenzie di informazione (stampa e tv). La cultura-marmellata è l’erede di quel dizionario dello stupidario che compilò Flaubert nel suo capolavoro “Bouvard e Pecuchet”. Quando poi la melassa si fa eccessiva, ecco opporglisi l’urlatore rozzo e aggressivo. Ma, ovviamente, non si tratta di un’alternativa, ma dell’altra faccia del degrado. Entrambi, il ripetitore di luoghi comuni e il volgare trasgressore, impediscono che una cultura seria e rigorosa svolga il suo compito: produrre un progresso intellettuale di massa. Ma ciò è proprio quello che i demagoghi e gli arruffapopoli di ogni colore e di ogni tempo non vogliono che si realizzi.
Fiorenzo Baratelli è direttore dell’Istituto Gramsci di Ferrara

Sostieni periscopio!
Fiorenzo Baratelli
I commenti sono chiusi.